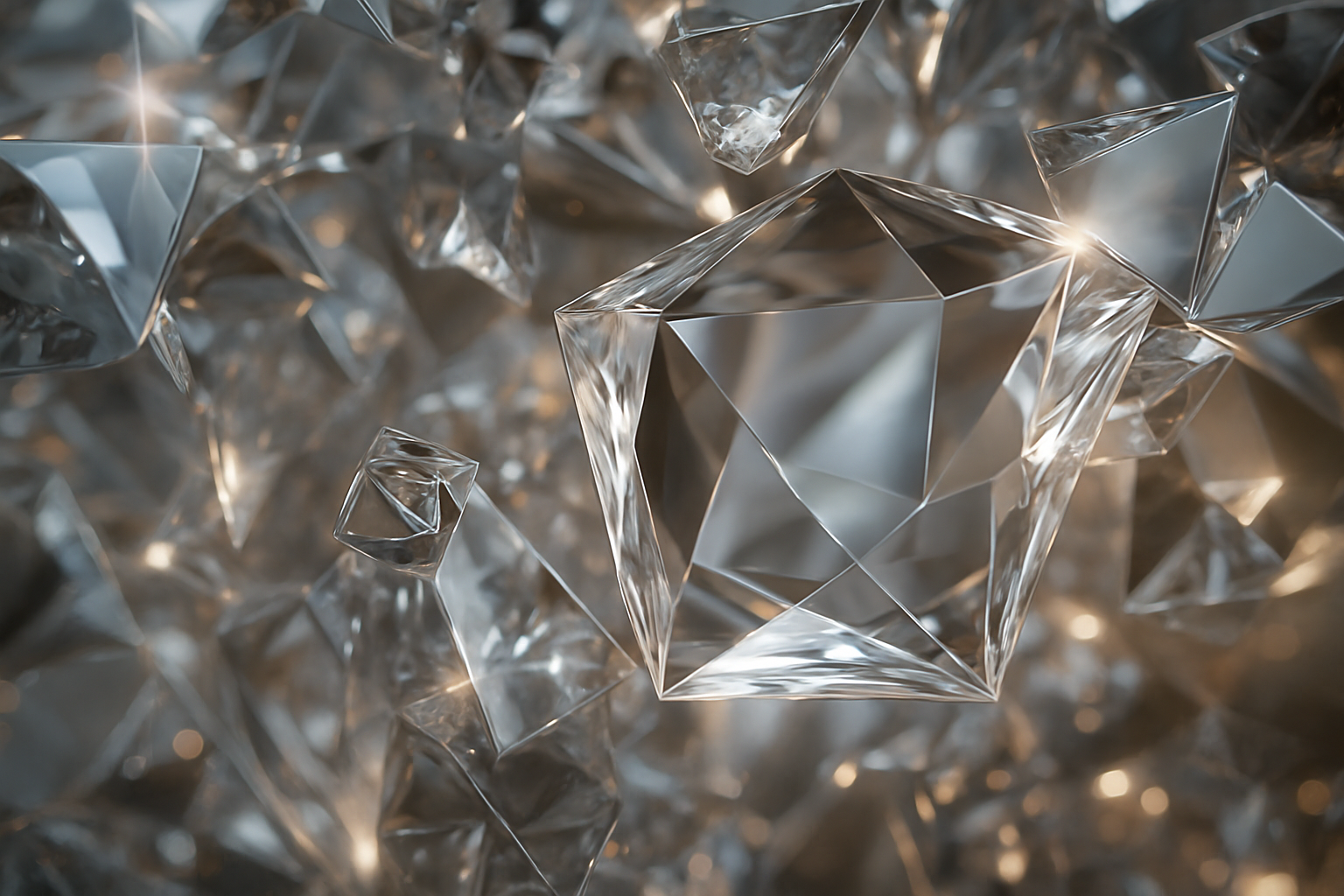Il corpo umano, per quanto allenato, incontra un limite invalicabile nel consumo energetico prolungato. Una ricerca pubblicata sulla rivista Current Biology il 20 ottobre ha dimostrato che anche gli atleti di endurance d'élite non possono superare in modo continuativo un "tetto metabolico" equivalente a circa 2,5 volte il loro metabolismo basale (BMR). Lo studio, guidato dall'antropologo Andrew Best del Massachusetts College of Liberal Arts, sfida l'idea che l'essere umano possa sostenere livelli energetici estremi per periodi estesi e fornisce nuove chiavi di lettura sui meccanismi fisiologici che regolano la spesa calorica durante sforzi prolungati.
Il metabolismo basale rappresenta la quantità minima di energia necessaria all'organismo a riposo per mantenere le funzioni vitali. Ricerche precedenti avevano suggerito che in brevi periodi di attività intensa fosse possibile raggiungere picchi fino a 10 volte superiori al BMR, ma la domanda cruciale riguardava la sostenibilità di tali livelli nel lungo termine. Per rispondere a questo interrogativo, Best e il suo team hanno monitorato 14 ultra-corridori, ciclisti e triatleti durante competizioni e periodi di allenamento, utilizzando una tecnica sofisticata basata su isotopi stabili.
I partecipanti hanno consumato acqua arricchita con deuterio e ossigeno-18, forme leggermente più pesanti di idrogeno e ossigeno. Analizzando la velocità con cui questi isotopi venivano eliminati attraverso l'urina, i ricercatori hanno potuto calcolare la quantità di anidride carbonica espirata e, di conseguenza, stimare con precisione il dispendio calorico totale. Questa metodologia, nota come "acqua doppiamente marcata", rappresenta lo standard aureo per misurare il metabolismo energetico in condizioni di vita reale, al di fuori del laboratorio.
Durante eventi di endurance che si protraevano per più giorni, diversi atleti hanno raggiunto temporaneamente livelli di consumo energetico da sei a sette volte superiori al loro BMR, corrispondenti a circa 7.000-8.000 calorie giornaliere. Tuttavia, quando i ricercatori hanno calcolato la media del dispendio calorico su intervalli molto più lunghi, rispettivamente di 30 e 52 settimane, il consumo energetico è costantemente rientrato intorno al valore di 2,4 volte il BMR. Questo schema rivela che superare il tetto metabolico per brevi periodi è fisiologicamente possibile, ma mantenerlo nel tempo porta inevitabilmente a conseguenze negative.
La spiegazione di questa limitazione risiede nei meccanismi di riequilibrio energetico che l'organismo attiva automaticamente. Durante gli sforzi estremi, il corpo umano redistribuisce l'energia disponibile, sottraendola inconsapevolmente ad altre funzioni. Come spiega Best, il cervello esercita un'influenza potente su quanto ci muoviamo spontaneamente, sulla nostra propensione all'irrequietezza fisica e persino sul desiderio di riposare. La sensazione di fatica che gli atleti sperimentano non è solo un segnale di affaticamento muscolare, ma rappresenta una strategia di conservazione energetica orchestrata dal sistema nervoso centrale.
Questa capacità di adattamento metabolico solleva interrogativi più ampi sulla fisiologia umana. Il tetto identificato non è solo una curiosità per chi pratica sport estremi, ma potrebbe avere implicazioni per comprendere come l'organismo gestisce le risorse energetiche in diverse situazioni, dalla gravidanza alle malattie che alterano il metabolismo. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che i risultati riflettono le caratteristiche specifiche del gruppo di atleti studiato: non si può escludere l'esistenza di individui eccezionali capaci di superare questo limite, anche se non sono stati inclusi nella ricerca.
Per la maggior parte delle persone, raggiungere questo tetto metabolico rimane comunque un obiettivo irraggiungibile e probabilmente indesiderabile. Come precisa Best, occorrerebbe correre in media circa 18 chilometri al giorno per un anno intero per raggiungere 2,5 volte il metabolismo basale. Per individui non professionisti, gli infortuni muscolo-scheletrici rappresenterebbero un ostacolo molto prima che entrino in gioco limitazioni energetiche di questa portata.
Lo studio, finanziato dalla Duke University e da un Faculty Incentive Award del Massachusetts College of Liberal Arts, apre nuove prospettive di ricerca sulla fisiologia dell'esercizio estremo. Rimangono da chiarire i meccanismi molecolari e ormonali che impongono questo limite superiore e come fattori individuali come genetica, età e stato di allenamento possano modularlo. Comprendere questi aspetti potrebbe rivelarsi cruciale non solo per ottimizzare le prestazioni atletiche, ma anche per sviluppare strategie terapeutiche in condizioni patologiche caratterizzate da alterazioni del metabolismo energetico.