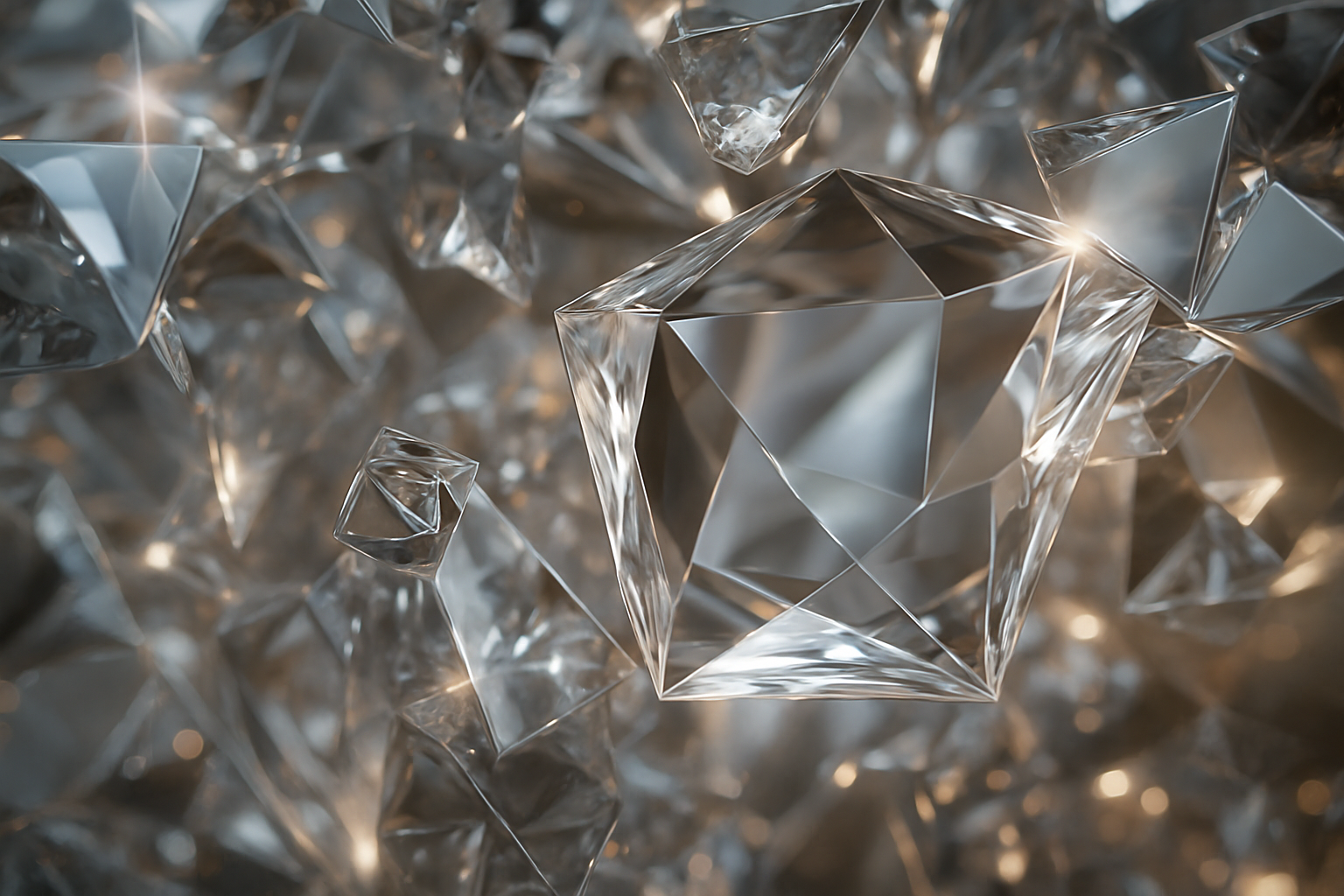La caccia ai mondi potenzialmente abitabili oltre il sistema solare ha appena registrato una scoperta che potrebbe rivelarsi cruciale per i prossimi decenni di ricerca astrobiolica. Un pianeta roccioso di massa quasi quadrupla rispetto alla Terra, denominato GJ 251 c, orbita nella zona abitabile di una stella situata a meno di 20 anni luce dal nostro pianeta, una distanza che in termini cosmici lo rende praticamente un vicino di casa. La vicinanza e le caratteristiche fisiche di questo mondo classificato come "super-Terra" lo rendono uno dei candidati più promettenti per la ricerca di biosignature atmosferiche, ossia tracce chimiche riconducibili a forme di vita.
La scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica The Astronomical Journal, è il frutto di oltre vent'anni di osservazioni coordinate a livello internazionale e rappresenta un esempio emblematico di come la moderna astronomia richieda non solo strumenti tecnologici all'avanguardia, ma anche sofisticate tecniche di analisi dei dati e collaborazioni multidisciplinari di lungo periodo. Il risultato è stato possibile grazie all'Habitable-Zone Planet Finder (HPF), uno spettrografo ad alta precisione operante nel vicino infrarosso, installato sul telescopio Hobby-Eberly dell'Osservatorio McDonald in Texas e progettato specificamente da ricercatori della Penn State University per individuare pianeti simili alla Terra attorno a stelle vicine.
La metodologia utilizzata si basa sull'analisi del "wobble" stellare, ovvero l'oscillazione gravitazionale che un pianeta in orbita induce sulla propria stella madre. Questo movimento si manifesta attraverso piccoli spostamenti Doppler nella luce stellare, variazioni spettrali estremamente sottili che richiedono strumentazione di precisione estrema per essere rilevate. Come spiega Suvrath Mahadevan, professore di astronomia alla Penn State e coautore dello studio, si tratta di un gioco difficile in termini di capacità di distinguere i segnali planetari dall'attività stellare, separando oscillazioni minime da quello che è essenzialmente un calderone fremente di magnetismo sulla superficie della stella.
Il sistema stellare GJ 251 era già noto agli astronomi per ospitare un pianeta interno, GJ 251 b, che completa un'orbita ogni 14 giorni terrestri. Combinando decenni di osservazioni pregresse con i nuovi dati ad alta precisione dell'HPF, il team ha identificato un segnale più intenso con periodicità di 54 giorni, indicativo della presenza di un secondo pianeta più massiccio. La conferma è arrivata dal spettrometro NEID, altro strumento costruito da ricercatori Penn State e operativo presso l'Osservatorio Nazionale di Kitt Peak in Arizona.
Una delle sfide principali nell'identificazione di esopianeti consiste nel distinguere il segnale planetario dal "rumore" generato dall'attività magnetica della stella ospite, fenomeno paragonabile a una forma di meteorologia stellare. Macchie stellari e altre caratteristiche superficiali possono simulare le variazioni periodiche prodotte da pianeti in orbita, creando falsi positivi. Per superare questo ostacolo, il team ha impiegato tecniche di modellazione avanzate che analizzano come i segnali si comportano attraverso diverse lunghezze d'onda della luce, permettendo di isolare con maggiore affidabilità la componente planetaria.
Corey Beard, primo autore della pubblicazione e ricercatore che ha condotto l'analisi durante il dottorato in astrofisica presso l'Università della California a Irvine, sottolinea come questo sistema rappresenti il limite tecnologico e metodologico attuale. Sebbene gli strumenti disponibili oggi non consentano di ottenere immagini dirette di GJ 251 c, la prossima generazione di telescopi terrestri con specchi di classe 30 metri sarà in grado di studiarne direttamente l'atmosfera, potenzialmente rilevando composti chimici associati alla presenza di vita biologica, come ossigeno molecolare, metano in condizioni di disequilibrio chimico o altri biosignature.
Eric Ford, professore di astronomia e astrofisica e direttore della ricerca presso l'Institute of Computational & Data Sciences della Penn State, evidenzia come questa scoperta dimostri la potenza della ricerca multidisciplinare. Mitigare il rumore dell'attività stellare ha richiesto non solo strumentazione all'avanguardia e accesso a telescopi di prim'ordine, ma anche la personalizzazione dei metodi di analisi statistica per le specifiche necessità di questa stella e della combinazione di strumenti utilizzati. La sinergia tra dati di qualità eccezionale e tecniche statistiche avanzate ha permesso di trasformare le osservazioni in una scoperta che apre la strada agli osservatori futuri nella ricerca di evidenze di vita oltre il Sistema Solare.
Il finanziamento della ricerca è stato garantito dalla National Science Foundation statunitense, dalla NASA e dalla Heising-Simons Foundation, testimoniando l'investimento continuo richiesto per progetti scientifici di questa portata. Mahadevan sottolinea come l'impegno sia rivolto costantemente al futuro: dalla formazione della prossima generazione di ricercatori capaci di condurre indagini all'avanguardia, alla progettazione e costruzione di nuove tecnologie per rilevare pianeti potenzialmente abitabili. La comunità scientifica si prepara ora all'era dei telescopi di classe 30 metri, che trasporteranno strumenti capaci di ottenere immagini dirette di pianeti rocciosi situati nelle zone abitabili delle loro stelle, aprendo prospettive senza precedenti nell'astrofisica planetaria e nell'astrobiologia.
Sebbene non sia ancora possibile confermare la presenza di un'atmosfera o di forme di vita su GJ 251 c, il pianeta costituisce un obiettivo privilegiato per l'esplorazione futura. La scoperta è significativa, ma rappresenta solo l'inizio di un percorso investigativo che potrebbe estendersi per i prossimi dieci o quindici anni, man mano che tecnologie sempre più sofisticate permetteranno di caratterizzare con precisione crescente le proprietà fisiche e chimiche di mondi distanti che potrebbero, per la prima volta nella storia umana, rivelare tracce inequivocabili di vita oltre la Terra.