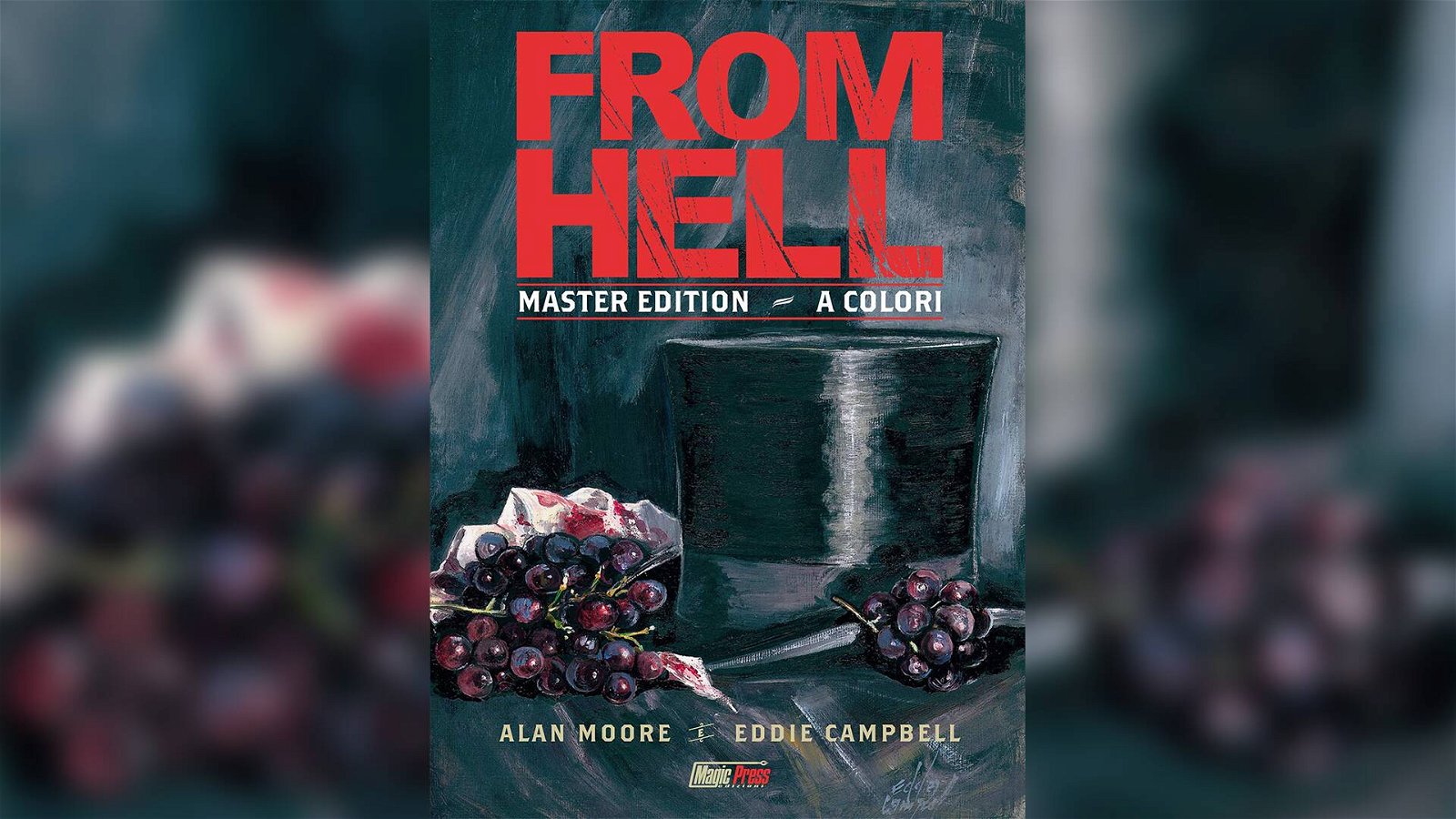Il 2021 è ormai alle porte e, complice anche l’avvento della nuova generazione di console, si preannuncia un anno scoppiettante e ricco di sorprese. Sono infatti tanti, tantissimi i titoli che meritano anche solo di essere menzionati, per un’annata che speriamo possa elevare ulteriormente i già impressionanti standard dell’industria videoludica.
La storia dei videogiochi, del resto, ci ha consegnato tantissimi capolavori capaci addirittura di trascendere il “semplice” medium riuscendo a divenire qualcosa di più: prodotti in grado di (ri)scrivere l’intrattenimento in quanto tale, svelandone nuove concezioni e cambiando radicalmente le carte in tavola. Alcune di queste opere sono ciò che sono proprio in quanto narrazioni pensate, nella loro completezza, per dare un inizio e una fine a una determinata storia.
Alcuni videogiochi, insomma, sono autoconclusivi e non necessitano perciò di sequel o di sviluppi di altro genere all’infuori dello stesso prodotto. Necessità mosse dal mercato, un’insistente richiesta del pubblico o il semplice desiderio di raccontare qualcosa in più, sono tra gli elementi che portano all’ampliamento di infrastruttura narrative già presenti. Spesso, in poche parole, si rende quasi obbligata un’operazione come lo sviluppo di un sequel per un’opera che, magari, non ne ha davvero bisogno. Quello che vogliamo fare oggi è parlare proprio di questo: vogliamo analizzare quando, come e perché talvolta la creazione di un sequel videoludico può non essere la scelta azzecata. Partiamo dal principio, soffermandoci su quelli che sono gli aspetti caratterizzanti di un’opera di successo.
Videogiochi e sequel: il troppo stroppia?
Che cosa rende un videogioco un’opera di successo? Non esiste un’unica risposta. Potremmo parlare di una narrazione sopra le righe, di una caratterizzazione dei personaggi particolarmente curata, o ancora di una colonna sonora indimenticabile o di un’ambientazione davvero coinvolgente. Gli aspetti da considerare sono insomma moltissimi, e un titolo si può considerare un vero capolavoro non quando in cui soddisfa tutti questi requisiti, ma nel momento in cui riesce a bilanciarli in termini di qualità e quantità.
Prendiamo ad esempio il primo capitolo di The Last of Us, capolavoro indiscusso con cui Naughty Dog ha dato vita a un universo narrativo dalla portata impressionante. Uscito nel 2013, il gioco racconta nei minimi dettagli un viaggio in un’America devastata da un virus che ha sconvolto il mondo come lo conosciamo: Joel e Ellie, i due protagonisti, potrebbero essere la chiave per riportare le cose come erano una volta.
Tenendo in considerazione tutte le componenti della storia, con particolare attenzione all’arco narrativo dei protagonisti, possiamo tranquillamente affermare come il tutto sia in sostanza autoconclusivo. Il primo capitolo non lascia infatti nulla in sospeso se non una serie di punti che, proprio per ragioni narrative, possono concedersi di restare inespresse. Quando Naughty Dog ha annunciato lo sviluppo di The Last of Us Part II, molti appassionati hanno infatti evidenziato qualche dubbio in proposito: alla luce di tutto ciò che è stato raccontato, era davvero necessario?
Uscito nel corso di quest’anno e in grado di collezionare una serie di premi e il plauso totale da parte della critica, il titolo ha suscitato sin da subito polemiche e visioni contrastanti a fronte di determinate scelte narrative che, nelle primissime ore di gioco, vanno a sconvolgere parte di quanto visto nell’acclamatissimo primo capitolo.
Sebbene i dubbi siano legittimi, va sottolineato quanto The Last of Us Part II riesca senza ombra di dubbio a raggiungere un intento fondamentale: colpire, e farlo in maniera radicata e indelebile. Il gioco insomma può essere etichettato come un capolavoro oppure no, questo sta alle opinioni del singolo utente, ma è indubbio quanto lo sconvolgimento raccontato sia parte di una narrazione ancor più profonda e calcata rispetto a quanto ammirato nel primo atto della storia. Si tratta dunque di un sequel necessario? Sì, o forse no: in questo caso la risposta è relativa, e dipende dalla singola esperienza del singolo giocatore.
Un altro esempio di rilievo, sempre targato Naughty Dog, è la saga di Uncharted. Con il primo capitolo uscito nell’ormai lontano 2007 - che nonostante non sia invecchiato troppo bene è e resta un caposaldo della storia del videogioco - si è dato il via a una serie di fatto indimenticabile. Ogni capitolo, in effetti, potrebbe anche essere autoconclusivo e non necessitare di ulteriori sviluppi. In questo caso espandere la narrazione - non comunque l’elemento cardine delle avventure di Nathan Drake - significa offrire al giocatore qualcosa di ancora di più, alzando ogni volta gli standard soprattutto lato gameplay.
Uncharted 4, ad esempio, offre a livello di trama tutta una serie di risvolti molto interessanti ma non essenziali nell’apprezzare la storia nel suo complesso. Ciò nonostante, si tratta senza dubbio di uno dei capolavori meglio riusciti della scorsa generazione e, forse, dell’intera storia dei videogiochi. I sequel non erano insomma necessari ma, come si suol dire, “s’avevano da fare”.
Videogiochi e sequel: quando dire basta
Abbiamo dunque visto come la produzione di un seguito, in determinati casi, può essere un’ottima idea anche se non strettamente necessaria. Uno sguardo attento a quella che è la storia dei videogiochi ci mostra tante, tantissime casistiche differenti, e nelle prossime righe andremo ad approfondirne tre ben distinte tra loro.
La prima trova riscontro in una saga che ha segnato la storia del genere survival horror, per poi andare incontro a una fine ingloriosa senza lasciare le tracce che forse avrebbe meritato. Stiamo parlando di Alone in the Dark, serie iniziata nel 1992 e capace di influenzare in maniera importante alcuni dei titoli più noti all’interno del filone horror: Resident Evil e Silent Hill, giusto per citarne un paio, devono molto alla serie targata Infogrames.
I primi quattro capitoli, tutti usciti nel corso degli anni Novanta, sono riusciti in qualche modo a scrivere pagine importanti nella storia del medium videoludico. Alone in the Dark: The New Nightmare (2001) mirava a portare avanti questa interessante produzione riuscendoci, a parer di molti, soltanto in parte. Si trattava in ogni caso di un prodotto in grado, al netto di qualche alto e basso, di offrire al giocatore un’esperienza più che soddisfacente. Nel 2008 la serie torna con un capitolo capace di raccogliere ottimi risultati in termini di vendita, prima della definitiva pietra tombale che ha inevitabilmente compromesso la storia del franchise. Alone in the Dark: Illumination, uscito nel 2015 e sviluppato da Pure FPS, è infatti annoverato non solo come uno dei sequel meno riusciti in campo videoludico, ma come uno dei giochi peggiori di sempre.
Le ragioni sono svariate e ben note agli appassionati: il concept della saga viene completamente stravolto, offrendo ai giocatori uno scooter in terza persona realizzato in maniera approssimativa e quantomai lacunosa. Illumination riuscì a mettere d’accordo pubblico e critica, convinti della definitiva conclusione di una delle saghe fondamentali nel dar vita al genere. Questa specifica casistica è la dimostrazione di come, delle volte, sia imperativo desistere dal dare seguito a un franchise se esso non ha più molto da dire o, in alternativa, se è evidente una mancanza di idee degne di essere raccontate. Il rischio, come avvenuto in questo frangente, è di rovinare quanto di bello costruito in anni e anni di lavoro. L’eredità di Alone in the Dark è oggi spesso relegata nel dimenticatoio: un vero peccato, considerando quanto le cose sarebbero potute andare molto diversamente.
Altra casistica è rappresentata da Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, uno dei prodotti senz’altro più discussi della scorsa generazione anche a causa di vicende esterne allo sviluppo del gioco. Tutti siamo infatti a conoscenza della rottura tra Konami e l’ideatore della serie Hideo Kojima, avvenuta quasi a sorpresa dopo un sodalizio durato più di due decenni. Un divorzio che ha avuto ripercussioni non da poco sull’intero sviluppo del gioco, con il prodotto finale ad apparire a tratti incompleto.
Non fraintendete: The Phantom Pain è a tutti gli effetti un’esperienza che non fatichiamo a definire mastodontica. Il punto è che, nelle condizioni in cui il progetto è stato portato avanti, forse sarebbe stato meglio soffermarsi di più sulla lavorazione o addirittura evitare di dare vita a un capitolo che ha lasciato molti appassionati con l’amaro in bocca. Invece di rispondere a molti degli interrogativi emersi negli altri titoli della saga, Metal Gear Solid V va a crearne di nuovi che, con tutta probabilità, non vedranno mai risposta.
Parlando di videogiochi e sequel l’ultima circostanza che andremo ad affrontare riguarda un’altra serie che non ha bisogno di presentazioni: Devil May Cry, il cui primo episodio risale ormai all’agosto 2001. Nato quasi involontariamente durante lo sviluppo di Resident Evil 4, il gioco fu un vero successo: un mix esplosivo di azione e frenesia, capace di offrire un livello di sfida davvero importante anche ai giocatori più esperti.
Forte del successo ottenuto dal gioco, Capcom decise di spingere per la pubblicazione di un sequel: due anni dopo esce Devil May Cry 2 che, come tutti sappiamo, non fu propriamente un titolo degno di nota. Un gameplay senza novità, personaggi poco ispirati e il pressoché totale azzeramento del precitato livello di sfida sono solo alcuni degli elementi che decretarono il fallimento del gioco.
Capcom fu oggetto di pesanti critiche da parte di pubblico e stampa specializzata: il secondo capitolo dell’avventura di Dante non solo non aveva raggiunto le aspettative, ma anzi aveva affossato tutto ciò che di buono si era visto con l’inizio della serie. Lo studio nipponico decise però di rispondere rialzandosi alla grande: nel 2005 arriva Devil May Cry 3, con cui la redenzione fu ultimata in ogni sua componente. Il gioco è infatti il perfetto esempio di come, a seguito di un passo falso anche molto importante, ci si possa impegnare per rimediare ai propri errori dando vita a qualcosa di stupefacente e in grado davvero di stupire.
Abbiamo dunque visto come mancanza di idee, condizioni di sviluppo non consone e una sostanziale assenza di motivazioni possono essere motivi per dire che no, un sequel non è una buona idea. D’altro canto è altresì vero che spesso una storia merita di essere raccontata, e se ciò implica una ramificazione narrativa che preveda più e più seguiti ben venga. Fino a quanto il prodotto finale sarà realmente ispirato e figlio di uno sviluppo volto al raggiungimento di determinati standard di qualità, un sequel è assolutamente non una buona, ma un’ottima idea.
La parola passa ora a voi giocatori: quali sono i sequel che più vi hanno deluso? E quali invece considerate indimenticabili?
Devil May Cry 5, un sequel fatto davvero come si deve, è disponibile su Amazon a un prezzo molto interessante.