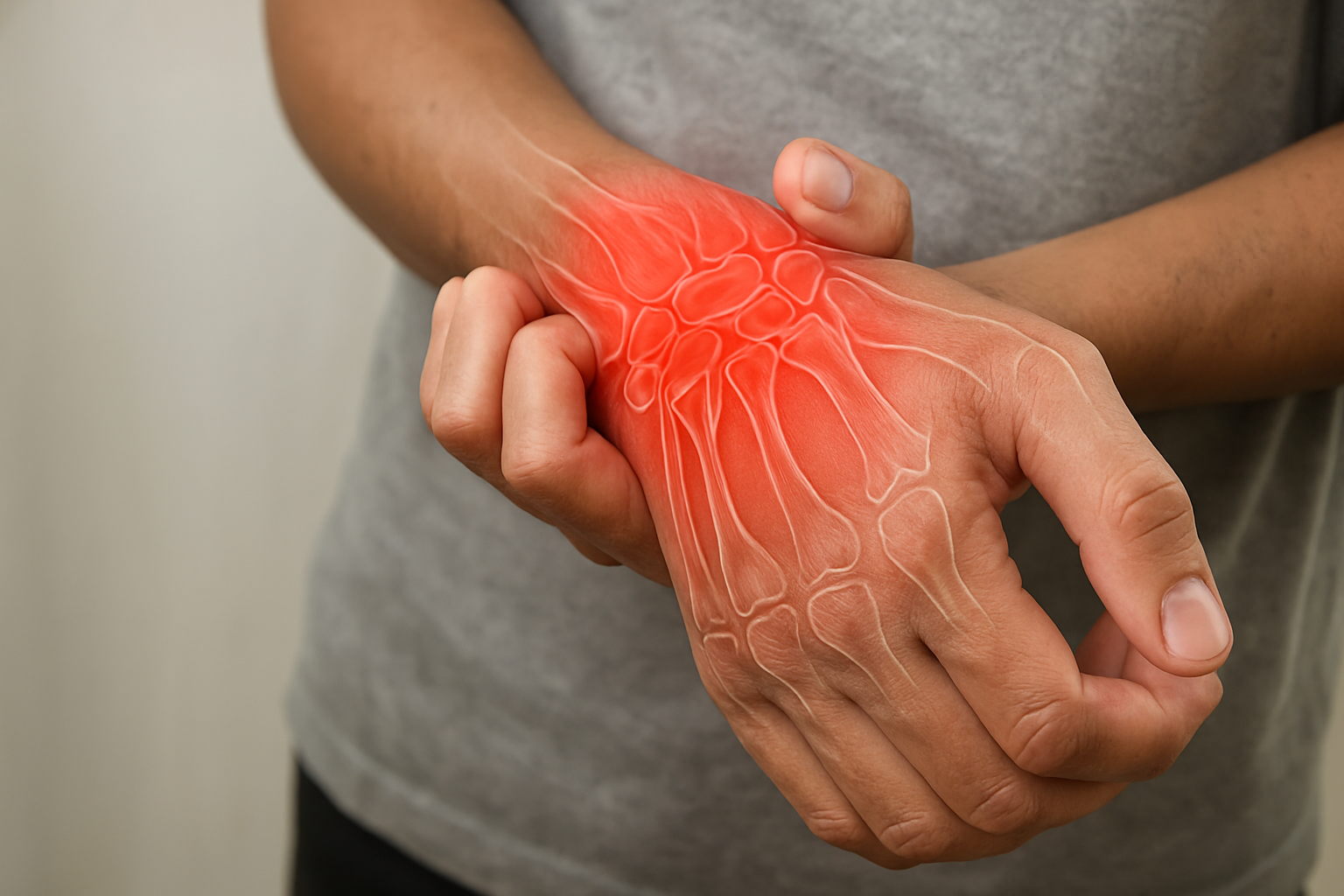La nascita e il declino delle città precolombiane del periodo classico Maya rappresentano uno dei grandi enigmi dell'archeologia mesoamericana. Per decenni, gli studiosi si sono interrogati su cosa spingesse comunità prevalentemente agricole, che traevano vantaggio dalla dispersione territoriale, a concentrarsi in densi centri urbani nonostante i costi elevati: maggiore esposizione alle malattie infettive, competizione per le risorse, crescente disuguaglianza sociale. Oggi, una ricerca pubblicata sui Proceedings of the National Academy of Sciences fornisce una risposta sorprendente, applicando modelli di ecologia delle popolazioni a dati archeologici, climatici e demografici raccolti nell'arco di oltre un decennio.
Il team guidato da Douglas Kennett, archeologo dell'Università della California a Santa Barbara, ha identificato una complessa interazione tra tre fattori chiave che determinarono l'urbanizzazione nelle Lowlands Maya del periodo Classico. Il primo elemento consiste nei periodi di deterioramento climatico, con particolare riferimento a fasi di siccità prolungata. Il secondo fattore riguarda l'intensificazione dei conflitti tra gruppi, che rendeva più sicura la concentrazione in insediamenti fortificati. Il terzo, e forse più rilevante, è rappresentato dalle economie di scala generate dagli investimenti in infrastrutture agricole, che permettevano di sostenere popolazioni più dense attraverso sistemi complessi di irrigazione, terrazzamenti e gestione delle risorse idriche.
La metodologia adottata dai ricercatori integra diverse linee di evidenza scientifica. Dal 2012, il gruppo ha sistematicamente compilato dati archeologici relativi a dinamiche demografiche, tracce di conflitti armati e testimonianze di sistemi agricoli intensivi nelle città Maya. L'elemento innovativo è stata la disponibilità di record climatici ad alta risoluzione ricavati da carote sedimentarie e altri indicatori paleoclimatici, combinati con sofisticati modelli computazionali che consentono di analizzare le relazioni tra variabili ambientali, sociali ed economiche con una precisione senza precedenti.
Il risultato più inatteso della ricerca riguarda proprio le dinamiche di deurbanizzazione. Contrariamente a quanto ipotizzato per anni, l'esodo dalle città Maya non coincise con il peggioramento delle condizioni climatiche, ma si verificò paradossalmente durante fasi di amelioramento ambientale. "La scoperta più sorprendente è stata che l'abbandono delle città avvenne in condizioni climatiche in miglioramento", spiega Kennett. "Abbiamo a lungo pensato che il declino delle città Maya classiche fosse parzialmente causato da un periodo esteso di siccità. Si rivela essere una storia molto più complicata e interessante."
La spiegazione proposta dai ricercatori si basa sul concetto di analisi costi-benefici applicata su scala temporale estesa. Durante le fasi di stress climatico e conflitti intensi, i vantaggi della vita urbana – sicurezza, accesso a infrastrutture produttive, reti di scambio – superavano i costi elevati. Tuttavia, quando il clima migliorava e la pressione dei conflitti diminuiva, il bilancio si invertiva. La degradazione ambientale nelle aree periurbane, causata da secoli di sfruttamento intensivo, rendeva insostenibile la vita nelle città, mentre le zone rurali tornavano attrattive offrendo maggiore autonomia, libertà decisionale e accesso a terre non esaurite.
Il modello elaborato dal team riconcilia teorie precedentemente considerate in competizione tra loro – pressioni ambientali, conflitti, dinamiche economiche – all'interno di un framework unico basato sull'ecologia delle popolazioni. Questo approccio permette di comprendere perché società agrarie, che normalmente beneficiano dalla dispersione territoriale per ridurre i tempi di spostamento verso i campi, decidessero di concentrarsi in città nonostante i significativi svantaggi finanziari e sanitari. La chiave risiede nell'evoluzione congiunta di urbanesimo, disuguaglianza sistemica e relazioni patron-cliente, processi interconnessi che si rinforzavano reciprocamente.
Le implicazioni di questa ricerca vanno ben oltre la comprensione delle civiltà precolombiane. Identificando i principi generali che influenzano la concentrazione e la dispersione delle popolazioni, lo studio offre strumenti interpretativi applicabili all'evoluzione urbana in diverse epoche e contesti geografici. Nel momento in cui le moderne metropoli affrontano sfide legate a pressioni economiche, congestione, inquinamento e, più recentemente, eventi sanitari di portata globale, comprendere le dinamiche profonde che storicamente hanno regolato i flussi migratori urbani acquisisce una rilevanza particolare per le politiche territoriali contemporanee e future.