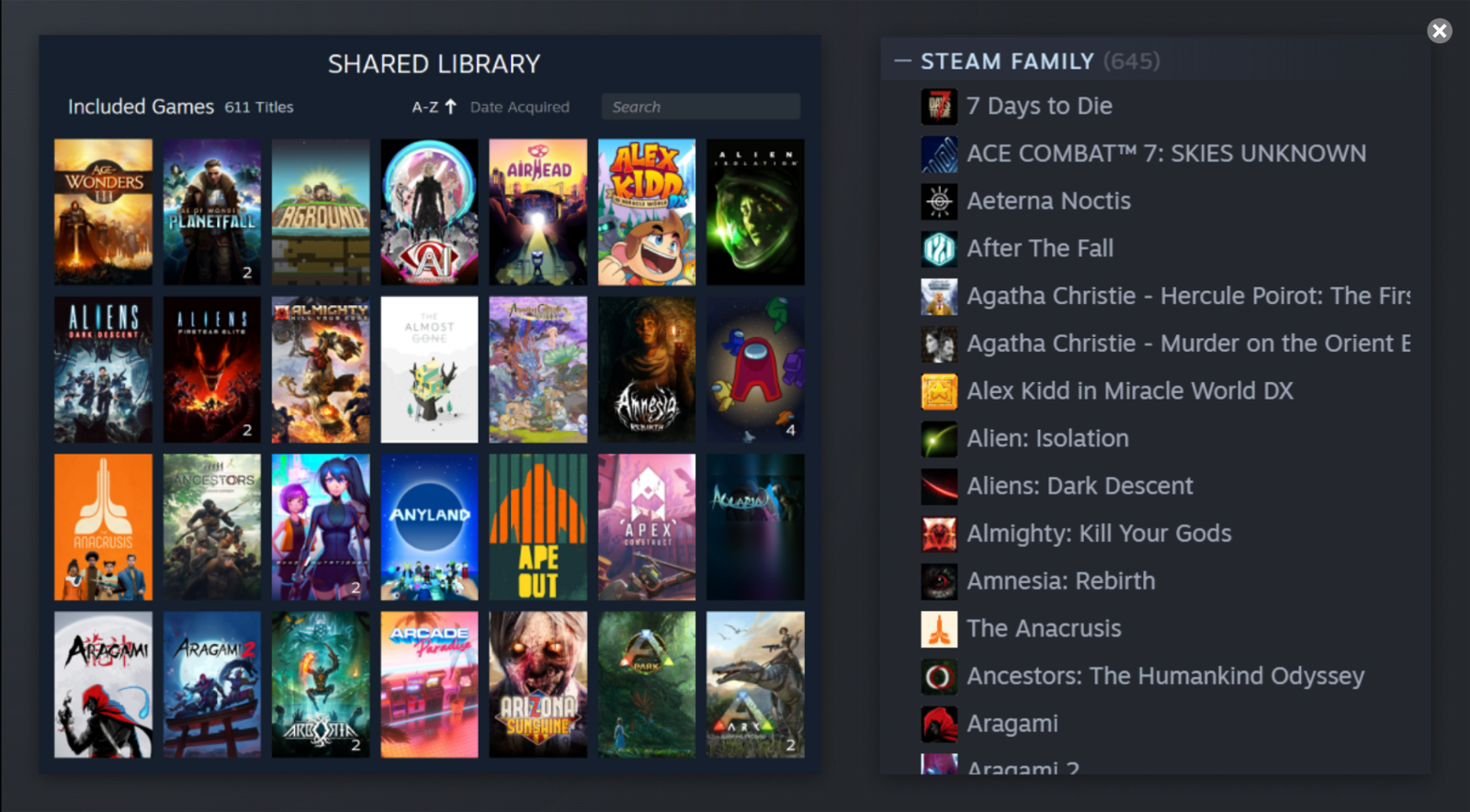La trasformazione radicale delle diete globali rappresenta una delle sfide più urgenti per la salute pubblica del XXI secolo. Un'imponente analisi scientifica pubblicata su The Lancet, frutto del lavoro di 43 esperti internazionali distribuiti su tre articoli correlati, documenta come gli alimenti ultra-processati (UPF, dall'inglese Ultra-Processed Foods) stiano sistematicamente soppiantando i cibi freschi e minimamente lavorati in ogni continente, alimentando l'epidemia globale di malattie croniche. La ricerca, finanziata da Bloomberg Philanthropies, non si limita a quantificare il fenomeno ma individua nei meccanismi industriali e nelle strategie politiche delle multinazionali alimentari le cause strutturali di questa transizione nutrizionale, proponendo un piano d'azione coordinato sul modello delle campagne internazionali contro l'industria del tabacco.
I dati raccolti dalle indagini nazionali rivelano una progressione allarmante. In Spagna, la quota di energia alimentare derivante da UPF è triplicata negli ultimi tre decenni, passando dall'11% al 32%. La Cina ha registrato un incremento dal 4% al 10% nello stesso periodo. Messico e Brasile hanno visto raddoppiare questa percentuale (dal 10% al 23%) negli ultimi quarant'anni. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, i livelli superano stabilmente il 50% da vent'anni, con tendenza all'ulteriore crescita. Questi prodotti industriali sono definiti dalla classificazione Nova, sviluppata nel 2009 dal professor Carlos Monteiro dell'Università di San Paolo, come formulazioni create a partire da ingredienti a basso costo quali oli idrogenati, isolati proteici e sciroppi di glucosio-fruttosio, arricchiti con additivi cosmetici come coloranti, dolcificanti artificiali ed emulsionanti.
La metodologia dell'analisi ha incluso una revisione sistematica di 104 studi osservazionali a lungo termine, di cui 92 hanno riscontrato associazioni positive tra consumo elevato di UPF e almeno una patologia cronica. Le meta-analisi hanno identificato correlazioni significative con 12 condizioni diverse: obesità, diabete di tipo 2, patologie cardiovascolari, depressione e mortalità prematura figurano tra le più rilevanti. I meccanismi patogenetici individuati comprendono il consumo eccessivo favorito dalla palatabilità artificiale, lo squilibrio nutrizionale (eccesso di zuccheri e grassi saturi, carenza di fibre e proteine di qualità) e l'esposizione prolungata a sostanze additive potenzialmente dannose. Il professor Mathilde Touvier dell'Istituto nazionale francese per la salute e la ricerca medica (Inserm) sottolinea che, nonostante il dibattito scientifico sulla classificazione Nova richieda ulteriori trial randomizzati e chiarimenti sui meccanismi d'azione, il corpus di evidenze disponibile giustifica l'immediata implementazione di politiche di salute pubblica, distinguendo la discussione scientifica legittima dai tentativi di delegittimazione orchestrati da interessi commerciali.
Il secondo articolo della Serie delinea un pacchetto di interventi normativi progettati per rafforzare le legislazioni esistenti contro gli alimenti ad alto contenuto di grassi, sale e zuccheri (HFSS). Le raccomandazioni includono l'inserimento di marcatori specifici degli UPF (coloranti, aromi, dolcificanti) nelle etichette frontali, accanto ai contenuti eccessivi di nutrienti critici, per prevenire sostituzioni cosmetiche che mantengano invariata la natura ultra-processata del prodotto. Il professor Barry Popkin dell'Università della Carolina del Nord evidenzia come questa strategia consentirebbe regolamentazioni più efficaci. Altre misure proposte comprendono restrizioni al marketing, specialmente quello rivolto ai minori e quello digitale, il divieto di vendita in strutture pubbliche come scuole e ospedali, e la limitazione dello spazio espositivo nei supermercati. Il programma nazionale brasiliano di alimentazione scolastica costituisce un esempio virtuoso: ha già eliminato la maggior parte degli UPF e prevede che entro il 2026 il 90% dei pasti scolastici provenga da alimenti freschi o minimamente processati.
L'analisi economica contenuta nel terzo articolo svela le dinamiche strutturali che sostengono l'espansione degli UPF. Le multinazionali alimentari sfruttano economie di scala, ingredienti a basso costo e strategie di marketing sofisticate per massimizzare i profitti, che vengono poi reinvestiti nell'ampliamento della produzione e nell'acquisizione di influenza politica. Gli autori documentano un arsenale di tattiche utilizzate per proteggere gli interessi corporativi: blocco di regolamentazioni sfavorevoli, manipolazione del dibattito scientifico, finanziamento di centinaia di gruppi d'interesse, lobbying intensivo, contributi a campagne elettorali e contenziosi legali per ritardare l'implementazione di norme. Il professor Simon Barquera dell'Istituto nazionale di salute pubblica del Messico sottolinea che sono le corporazioni globali, non le scelte individuali, a guidare l'ascesa degli alimenti ultra-processati, spesso presentandosi pubblicamente come parte della soluzione mentre le loro azioni prioritizzano sistematicamente la redditività rispetto alla salute pubblica.
La dimensione sociale dell'accessibilità alimentare emerge come elemento critico nelle raccomandazioni. Il professor associato Gyorgy Scrinis dell'Università di Melbourne evidenzia che le politiche restrittive devono accompagnarsi a interventi che rendano gli alimenti freschi economicamente accessibili e praticamente utilizzabili non solo per chi dispone di tempo per cucinare, ma anche per famiglie impegnate e individui che dipendono da soluzioni convenienti. Gli autori propongono l'implementazione di tassazioni mirate su categorie selezionate di UPF, destinando i proventi a sussidi per alimenti nutrienti, particolarmente per le fasce a basso reddito, secondo un modello di redistribuzione fiscale finalizzato alla salute pubblica.
La professoressa Camila Corvalan dell'Università del Cile e il professor Carlos Monteiro convergono nell'identificare l'ostacolo principale: l'influenza politica delle corporazioni rappresenta la barriera più significativa a riforme efficaci. Gli autori invocano un movimento globale di salute pubblica capace di proteggere gli spazi decisionali dall'interferenza industriale, interrompere i legami tra industria e organizzazioni sanitarie, e consolidare reti di advocacy per la riduzione del consumo di UPF. Il dottor Phillip Baker dell'Università di Sydney richiama esplicitamente il precedente storico della lotta contro l'industria del tabacco, auspicando una risposta coordinata che contrasti il potere corporativo attraverso coalizioni potenti orientate a sistemi alimentari equi, salutari e sostenibili.
Le prospettive future delineate dalla Serie richiedono una visione trasformativa dei sistemi alimentari globali, che valorizzi i produttori locali, preservi le tradizioni culinarie culturali, promuova l'equità di genere e garantisca che i benefici economici rimangano nelle comunità anziché confluire verso azionisti distanti. Gli autori riconoscono che la transizione necessiterà di ricerche ulteriori su sottogruppi di prodotti con profili nutrizionali differenti, meccanismi patogenetici più dettagliati e trial clinici randomizzati a lungo termine, ma ribadiscono che attendere risultati definitivi consentirebbe agli UPF di consolidare ulteriormente la loro presenza nelle diete globali.