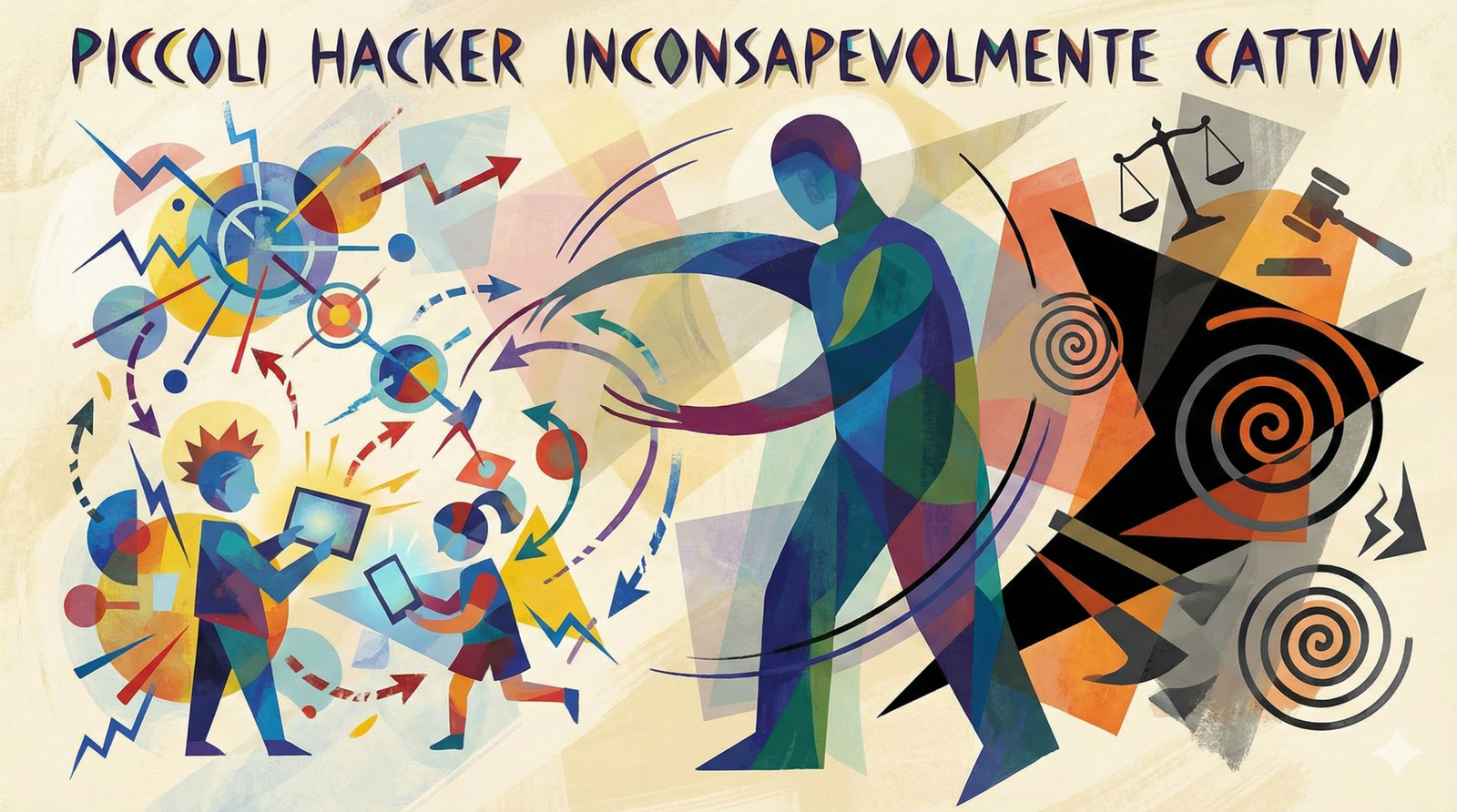La fisica quantistica potrebbe presto rivoluzionare il modo in cui studiamo gli oggetti celesti più sfuggenti dell'universo, quelli troppo piccoli o distanti per essere osservati direttamente dai nostri telescopi. Un team di ricercatori dell'Università del Maryland, guidato da Zhenning Liu, ha sviluppato un protocollo innovativo che sfrutta le proprietà quantistiche della luce per misurare la massa di corpi cosmici che causano fenomeni di microlensing gravitazionale, un effetto finora difficilissimo da analizzare nel dettaglio.
Il principio alla base è affascinante quanto complesso. Quando la luce proveniente da una stella attraversa lo spazio, può incontrare lungo il suo cammino oggetti massicci come pianeti o buchi neri che ne curvano la traiettoria, creando immagini distorte come se fosse presente una lente aggiuntiva. Questi fenomeni sono relativamente facili da osservare quando gli oggetti interposti sono giganteschi, ma diventano estremamente problematici quando si tratta di corpi più piccoli come buchi neri isolati o pianeti vagabondi che fluttuano nello spazio senza orbitare attorno a una stella.
I metodi tradizionali di osservazione astronomica riescono a rilevare quando si verifica un evento di microlensing perché la luminosità della fonte aumenta temporaneamente. Questo permette agli scienziati di dedurre che esiste un oggetto interposto tra noi e la sorgente luminosa, ma non fornisce abbastanza informazioni per calcolarne la massa con precisione. Liu spiega che gli strumenti convenzionali richiederebbero la raccolta di enormi quantità di luce, cosa che implica la costruzione di telescopi sempre più grandi e costosi.
La soluzione proposta dal team si basa su una considerazione fondamentale: la luce è composta da fotoni, particelle che seguono le leggi della meccanica quantistica. Quando un fotone ha la possibilità di percorrere due tragitti diversi attorno a un oggetto, ciascuno dei quali richiede tempi di percorrenza differenti, questa differenza temporale modifica le proprietà quantistiche del fotone stesso. Poiché le particelle quantistiche possono comportarsi come onde, i fotoni possono effettivamente viaggiare simultaneamente lungo entrambi i percorsi, analogamente a un'onda d'acqua che incontra uno scoglio.
Il protocollo sviluppato dai ricercatori eccelle nell'estrarre proprio questa differenza temporale tra i due percorsi possibili, che può poi essere tradotta nella massa dell'oggetto interposto. L'analisi matematica condotta dal team ha dimostrato che il sistema funzionerebbe particolarmente bene per studiare stelle nel rigonfiamento galattico, quella regione centrale della Via Lattea dove in passato sono già stati scoperti oggetti oscuri attraverso studi sul lensing gravitazionale, seppur con metodi meno raffinati.
Un aspetto cruciale che rende questa ricerca particolarmente promettente riguarda la sua fattibilità pratica. A differenza di molte applicazioni quantistiche che richiedono computer quantistici completamente funzionanti, questo protocollo potrebbe essere implementato con dispositivi più standard che catturano e analizzano un fotone alla volta, combinati con computer convenzionali. Secondo Liu, questo significa che potrebbe essere testato nella pratica entro pochi anni, un orizzonte temporale decisamente ravvicinato per tecnologie di questo tipo.
Daniel Oi dell'Università di Strathclyde nel Regno Unito sottolinea come l'approccio quantistico offra un miglioramento esponenziale nella capacità di estrarre informazioni sul ritardo temporale dalla luce, un vantaggio che paragona al santo graal delle tecnologie quantistiche. Si evidenzia inoltre come le tecnologie quantistiche siano naturalmente adatte per segnali astronomici deboli costituiti da piccoli numeri di fotoni, proprio perché la teoria quantistica è all'origine di molti dei limiti fondamentali sulla precisione con cui qualcosa può essere misurato in fisica.
Il metodo richiede un numero relativamente ridotto di fotoni per funzionare efficacemente, superando così uno dei principali ostacoli dell'astronomia moderna: la necessità di raccogliere immense quantità di luce per ottenere dati significativi. Questa caratteristica potrebbe aprire nuove possibilità per l'identificazione e lo studio di oggetti cosmici finora rimasti nell'ombra, letteralmente invisibili ai nostri strumenti più potenti, consentendo agli astronomi di mappare con maggiore precisione la distribuzione della materia oscura nell'universo e scoprire popolazioni di oggetti celesti la cui esistenza oggi possiamo solo ipotizzare.