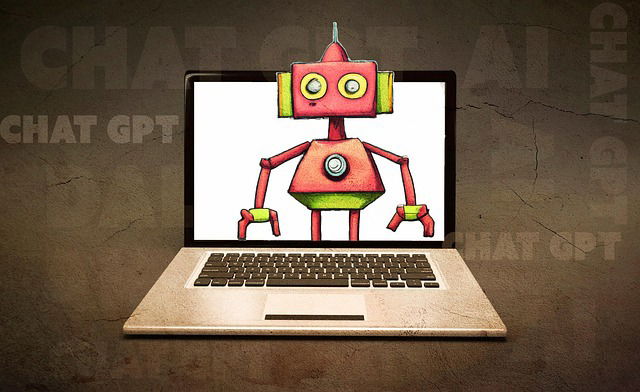Nel cuore delle Isole Canarie, un piccolo ragno endemico sta riscrivendo le regole dell'evoluzione genomica. La Dysdera tilosensis, una specie che vive esclusivamente su Gran Canaria, ha compiuto qualcosa che gli scienziati consideravano estremamente raro: nell'arco di alcuni milioni di anni ha ridotto le dimensioni del proprio genoma quasi della metà, mantenendo però una diversità genetica superiore rispetto ai suoi parenti continentali.
La scoperta, pubblicata sulla rivista Molecular Biology and Evolution, rappresenta il primo caso documentato in cui una specie animale ha ridotto il proprio genoma di circa il 50% durante il processo di colonizzazione di isole oceaniche. Il team di ricerca guidato da Julio Rozas e Sara Guirao della Facoltà di Biologia e dell'Istituto di Ricerca sulla Biodiversità dell'Università di Barcellona ha utilizzato tecnologie avanzate di sequenziamento del DNA per confrontare due specie strettamente imparentate.
L'analisi comparativa ha messo a confronto la Dysdera catalonica, che popola alcune aree della Catalogna e della Francia meridionale, con la sua cugina insulare D. tilosensis. I risultati sono stati sorprendenti: mentre la specie continentale possiede un genoma di 3,3 miliardi di coppie di basi, quello della specie canaria ammonta a soli 1,7 miliardi. Come spiega il professor Rozas, direttore del gruppo di ricerca in Genomica Evolutiva e Bioinformatica, nonostante il genoma più compatto, la specie delle Canarie mostra una diversità genetica maggiore.
Le Isole Canarie sono da tempo considerate un laboratorio naturale per lo studio dell'evoluzione in isolamento, e il genere Dysdera ne è un esempio emblematico. Circa 50 specie endemiche di questi ragni, che rappresentano il 14% di tutte le specie conosciute del genere, si sono evolute nell'arcipelago da quando le isole sono emerse alcuni milioni di anni fa. Questa straordinaria diversificazione offre agli scienziati un'opportunità unica per osservare i processi evolutivi in azione.
Tradizionalmente, la comunità scientifica riteneva che le specie che colonizzano le isole tendessero a sviluppare genomi più grandi e ricchi di DNA ripetitivo. Questa nuova ricerca ribalta completamente tale assunto, alimentando il dibattito su uno dei misteri centrali della biologia: come e perché le dimensioni del genoma cambino durante l'evoluzione. Il sequenziamento genomico ha inoltre rivelato differenze strutturali significative: D. catalonica presenta quattro autosomi più un cromosoma X, mentre D. tilosensis ne ha sei più un cromosoma X.
Vadim Pisarenco, dottorando presso l'Università di Barcellona e primo autore dello studio condotto in collaborazione con l'Università di La Laguna, il Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo e l'Università di Neuchâtel in Svizzera, sottolinea l'eccezionalità del fenomeno. Si tratta di uno dei primi casi documentati di drastica riduzione genomica utilizzando genomi di riferimento di alta qualità, e viene descritto per la prima volta in dettaglio per specie animali filogeneticamente così vicine.
La professoressa Sara Guirao evidenzia come, in specie evolutivamente simili che condividono habitat e dieta comparabili, le differenze nelle dimensioni del genoma non possano essere facilmente attribuite a fattori ecologici o comportamentali. L'analisi filogenetica combinata con misurazioni di citometria a flusso rivela che l'antenato comune possedeva un genoma grande, di circa 3 miliardi di basi. Questo indica che la riduzione genomica drastica si è verificata durante o dopo l'arrivo sulle isole.
Il risultato appare paradossale sotto due aspetti fondamentali. Sebbene meno frequente negli animali, il modello più comune è l'aumento delle dimensioni del genoma attraverso duplicazioni dell'intero patrimonio genetico, fenomeno particolarmente diffuso nelle piante dove la comparsa di specie poliploidi è comune. Al contrario, riduzioni così marcate delle dimensioni genomiche in un periodo di tempo relativamente breve sono molto più rare, come precisa Guirao.
In secondo luogo, i risultati contraddicono le teorie secondo cui, sulle isole, l'effetto fondatore – il processo di colonizzazione da parte di un numero ridotto di individui – porterebbe a una diminuzione della pressione selettiva e, di conseguenza, a genomi più grandi e ricchi di elementi ripetitivi. Pisarenco osserva invece il fenomeno opposto: le specie insulari possiedono genomi più piccoli e compatti con maggiore diversità genetica. Questo schema suggerisce la presenza di meccanismi non adattativi, per cui le popolazioni nelle Canarie sarebbero rimaste relativamente numerose e stabili per lungo tempo, permettendo di mantenere una forte pressione selettiva e, di conseguenza, di eliminare il DNA non necessario.
Rimane ancora da chiarire perché alcune specie accumulino grandi quantità di DNA ripetitivo mentre altre evolvano genomi snelli e compatti. Alcuni scienziati propongono che i cambiamenti nelle dimensioni del genoma riflettano un adattamento diretto all'ambiente, mentre altri sostengono che tali cambiamenti risultino da un equilibrio tra l'accumulo di elementi ripetitivi, come i trasposoni, e la loro rimozione attraverso la selezione naturale. I ricercatori concludono che questo studio supporta l'idea secondo cui, più che un adattamento diretto, le dimensioni del genoma in queste specie dipendano principalmente da un equilibrio dinamico tra accumulo e rimozione del DNA ripetitivo, gettando nuova luce su uno degli enigmi più duraturi della biologia evolutiva.