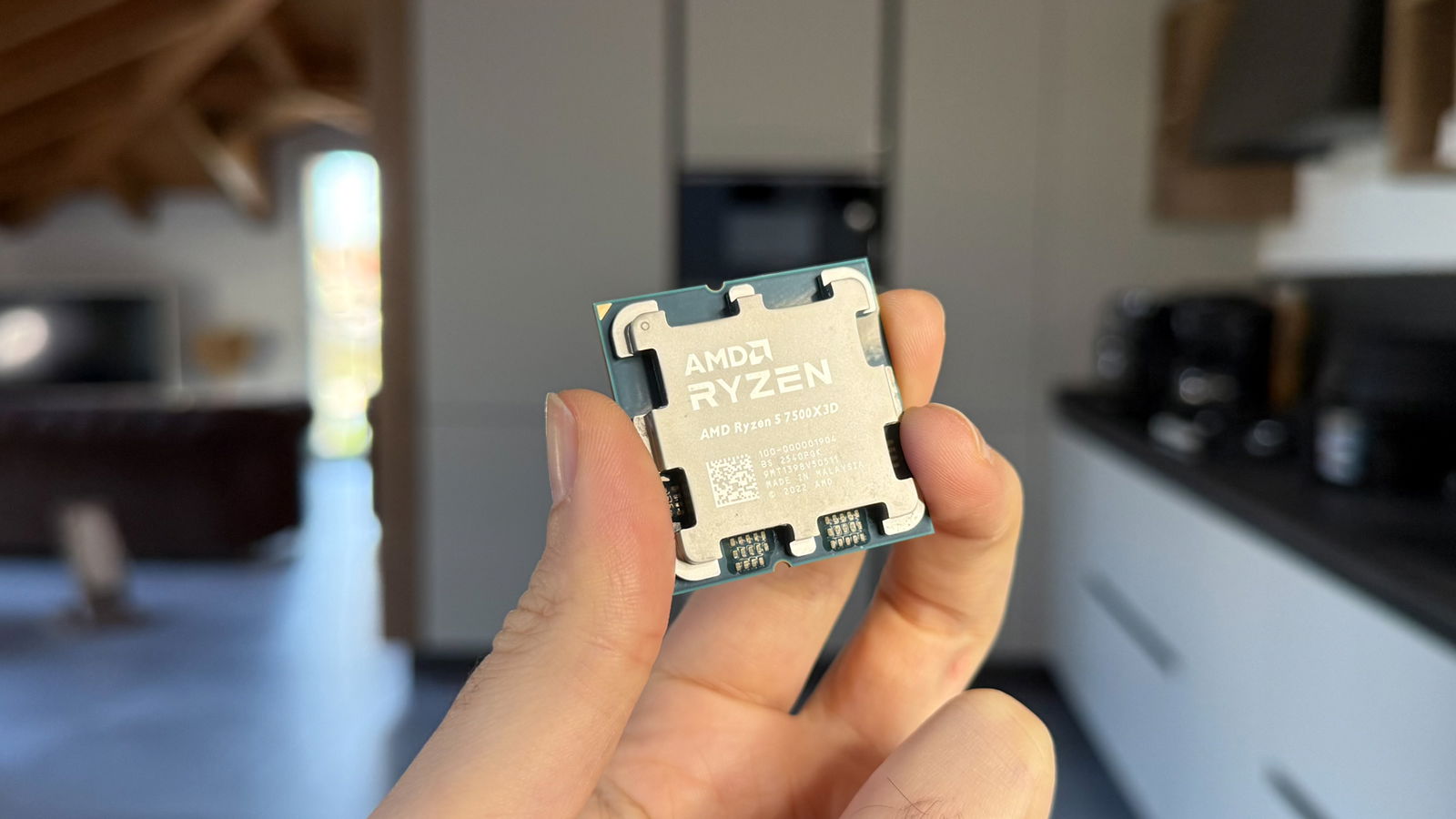La scoperta di una collisione tra buchi neri di dimensioni straordinarie sta rivoluzionando la comprensione scientifica di come questi enigmatici oggetti cosmici si sviluppano nell'universo. L'evento, rilevato nel novembre 2023 e denominato GW231123, rappresenta la fusione più massiccia mai osservata attraverso le onde gravitazionali, coinvolgendo due buchi neri con masse rispettivamente di circa 100 e 140 volte quella del Sole. Il risultato finale è un buco nero di 225 masse solari, circa il 50% più massiccio del precedente record, che sfida le attuali teorie sulla formazione di questi corpi celesti.
Masse "proibite" che riscrivono la fisica stellare
L'aspetto più sorprendente di questa scoperta risiede nel fatto che i due buchi neri coinvolti presentano masse che la teoria considera praticamente impossibili. Secondo i modelli attuali, i buchi neri con masse comprese tra 60 e 130 volte quella del Sole non dovrebbero esistere, poiché le stelle di tale dimensione dovrebbero essere completamente distrutte durante il processo di supernova anziché collassare in buchi neri. "Stiamo osservando questi buchi neri ad alta massa proibita", spiega Priyamvada Natarajan, astrofisica teorica dell'Università di Yale, evidenziando come questa scoperta metta in discussione le conoscenze consolidate.
La spiegazione più plausibile suggerisce che questi oggetti non si siano formati attraverso il meccanismo standard del collasso stellare, ma piuttosto attraverso fusioni gerarchiche di corpi massicci precedenti. Mark Hannam, fisico dell'Università di Cardiff e membro della collaborazione LVK, descrive il processo come una cascata di eventi che hanno portato alla collisione finale, stimata essere avvenuta tra 2,3 e 13,4 miliardi di anni luce dalla Terra.
Una rotazione al limite della fisica
I modelli elaborati dagli scienziati rivelano un altro aspetto stupefacente: i buchi neri ruotavano a una velocità straordinaria di circa 40 giri al secondo, avvicinandosi al limite teorico previsto dalla relatività generale di Einstein per mantenere la stabilità. Alan Weinstein del California Institute of Technology, anch'egli parte della collaborazione LVK, sottolinea come questa rotazione sia "molto vicina al massimo consentito", fornendo indizi preziosi sui meccanismi di crescita dei buchi neri nell'universo.
La rilevazione è stata possibile grazie al Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), che utilizza laser sparati lungo bracci a forma di L per rilevare minuscole variazioni nella lunghezza causate dal passaggio delle onde gravitazionali attraverso il pianeta. Queste increspature nello spazio-tempo vengono generate quando corpi massicci accelerano, come nel caso di buchi neri o stelle di neutroni in spirale che si fondono.
Il mistero dei buchi neri di massa intermedia
La scoperta assume particolare rilevanza nel contesto di una delle questioni più dibattute in astronomia: come abbiano fatto i buchi neri supermassicci, presenti nei centri delle galassie come la Via Lattea, a crescere così rapidamente nell'universo primordiale. Mentre esistono ampie evidenze per i buchi neri di massa stellare e per quelli supermassicci con oltre un milione di masse solari, i buchi neri di massa intermedia nella fascia tra 100 e 100.000 masse solari sono stati finora estremamente difficili da individuare.
Questa osservazione, presentata al meeting GR-Amaldi sulle onde gravitazionali a Glasgow il 14 luglio, arriva in un momento particolare per la ricerca statunitense nel campo, che deve affrontare tagli significativi ai finanziamenti per la rilevazione delle onde gravitazionali. Dal primo rilevamento di LIGO nel 2015, sono state osservate centinaia di fusioni attraverso le onde gravitazionali, ma GW231123 rappresenta un salto quantico nella comprensione di questi fenomeni cosmici.
L'entusiasmo della comunità scientifica è palpabile, con ricercatori che definiscono la scoperta "super eccitante" per le sue implicazioni sulla comprensione di come i buchi neri crescano e si evolvano nell'universo. La collaborazione LVK, che comprende oltre a LIGO anche i rilevatori Virgo in Italia e KAGRA in Giappone, continua a espandere la rete di osservazione globale per catturare questi eventi cosmici straordinari.