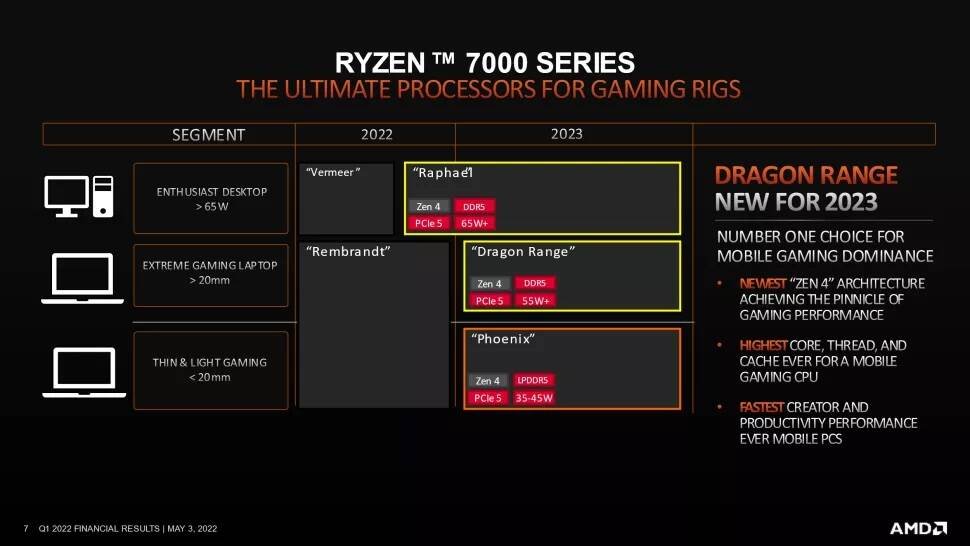Quando si parla di videogiochi, si pensa sempre ad uno spartiacque che divide, in modo più o meno netto, due macro categorie di opinioni. La prima, datata, e dettata da un forte bias culturale, è quella che vorrebbe il videogame come nulla più che un ninnolo, un giocattolo, e dunque non in grado di svolgere altra funzione che quella del mero intrattenimento ludico.
Si tratta, in effetti, di una concezione del videogame che sembra voler prescindere per forza dalla matrice prima artistica, e poi culturale, che questo splendido strumento ha sviluppato negli anni, che era già presente agli albori della sua concezione, seppur in forme non così immediatamente riconoscibili come oggi, e che è stata più di recente sdoganata grazie ad opere di enorme caratura artistica, comunicativa e, ovviamente, emotiva.
La seconda frangia è invece quella più progressista e, per fortuna, attualmente più in rapida espansione, che riconosce ai videogiochi la loro eccezionale capacità di comunicare, oltre che il privilegio di poterlo fare per mezzo di un sistema di controllo attivo che, va detto, è proprio solo di questo mezzo dell'intrattenimento, anche a paragone di quello che è uno dei più fulgidi e universali esempi di “intrattenimento che diventa cultura”, ovvero il cinema.
Dunque, perché questo articolo?
Perché di recente (leggasi: negli ultimi anni), siamo stati partecipi, ma anche protagonisti, di piccole ma importanti affermazioni dei videogame come mezzi artistici e di comunicazione, grazie soprattutto all'inclusione, all'interno dello sviluppo di alcuni titoli tripla A, di messaggi, tematiche e personaggi in grado non solo di creare il tipico “chiacchiericcio” della rete, ma soprattutto dei veri e propri casi mediatici che, anche se talvolta con risultati mediocri, hanno diffuso a macchia d'olio l'idea che il videogame vada considerato ben oltre la sua forma giocattolosa, ereditata malamente da un tempo in cui i videogame venivano rivolti alle fasce più giovani del pubblico mondiale.
Penso ad esempi lampanti come l'inclusione delle tematiche LGBTQ in The Last of Us o in Life is Strange che, includendo personaggi apertamente omosessuali, hanno voluto correre “il rischio” di proporsi con storie mature, toccanti, e innegabilmente umane. Tanto toccanti da riuscire a creare un dibattito e, in molti casi, persino una accettazione di certi temi, anche da parte dei giocatori più stoici e restii.
L'arrivo, poi, di Horizon: Forbidden West, e la consacrazione di Aloy non solo come eroina, ma come icona in antitesi con una vecchia concezione del “personaggio femminile dei videogiochi”, capace di portare al mondo un messaggio ben più profondo dei semplici risvolti dettati dalla trama del gioco ha creato un dibattito, sia nelle redazioni di chi, di videogame, ci vive scrivendo, sia nella quasi totalità della rete, seppur, anche qui, con risultati a volte ai limiti del grottesto.
E così, quello che era un pensiero che mi balenava in testa da un po', che fa poi da titolo a questo articolo, ovvero: “il videogame può essere uno strumento di emancipazione culturale”, ha cominciato a prendere una forma concreta, ben chiaro che volendo partire da un tema, ovvero quello dei personaggi femminili nei videogame, e del loro recente impatto culturale e mediatico, ho dovuto per forza di cose chiedere aiuto, anche solo per un evidente limite di immedesimazione.
Per risolvere questo dubbio, che poi dubbio non è ma, semmai, è la ricerca di una conferma, ho quindi pensato di riutilizzare la formula dell'intervista multipla che, già qualche tempo fa, aveva portato alla nascita di un articolo sul tema del videogame consacratosi come arte.
E così ho coinvolto 3 professioniste. 3 incrollabili donne la cui passione per il videogame ma, soprattutto, la competenza e la capacità professionale, ha permesso loro di consacrarsi nel settore, seppur con ruoli parzialmente diversi. L'ho fatto perché ho pensato che, se si doveva partire da Ellie o da Aloy, o anche solo dalla nuova incarnazione di Lara Croft, sarebbe stato più giusto, corretto, ed anche più interessante, chiedere a quelle donne che, anche solo per motivi di immedesimazione, potevano offrire a me, ed a voi, un punto di vista interessante sull'argomento.
Ciò detto, la parola alle nostre 3 professioniste, qui brevemente presentate in ordine rigorosamente alfabetico:
Jessica “Miss Hatred” Armanetti: ex pro gamer di Halo, celebre con il suo game tag “MissHatred”, ha alle spalle un numero enorme di tornei, con modalità ufficiali MLG, e altrettanti piazzamenti. Cosplayer, make up artist, appassionata di gaming ma, soprattutto conduttrice, con conduzioni che vantano palcoscenici come Cartoomics, Lucca Comics & Games, Gamescom, Madrid Gamesweek, Akumakun Ireland, Anime Milwaukee, Romics, e Paris Games Week. Attualmente è una delle conduttrici del programma TV e web “Crossover Universo Nerd” in onda su 7Gold.
Alessandra “Lex” Contin: freelance e scrittrice, attualmente potete leggerla su quotidiani nazionali come La Repubblica e La Stampa, comincia la sua carriera nel 1991, ed è attiva nel mondo del gaming da sempre. Tra i nomi più rilevanti del giornalismo videoludico nostrano, ha all'attivo diversi libri tra cui “Skill”, pubblicato da Einaudi nel 2004 e considerato il primo romanzo italiano a tema videogame. Compare in numerose antologie e quaderni di “games studies”, tra cui Gamers. Storie di passione per i videogiochi (Mondadori), Descrizione di un luogo (Einaudi), Hard Blog (Mondadori), Ragazze che dovresti conoscere (Einaudi), In fondo al nero (Mondadori), e Visioni da Matrix.
Stefania Sperandio: classe 1989, Laurea Magistrale all’Università IULM di Milano in Televisione, Cinema e Nuovi Media, dal 2005 lavora nell’informazione verticale sui videogiochi. Su SpazioGames.it dal 2012, dal 2020 è caporedattrice del progetto editoriale della testata. Appassionata soprattutto di analisi e critica dello storytelling interattivo, a cui dedica ampie analisi, è a sua volta autrice e ha discusso due tesi dedicate ai videogiochi – la prima su rappresentazione e rappresentanza femminile nel medium, la seconda sulle interazioni tra realtà e virtuale nelle esperienze di gioco. È stata inserita tra le 50 personalità di spicco che lavorano con i videogiochi in Italia stilata dal quotidiano Repubblica.
Stefania Sperandio
Raffaele: Stefania partiamo proprio dalle basi: secondo te quanta strada è stata fatta dal videogioco dal punto di vista del riconoscimento culturale, sia dal punto di vista internazionale che quello nazionale? Specie se consideriamo che il nostro paese, generalmente, viene considerato un po' più arretrato da questo punto di vista?
Stefania: Il resto del mondo, secondo me, sta più avanti rispetto all'Italia, nel senso che è più facile vedere anche grandi portali che danno spazio al videogioco. In Italia, se tu ti guardi intorno, quando si discute del videogioco siamo sempre gli stessi a parlare, e siamo sempre nel nostro spazietto. C'è stata un'evoluzione rispetto agli anni addietro, dal mio punto di vista, dove veramente quando dicevi "gioco ai videogiochi", la risposta era riderti in faccia. Adesso ti si ride ancora in faccia, ma ci sono ambienti in cui questo non avviene. Penso, ad esempio, all'ambito istituzionale o accademico, in cui si cerca di parlare di videogiochi come di un mezzo di comunicazione.
Raffaele: Mi pare di capire che, per te, ci sono ancora delle resistenze largamente diffuse. Il motivo?
Stefania: Questa è una cosa che non mi stancherei mai di dire, ma penso che i nemici del videogioco sono gli stessi videogiocatori. Lo dico perché capita spesso che, lavorando in una testata che ha un pubblicato abbastanza eterogeneo, come appunto SpazioGames, siano i videogiocatori i primi a dirti che siamo noi critici i primi a prendere i videogiochi “troppo sul serio”. Come per dire che se un videogioco esprime un determinato messaggio, vuole parlare di rappresentazione, magari vuole parlare di pace, allora diventa “politico”, e quindi non c'è più spazio per divertirsi. “Ah, è un videogioco politico!” dicono, come se poi un prodotto per essere politico debba abbracciare solo determinate tematiche ed escludere la componente ludica. Insomma, ci sono molto resistenze, e queste sono presenti da noi come all'estero.
Raffaele: Che poi, magari, sono gli stessi giocatori che si sono spaccati di Metal Gear negli ultimi vent'anni...
Stefania: Sì. E poi ti dicono che Metal Gear non era un gioco politico. Ho visto qualcuno dire che non fosse politico nemmeno Spec Ops: The Line. Io credo che ci sia un serio problema nel capire il tipo di messaggi che un videogioco ti può proporre, e questo è un problema che coinvolge anche parte dei videogiocatori. Ed è una cosa da non dare per scontata: è inutile che cerchiamo di "combattere" per cercare di dare un riconoscimento culturale al videogioco come mezzo, se poi ci sono dei videogiocatori che hanno difficoltà, loro stessi, a riconoscere il fatto che possono esistere videogiochi con alle spalle un messaggio più profondo del mero giocare. Posso giocare a FIFA, posso giocare a Yoshi, così come posso andare a giocare a Edit Finch, a Spec Ops o a Metal Gear e trovare una prodotto impegnato che, quando poi mi emoziona, mi rende l'anima un pochettino più pesante.
Raffaele: Secondo te questo limite da cosa è imposto?
Stefania: Secondo me i videogiocatori sono ancora influenzati, così come il pubblico di massa, dal fatto che videogioco sia associato a giocattolo. C'è una radice comune che fa ancora dire ad alcune persone “non sei troppo grande per i videogiochi?”, e che porta a pensare allo svago come ad un'attività ludica solo per i piccini, senza capire che il videogioco è una forma di gioco completamente diversa. Nessuno direbbe a qualcuno “sei vecchio per i film, i libri o le serie tv”, però perché per il videogioco si dice? Perché non è percepito come mezzo di comunicazione. È percepito solo nella sua attinenza al giocattolo. È quella che veniva chiamata dagli studiosi (Roger Caillois, ndr) la funzione di “Paidia”, ovvero il gioco disimpegnato tipico dei bambini, che non ha regole ed è spontaneo, immediato. Invece non è solo quella concezione di gioco, perché il videogame è un gioco molto più articolato. Noi lo sappiamo, ma spesso questo non viene recepito.
Raffaele: Quindi come si fa a creare una "scolarizzazione" di queste tematiche? Per scolarizzazione non intendo un approccio al videogame nelle scuole, ma un iter corretto attraverso cui passare le giuste informazioni sul medium.
Stefania: Penso che si stia lavorando bene nel tentare di parlarne in sempre più spazi, anche con resistenza. Adesso è molto più facile farsi sentire, anche quando ci sono degli spazi con visibilità che ne parlano, invece, in modo inappropriato. Qualche mese fa c'era stato un intervento sui videogiochi a Geo, su Rai 3, dove avevo sentito veramente una raffica di accuse infondate sul tema dei videogame. Non pensavo fosse possibile dire tutte quelle cose sbagliate in un colpo solo, anche perché parliamo di un servizio pubblico che, come unica prospettiva, ha saputo proporre quella della dipendenza. Aggiungo che potrebbe essere anche interessante, a patto però di parlarne come si deve, cosa che non è successa. Ecco, quando è stato mandato in onda questo intervento così inappropriato sui videogiochi, ho visto molti parlarne, molti farlo notare e prendere le difese, dicendo che la visione del programma era errata. In passato ci sarebbero state una scrollata di spalle e si sarebbe detto "chi se ne frega". È successo lo stesso pochi giorni fa quando si è parlato di nuovo, nei media più popolari, del videogioco come pericolo. Ecco, questo è il segnale che oggi esiste una cultura più consapevole del videogioco e di quello che può fare, che sta facendo progressi rispetto agli anni addietro. È già arrivata dove vorrebbe arrivare? No, perché va molto piano.
Raffaele: Dunque, secondo te, l'ignoranza che sussiste tra i giocatori crea un certo tipologie di barriere. A questo punto, secondo te, è la stessa ignoranza che porta a screditare le donne che si interessano al mondo del gaming? Si tratta di un tema che mi interessa molto perché, visto l'aumento di donne che danno voce alla propria passione da gamer, mi pare che, a contrasto, si si anche risvegliata quella parte di pubblico cultura che pensa solo che la donna non possa occuparsi di videogiochi se non, ecco, giocando su Twitch. Dov'è il problema qui? Pensi che ci sia un blocco "culturale" diverso? O magari è solo la somma di tutta una serie di problemi legati agli stereotipi che si hanno sulle donne?
Stefania: Penso sia la somma di più problemi. C'è sia quel tipo di resistenza di cui ho già parlato, per cui uno non considera il videogioco una cosa seria, quindi perché dovresti perdere tempo con i videogiochi. E sia che, quando il videogioco viene ridotto a giocattolo, spesso viene identificata solo la sua parte agonistica, ovvero la gente che si sfida nei videogiochi. La parte competitiva è sempre, sia storicamente che culturalmente, identificata come esclusivamente maschile. Di solito e secondo lo stereotipo, l'uomo è quello competitivo e la donna è mansueta e questo, per estensione, riduce anche ai minimi termini quello che una donna può fare o no, anche nei videogiochi. In più, abbiamo ventenni di comunicazione sulle spalle, tutta legata ad una visione dei videogiochi al maschile. Un po' come il Game Boy, che si chiamava così perché per uno studio di marketing aveva pensato che quello era un prodotto che avrebbe funzionato per i “boys”, senza la volontà di rivolgersi alle “girls". Perché a livello culturale più vicini ad un certo tipo di tecnologie, ed anche allo studio di quelle tecnologie, sono sempre stati solo gli uomini. In questo senso, anche il videogioco è diventato un ambiente così maschilista, anche se parliamo del giornalismo di settore, che a volte alcune donne di talento si sono sentite scoraggiate ad avvicinarsi a questo lavoro.
Raffaele: Capisco, tant'è che mentre lo dici sto cercando di pensare a nomi di donne che sono diventate famose nel mondo dello sviluppo, ma in effetti sto facendo un po' di difficoltà.
Stefania: Certo, perché se pensi, ad esempio, a Naughty Dog, pensi subito a Neil Druckmann e non a Amy Henning (la sceneggiatrice della serie Uncharted ndr). Anche se sei brava, è comunque difficile farsi notare, ma per fortuna ci sono esempi che ti danno speranza, pensiamo alle origini di Sierra e ad esempi più recenti come Jade Raymond. Per farti un altro esempio: tempo fa ho avuto contatti con il corso di game design della Statale di Milano. Lì mi sono resa conto che, anche se erano quasi tutti uomini, c'erano diverse studentesse che volevano lavorare nel mondo dei videogiochi, e questo era attorno al 2015, quindi spero che con il susseguirsi degli anni, sempre più studentesse si siano sentite più libere di partecipare. In generale, confermo quanto ti ho detto: c'è un sovrapporsi di problemi culturali. Poi, quale tra questi prenda il sopravvento, è del tutto secondario.
Raffaele: di recente ci sono stati due eventi che hanno calamitato l'attenzione del mondo dei videogiochi, relativamente a questione di mera sessualità. Sto pensando, ad esempio, a The Last of Us, o anche a Life is Strange. Parliamo di titoli in cui si parla non solo di protagoniste femminili, ma anche di concetti come la sessualità e l'orientamento sessuale, o ancora Aloy, che invece ha creato una crepa rispetto a quella che è la più comune e stereotipata sessualizzazione di una protagonista femminile. Ora, su questo tema immenso ti faccio due domande distinte. La prima: perché, secondo te, un team di sviluppo “azzarda il rischio” di trattare argomenti che possono far imbestialire la community? E inoltre: come interpreti tu, come giocatrice e come professionista, mosse come quella di Sony relativa alla famosa statua di Aloy “The Placeholder”? A prescindere , ovviamente, da qualsiasi parere o gusto sul gioco in sé.
Stefania: Dunque, sicuramente c'è un contesto di dibattito storico e culturale diverso rispetto a quello di anni prima, che fa trovare più facilmente il coraggio ai publisher nel prendersi un rischio. Io cito sempre il caso di “Remember Me”, un titolo che non trovava un publisher perché la sua protagonista era una donna e, per qualcuno, quell'idea non funzionava. Che, se ci pensi, è una roba fuori di testa, perché è come se ti rimbalzassero un film perché invece di Tom Cruise c'è Nicole Kidman. Se la intendi così, si capisce che abbiamo un problema. Remember Me è uscito nel 2013, sono passati meno di dieci anni da questa situazione, ed è cambiato - per fortuna - il tipo di approccio che hanno i publisher in tal senso, che hanno “trovato il coraggio” di dimostrare che la convinzione che bloccava Remember Me era sbagliata. Naturalmente, il rifiuto era dato dagli studi che un publisher fa prima di immettere sul mercato un gioco: si guardano numeri, ci si aspetta che le cose vadano e, in un certo senso e, scommettono sulla buona riuscita. Questo è dovuto alle resistenze che ci sono ancora oggi, per cui ci sono persone che ti dicono che non vogliono giocare a The Last of Us 2 perché non c'è Joel come protagonista principale giocabile. E sono tanti, ma proprio tanti. Quelle che fanno resistenza ancora oggi sono persone dove il problema culturale è molto più profondo di quanto un videogioco possa provare a risolvere. Perché sono gli stessi che non guarderebbero un film con protagonista una donna, perché “la storia di una donna non è interessante”.
Raffaele: Dunque mi dici che le cose sono cambiate ed i publisher se ne sono accorti?
Stefania: Direi di sì. Certi publisher sanno che ora c'è un contesto culturale diverso. Penso ad Ubisoft, da cui erano usciti i messaggi interni tipo: "non possiamo mettere una protagonista perché le protagoniste non vendono", e poi ha di recente preso il coraggio a due mani dicendo che Kassandra (la protagonista di Assassin's Creed Odyssey ndr), è il personaggio canonico per la serie, cosa che è poi stata detta anche per Eivor (il protagonista di AC: Valhalla ndr). Certo, lì con il pretesto del gioco di ruolo puoi comunque offrire una scelta libera tra il personaggio maschile e quello femminile, e lasciare tutti tranquilli, ma ciò non toglie che in quegli universi è il personaggio femminile ad essere protagonista, ed il team ha compiuto una serie di scelte per inserirlo in modo coerente, Si tratta di un grosso passo in avanti rispetto a quando dissero "non possiamo mettere una donna perché dovremmo fare troppe animazioni".
Raffaele: Scusa se ti fermo un attimo, ma involontariamente sei arrivata ad un punto in cui sarei voluto arrivare io alla fine. Citando proprio la questione di Ubisoft, trovo sia interessante analizzare la compagnia, si per motivi di importanza che di vendite, e penso che proprio Assassin's Creed sia, per ovvi motivi, il brand da analizzare con più cura. All'inizio si era detto che Ubisoft non voleva un Assassin's Creed (almeno non uno degli episodi principali) con protagonista femminile. Ha rimediato a questa cosa Syndicate in cui c'erano due personaggi principali, ed uno di questi era una donna. Infine, con Odyssey e Valhalla, si sono di nuovo cambiate le carte un tavola, scegliendo di darci la possibilità di selezionare liberamente il sesso del personaggio, confermando solo a posteriori quella che è la scelta canon per il team di sviluppo. Ora ti chiedo: rispetto alla scelta di Syndicate, non trovi che sia forse un po' più “facile” e meno coraggioso offrire una scelta libera come quella degli ultimi due AC?
Stefania: Sì, perché penso che si ottenga un risultato migliore quando al centro di tutto c'è una scelta precisa. Anche dal punto di vista della scrittura funziona tutto meglio e valorizza il personaggio. Per esempio: se tu hai giocato Eivor uomo, e io Eivor donna, abbiamo avuto la stessa esperienza, questo perché il personaggio è diventato una sorta di contenitore. Questo prescinde dal carattere o dall'atteggiamento che il team ha voluto dare ad Eivor, resta comunque un personaggio che è indifferente alla scelta uomo/donna, e secondo me così si perde un qualcosa. Il team di sviluppo avrebbe potuto prendersi un rischio e dire “è solo uomo” o “è solo donna”, e sarebbe stato interessante capire il perché di quella scelta, e vedere come sarebbe stata portata avanti. So che suona strano per un titolo ruolistico, ma penso che sia così.
Raffaele: Secondo te perché è stata fatta una scelta del genere? Perché è mancato il coraggio?
Stefania: Credo sia tutto legato al malcontento che era venuto fuori quando uscì fuori la questione dei soggetti al femminile che venivano scartati dai piani alti. È una cosa che, prima o poi, gli sarebbe scoppiata in mano.
Raffaele: Lo capisco ma devo dirti che, per quel che mi riguarda, mi dà fastidio il modo in cui è stata fatta comunicazione per questi giochi: pensa ad Assassin's Creed Odyssey, presentato con Alexios in bella mostra, o di quando al lancio di Valhalla ti proponeva Eivor in versione maschile. Non trovi che sia fastidioso? Come un non volersi assumere certe responsabilità?
Stefania: A me manda in bestia. E tutto dipende dal fatto che, semplicemente, con un personaggio maschile in copertina fai più colpo, e allora lo sfrutti. Si ha sempre l'impressione che ci sia una proposta di serie A ed una di serie B, non ti si offre l'idea che l'esperienza di gioco possa essere appagante anche se al tuo personaggio mancano gli attributi maschili. Questo tipo di marketing, per cui il personaggio maschile è quello standard, sposa questa visione per cui con lo standard è maschile, la donna è solo un'alternativa... a patto che ci serva metterla.
Raffaele: Ci siamo dilungati, scusami. Torno alla seconda domanda, che ti ripropongo in versione estesa: parlando della statua di Aly, pensi che manifestazioni pubbliche come mettere una statua di un personaggio femminile a ridosso dell'uscita del gioco per cercare di lanciare un messaggio possono essere apprezzabili? Non credi che poi certe manovre portino le persone a chiedersi se un presupposto culturale sia vero o fittizio? In soldoni: la statua di Aloy, per te, aveva senso, o era solo una mossa di marketing che, magari, era meglio non fare?
Stefania: io mi sono emozionata davanti all'iniziativa della statua di Aloy. Lo so che è marketing, e non sono rimasta scioccata come quelli che sottolineavano “ohh guarda che vogliono vendere il gioco”. Ma va?! Davvero vogliono vendere il gioco? Eppure, al netto della volontà di vendere il gioco, ci hanno comunque messo dentro un messaggio apprezzabile, addossandolo ad un personaggio che, a suo modo, è comunque un'icona, che ha anche un enorme peso sulle spalle. Sony gliene ha anche addossato un altro paio: il primo è quello della toponomastica italiana, dove abbiamo un serio problema di cui nessuno riesce a discutere. Eppure è interessante, e se studi la cultura del paese, ti domandi se sia mai possibile che non ci sia stata una donna che si sia meritata una statua nel nostro paese. Da lì hanno pensato di chiamarla “The Placeholder”, perché chiaramente non stiamo celebrando il personaggio di un videogioco, stiamo celebrando donne che fanno grandi imprese. Quindi il fatto che il giorno successivo, poi, si sia parlato di questo problema che in Italia c'è, con la potenza comunicativa di un gigante come Sony, è qualcosa a cui dare merito. Perché non ci saremmo mai arrivati se non avessero pensato di legarci, oltre alle vendite del gioco, anche questo problema. La seconda cosa che hanno caricato sulle spalle di Aloy è il farle incarnare ancora, ancora e ancora che noi donne siamo state trattate come disagiate, soprattutto quelle della mia generazione, ovvero le nuove giocatrici. È stato bellissimo vedere le tante persone, e le tante giocatrici, che sono andate davanti alla statua a scattarsi una foto. È una cosa che ti fa dire che forse, alla fine, non eravamo poche e non eravamo così strane come volevano farci credere. I videogiochi hanno risposto che c'è spazio anche per le videogiocatrici. Ed è una cosa che prima il medium non faceva. Perché quando mi dicevano che ero strana perché giocavo ai videogiochi mi giravo e vedevo la principessa Peach da salvare, Samus che se trionfavi scoprivi che era una donna e si spogliava in base a quanto eri stato bravo, e poi Lara Croft, che io amavo, ma non era pensata sicuramente per rappresentare niente, era solo una bellissima modella, come in una pubblicità. Questa visione è cambiata, ed a memoria di questo qualcuno ha pensato valesse la pena dedicare una statua alle donne, ma anche alle videogiocatrici. Perché anche noi abbiamo bisogno di essere abili e tenaci. Vogliamo essere noi stesse, e non è detto che si riesca a farlo capire a chi ci guarda dall'esterno. Aloy, con la statua The Placeholder, ha incarnato tutte queste cose, e per quanto mi riguarda è stato un progetto bellissimo.
Jessica Armanetti
Raffaele: Jessica partiamo da una domanda secca. Dal tuo punto di vista, che è quello di una appassionata di gaming, di una ex giocatrice professionista, e di una presentatrice di un programma che parla per lo più di gaming oltre che di cultura nerd, come è messo il mondo del videogame dal punto di vista culturale? Può effettivamente essere il veicolo per un'emancipazione culturale?
Jessica: Dunque secondo me il videogioco in qualche modo è sempre stato uno strumento culturale. Il punto è capire quando le persone se ne siano accorte, e quando abbiano cominciato a dargli un certo peso. Ti faccio l'esempio di Monkey Island di cui, per altro, sono super fan. Tutti considerano, giustamente, Guybrush come protagonista, ma se osserviamo attentamente ci rendiamo conto che è Elaine Marley il vero personaggio forte del gioco. Perché Guybrush è un po' sfigatello, cerca di fare qualcosa che poi non riesce a fare, perché è un disastro in tutto quello che fa. Elaine, invece, è una personalità forte e determinata, e penso che questo sia dovuto al fatto che, nel team di scrittura c'erano moltissime donne che, evidentemente, sentivano il bisogno di raccontare di un personaggio femminile che ha il bisogno di emanciparsi, e stiamo parlando di un gioco di 30 anni fa.
Raffaele: Premesso che concordo, nel senso che quando c'è un'esigenza da parte di chi crea un prodotto, quella necessità si trasforma poi in un prodotto che ha un senso molto preciso e definito, anche solo nelle sue sfumature, ti chiedo: ma allora forse il problema è altrove? Potrebbe esserci, secondo te, un problema culturale, se non “genetico” nella percezione errata del videogame? Insomma: certe persone non riescono a sensibilizzarsi verso il medium, perché c'è un problema alla radice?
Jessica: Secondo me un po' sì. Non ho il quadro completo di tutta la situazione, però io guardando indietro, penso che oggi ci siano comunque stati dei miglioramenti. Penso a The Last of Us 2, che ha come protagoniste Ellie, che è omosessuale e Abby, che ha un corpo muscoloso, quasi mascolino. Purtroppo, anche al netto di questo, ci sono poi situazioni imbarazzanti, come la gente che critica “l barba” di Aloy.
Raffaele: Ma c'è, secondo te, un problema di “sessismo” nei videogame. Nel senso: è difficile immedesimarsi in personaggi che non sono del tuo stesso sesso? A me, personalmente, non è mai importato nulla, ma forse sono privilegiato, perché per anni i personaggi sono stati maschi, e non donne, e comunque non mi è mai importato se al centro del racconto ci fossero un uomo o una donna. Tu che ne pensi?
Jessica: In realtà anche io sono sempre stata come te: dammi un personaggio e non ho nessun tipo di problema. Però c'è una cosa che mi dà fastidio oggi, ed è il forzare la mano. Ad esempio, tornando a The Last of Us, lì penso che sia tutto perfetto. I personaggi sono così, te li schiaffano in faccia fin da subito e va bene, o li accetti o non li accetti. Non penso che sia successo lo stesso con Horizon ad esempio, dove mi sembra che la Aloy del primo gioco sia diversa da quella del secondo capitolo. Non sto dicendo che sia più bella, più brutta o più magra. La trovo solo diversa.
Raffaele: Di che tipo di problema stai parlando? Un problema di scrittura?
Jessica: No, penso che si sia voluto calcare la mano sull'estetica del personaggio e dire: "Guardate, ora mettiamo un personaggio più robusto", quando non era così. Per me non è un problema se tu mi fai un videogioco in cui una donna è muscolosa più di un uomo, chi se ne frega. Così come non mi importa se ci metti una donna che pesa 100 chili, 200 chili o 20 chili. Mi dà fastidio, però, se modifichi l'estetica di un personaggio a cose già fatte. Un po' come quando, forzatamente, certi film e certe serie TV si orientano, solo per moda, verso un certo politically correct, senza però che questo avvenga in modo naturale.
Raffaele: Ho capito cosa intendi. Ma secondo te questa cosa viene fatta per motivi di comodo, per motivi di marketing, o perché c'è la volontà di dimostrarsi in controtendenza rispetto a quella che è la media del mercato?
Jessica: Non ci vedo una questione di marketing, non ci vedo una cosa brutta o maligna. Penso che si voglia solo andare incontro a certe tendenze, anche quando sembra che siano controcorrente. Volte penso lo si faccia con la volontà di passare anche un messaggio positivo, ma penso che si sbagli nei modi. Secondo me non ha senso puntare troppo i riflettori su di una cosa per metterla in evidenza, non lo trovo naturale. Certe scelte devono essere più bilanciate, più silenziose, un po' come è successo per The Last of Us che, lo ripeto, per me è perfetto in questo senso.
Raffaele: A questo punto devo chiedertelo: che ne pensi della statua di Aloy?
Jessica: A me è piaciuta. Nella storia sono sempre state costruite delle statue per simboleggiare un personaggio importante, che fosse fonte di ispirazione, ed il fatto che l'abbiano creata per un personaggio di un videogioco, secondo me è una cosa enorme. Anzi è una cosa fantastica! Vuol dire che rappresenta non un'idea o una fantasia, ma qualcosa di più concreto, come una persona vera e propria. Questo perché, per qualcuno, quello che trasmette è diventato reale e questo è bellissimo.
Raffaele: Quindi è stata un'idea che ti è piaciuta?
Jessica: Assolutamente!
Raffaele: A questo punto, abbiamo parlato di giochi che ti propongono un personaggio fatto e finito, ed abbiamo stabilito che non ci importa che sia uomo o donna, lo prendiamo così com'è e chi se ne frega. Cosa ne pensi, invece, di quei titoli che, forse anche per cercare di rincorrere un bisogno meramente partecipativo, non riescono ad essere netti nel modo di presentare il loro personaggio principale? Ti cito Assassin's Creed perché è già spuntato in queste interviste e mi spiego meglio: ai tempi mi piacque molto l'idea con Syndicate di offrire due personaggi, uno maschio e uno femmina. Ho trovato invece fastidiosa la scelta fatta con Odyssey e Valhalla, cioè quella di offrire una scelta libera per il sesso del personaggio, ma di puntare la promozione dei giochi attraverso personaggi maschili per poi, a gioco digerito, rendere canonica solo la scelta femminile. Tu che ne pensi?
Jessica: Anche a me non mi piace. Una cosa simile era successa anche con Mass Effect, in cui tu potevi scegliere se fare John Shepard o Jane Shepard. Ed anche lì, gran parte della comunicazione era incentrata sulla versione maschile. Su Assassin's Creed in sé non posso dire molto. Ho smesso di giocare la serie, ho recuperato in parte Odyssey, ma di Valhalla non mi sono interessata.
Raffaele: Beh, questo non fa che confermare la mia idea che qui ci sia un problema, almeno dal punto di vista della comunicazione.
Jessica: Direi che non ha senso. Non ha proprio senso. Onestamente preferisco quando mi propongono una scelta unica e sensata, come in The Witcher, in cui c'è solo Geralt e va bene così. Il resto mi sembra solo un contentino, e questa cosa non mi piace. Per il resto io non credo di essermi mai lamentata di nessun personaggio. Anche se forse, ad essere sincera, non mi è piaciuta la Lara Croft dei nuovi Tomb Raider,
Raffaele: Questo mi interessa molto! Che cosa ti ha dato di fastidio?
Jessica: Se penso ai vecchi capitoli, Tomb Raider ha sempre proposto una Lara Croft super badass capace di qualsiasi cosa, e che non ha paura di nulla. Non mi è piaciuto il tono della nuova Lara... mi è sembrata quasi una pappamolle. Capisco la questione del rendere il personaggio “più umano”, ma questo significa per forza che si debba andare in una certa direzione? Avrei preferito un gioco creato da zero a questo punto, e senza il bisogno di chiamare la protagonista “Lara Croft”.
Raffaele: Però aspetta, non pensi che lì ci fosse un problema a monte? Insomma, lo spessore narrativo di Lara Croft, se c'era, si era esaurito da tempo. C'era il bisogno di raccontarti qualcosa di nuovo e, per farlo, occorreva fare molti passi indietro. Perché in effetti Lara Croft è figlia di una forte stereotipizzazione femminile, no? Come ben dimostrato dalle generose dimensioni del suo seno.
Jessica: No vabbè, questo è vero, penso però che il personaggio sia stato completamente snaturato. No?
Raffaele: Secondo me hai sollevato una discussione davvero interessante. Penso che ci sia un limite dato da un modo di sviluppare e pensare ai videogiochi dagli anni '80 e '90 che è dato da tutta una serie di dinamiche che sono perlopiù relative allo sviluppo. Cioè certe cose erano più semplici perché il mercato era più semplice, perché c'erano meno soldi per fare determinate cose e questo si trasformava in una serie di restrizioni, che potevano essere tecniche, artistiche e narrative. Tomb Raider nasce fondamentalmente come richiamo alla cultura del film action, quello all'Indiana Jones, in cui tu non ti sei mai domandato del perché un professore universitario, che quando raramente te lo fanno vedere che insegna sembra una persona molto ordinaria, sia perfettamente in grado di scoccare una frusta prendendo un ramo specifico tra i 3mila che sta guardando. Non te lo spieghi e non hai bisogno di farlo. Però quella cosa non è possibile. Né ti sei mai domandata delle motivazione sociopolitiche sul perché Indiana Jones fa Indiana Jones. Allo stesso tempo a noi non ce ne fregava del perché Lara Croft facesse la Lara Croft. A noi importava che fosse sexy, e che sapesse saltare, sparare e fare la capriole. Con il nuovo Tomb Raider hanno invece cercato di offrirci un nuovo punto di vista, più, meno pragmatico ma più interessante, un po' come è successo per God of War. Anche lì, la vecchia concezione di Kratos non aveva davvero più nulla da dire, ed è ovvio che proporre un personaggio che non sa far altro che uccidere, in un mondo in cui ci esaltiamo per The Last of Us 2, non avrebbe avuto molto senso. Ed infatti, se consideriamo che ci sono almeno 6 o 7 God of War prima del reboot del 2018, è con quest'ultimo che ci hanno raccontato qualcosa di davvero interessante su Kratos, e penso che lo stesso sia successo con Tomb Raider. Scusa se mi sono dilungato.
Jessica: Ma scherzi? Capisco perfettamente il tuo punto di vista. Penso che certe scelte, inevitabilmente, spezzino il pubblico in due. Poi, certo, se mi fai pensare a God of War del 2018, quel gioco mi ha fatto davvero commuovere, quindi probabilmente hai ragione.
Raffaele: Ecco, io so che ami molto Red Dead Redemption...
Jessica: È il mio gioco preferito!
Raffaele: Ecco, pensa a qual è la vera ricchezza di Red Dead Redemption 1 e Red Dead Redemption 2. Non penso siano l'ambientazione o la grafica, è proprio la scrittura! Hai un personaggio che ha qualcosa da dirti anche quando compie delle azioni in cui fondamentalmente non c'è granché da dire, come una missione secondaria, ed è per questo che poi uno si innamora di Red Dead Redemption. Lara Croft, prima dei reboot di Tomb Raider, in effetti non è che avesse chissà cosa da dire, anzi, non comunicava proprio niente, se non un antico lascito di un maschilismo molto molto accentuato che voleva che le eroine dei videogiochi fossero scollate e pettorute.
Jessica: La questione scollatura e seno prosperoso è una roba che mi dà ancora abbastanza i nervi! Riguardo a Red Dead Redemption 2, ti tiro fuori Sadie Adler, che è un personaggio che ha una crescita fuori di testa. Ma quello va benissimo, a me piace, io sono super d'accordo con te con il discorso della scrittura e con il discorso della storia da raccontare e ancora di più Red Dead Redemption lo fa alla perfezione. Penso che forse sono così affezionata a Lara Croft che mi riesce difficile ammettere che il reboot abbia molto più da dire su Lara di quanto non abbiano fatto i capitoli originali, ma forse il problema è mio perché sono troppo affezionata al personaggio, perché mi hai fatto questo parallelismo ed è vero. Hai ragione. Il quarto ha più da dire.
Raffaele: Tornando a noi: tu sei la conduttrice di un programma che fa cultura nerd (Crossover Universo Nerd ndr) che, checché se ne dica, è cultura, ed anzi voi la trattate con una piacevole freschezza. Dal tuo punto di vista, come conduttrice di questo tipo di programma, come sta messo il mondo dei videogame e soprattutto, da donna, che sarà stata sicuramente vittima di un certo tipo di linguaggio, come sta messo il mondo dei fan dei videogame?
Jessica: Ecco, forse si lega un po' al discorso di prima. Da un lato c'era già l'emancipazione, ma forse il pubblico e i fan non erano in grado di capirla. Posso dire con certezza che, per quanto riguarda la mia esperienza personale, i fan siano migliorati rispetto a prima, almeno rispetto a dieci anni fa. Stiamo parlando di tempi in cui ero una gamer professionista e giocavo ad Halo. Prima era una roba fuori di testa, non potevi quasi partecipare a certi tornei, perché ti dicevano:"no, non puoi giocare contro di me che sei una ragazza". Adesso è quasi normale, almeno, c'è una certa parità di sessi sulla scena competitiva. Poi, se guardo al privato, io gioco con molte più ragazze rispetto a prima.
Raffaele: secondo te questo tipo di evoluzione, non solo dal punto di vista dal numero di donne che giocano e ammettono di giocare, ma proprio questo miglioramento di cui mi stai parlando, da cosa è dovuto? Cosa si è sviluppato?
Jessica: Direi che era inevitabile. Era inevitabile perché le ragazze che giocano ci sono sempre state, si sono accorte che erano allo stesso livello, e quelle che non se ne erano accorte se ne stanno accorgendo e se ne accorgeranno. È una cosa paritaria, tanto che a me dà fastidio il termine “gamer girl”. Non è una distinzione che serve a qualcosa, sono una gamer e basta. Purtroppo questo è un aspetto del gaming che è sempre esistito, ma almeno sembra che oggi sia più semplice accettare che una ragazza possa voler giocare e competere nei videogame. Ti faccio un altro esempio di quanto fossimo messi male prima?
Raffaele: Vai!
Jessica: tempo fa lavoravo da GameStop, e quando entravano dei clienti maschi, molti ragazzi non chiedevano le cose a me, le chiedevano al mio responsabile. Quando poi cercavo di dire: “guardate che io sono qui, e qui ci lavoro”, loro mi rispondevano che preferivano parlare con lui, solo perché era maschio. Ora siamo messi meglio, ma siamo ancora lontani dalla perfezione.
Raffaele: Dunque, secondo te, questo videogioco riuscirà ad avere la consacrazione finale come prodotto culturale, come per esempio è spettato al cinema e al fumetto? Oppure c'è ancora tanta strada da fare ?
Jessica: Per me ci si arriverà, ma c'è ancora strada da fare, magari tra 10 anni...
Raffaele: Perché 10?
Jessica: Perché in 10 anni ho visto un cambiamento continuo ma grande a livello di pubblico, e penso che ci vorrà più o meno lo stesso anche affinché ci si un cambiamento nel percepire il videogioco dal punto di vista culturale. Il mercato cambia e sta cambiando, se oggi abbiamo avuto The Last of Us 2, ed è piaciuto quasi a tutti, figurati che succederà tra 10 anni!
Alessandra Contin
Raffaele: Parliamo di immedesimazione tra personaggio e giocatore: che cosa ne pensi del rapporto che sussiste tra il giocatore, maschio o femmina che sia, ed il personaggio che viene giocato? Negli ultimi anni questa faccenda ha acceso un dibattito grazie a personaggi come Ellie e Aloy, e la mia impressione è che ci sia una difficoltà, in molti giocatori, ad identificarsi con personaggi femminili che siano oltre lo stereotipo.
Alessandra: Io non credo esista una grossa difficoltà tra persone intelligenti aimmedesimarsi con un personaggio che non sia del tuo stesso sesso o comunque non rispecchi le tue inclinazioni. Penso che sia un'impossibilità di un certo tipo di giocatori che partonocon dei preconcetti fortissimi dovuti alla loro formazione particolare. Nel senso che se sei cresciuto in un ambiente per cui la divisione dei sessi è rigorosa, pensi che esista la teoria del gender, o pensi che giocare con un personaggio femminile ti porterà all'omosessualità, allora ti porrai il problema. I restanti videogiocatori, che sono poi la maggioranza, sono indifferenti a questo tipo di pensiero, e non credoabbiano alcun problema a giocare con un personaggio femminile.
Raffaele: e che mi dici invece dell'identificazione vera e propria?
Alessandra: Quella la può avere una persona dello stesso sesso, o comunque una persona abbastanza fluida, per cui è indifferente identificarsi con un uomo o una donna. L'attrito tra personaggio/giocatore insorgequando hai persone che hanno così tante barriere da partire con così tantipreconcetti che trovano insopportabile anche solo la proposta di un certo tipo di protagoniste. Penso a tempeste social come "Ellie è gay" o "Abby è brutta": è tutto nella loro testa, specie perché poi scopri che neanche hanno giocato ad una roba come The Lst of Us 2.
Raffaele: Tornando alla mia domanda originale: se, secondo te, questo problema non è così concreto, perché allora da parte dei team di sviluppo c'è sempre più la volontà o, se vogliamo, il bisogno di proporre personaggi che superino lo stereotipo?
Alessandra: Perché i tempi sono cambiati. Perché la nostra società sta finalmente superando gli stereotipi, e perché certi argomenti sono sul piatto ogni giorno, mentre prima no. I tempi sono veramente cambiati e il mercato, intelligentemente, sta seguendo quel modo di pensare, conscio che si deve rapportare a un un pubblico immerso nel cambiamento. Le nuove generazioni sono molto più avanti di quello che mediamente noi vogliamo dimostrare. Un esempio banale è quello del clima: che ha nelle nuove generazioni i più appassionati attivisti per la lotta al cambiamento climatico. Questi sono i giocatori di adesso che saranno i giocatori del futuro, ed hanno genitori che stanno negli uffici marketing, che si occupano di game design e sviluppo e che, probabilmente, si stanno rendendo conto di doversi adattare a questi nuovi giocatori. Non è che magicamente aziende come Ubisoft hanno avuto l'illuminazione ed hanno detto "da adesso facciamo anche personaggi femminili” o “facciamo personaggi lontani dagli stereotipi". Succede perché i giovani giocatori non pensano per stereotipi, per loro gli stereotipi non esistono più.
Raffaele: Trovo curioso che tu tiri in ballo Ubisoft, perché è una delle compagnie di cui ho discusso con Stefania Sperandio. Con lei ragionavo sull'iter creativo che Ubisoft ha attraversato in questi anni. La mia idea è che Ubi stia tarando il proprio approccio al mercato utilizzando le idee su Assassin's Creed, anche perché è la serie con cui vendono di più. Penso al passaggio che hanno fatto con Syndicate, dove proponevano unastoria, con due punti di vista uniti e paralleli, e con protagonisti di ambo i sessi. Ecco, quella per me è stata una scelta più interessane di quanto non abbiano fatto con Odyssey e Valhalla, dove abbiamo un unico personaggio che poi viene canonizzato a posteriori, come poi è successo con Kassandra. La cosa che mi urta? Lo spingere il gioco con una comunicazione tutta al maschile, per poi dichiarare che la vera protagonista è la versione femminile. Mi sembra quasi che non ci credano più abbastanza. Ti chiedo quindi: tu come la percepisci questa scelta? È una mossa di marketing? Quanto si è perso, quanto si è guadagno rispetto a quella che era la scelta di Syndicate che forse era stata più forte?
Alessandra: Personalmente penso che tutte le compagnie stiano cercando di avere un personaggio completamente customizzabile, così che tutti ci si possono riconoscere. Ci sono diversi studi in tal senso: quando tu ti fai un avatar, cerchi di riprodurti in qualche modo. Ubisoft ha seguito solamente questa idea, come altri prima di lei: ha dato la possibilità ai giocatori di immaginarsi come vuole, per non perdersi secondo me delle fette di mercato e quindi, come suggerivi tu, questo è assolutamente marketing.
Raffaele: Sempre relativamente al marketing, come hai percepito la statua dedicata ad Aloy a Firenze per il progetto “The Placeholder”?
Alessandra: Beh io ho preso una posizione abbastanza radicale su tutto quello che è successo. Dato che da oltre vent'anni porto avanti certe tipologie di argomenti, spendendomi in azioni concrete. Se ci sono persone che pensano che la statua dedicata ad Aloy sia solo ed esclusivamente un problema, cioè una mossa di marketing, io non posso che essere d'accordo. Sony è una multinazionale, che ha fatto un'operazione marketing, e questo è un fatto. Tuttavia penso che ci sianooperazioni e OPERAZIONI. Se tu vai contro operazioni di questo genere, che secondo me è una buona idea, perché tanto Horizon 2 avrebbe venduto uguale, e avrebbe venduto tanto, allora il giorno dopo che smobilitano quella statua, tu devi essere lì con un cartello con cui tieni aperto il dibattito. Perché è molto facile parlare di queste cose sui social, senza poi fare niente. Magari si può discutere dei modi, del linguaggio, o anche solo dell'idea della statua, però non puoi mandare in vacca tutta una buona operazione che mette un accento su un problema che c'è, semplicemente perché non sei d'accordo. Dunque, penso che la polemica sulla stata sia stata molto sciocca, per non dire gratuita ma, del resto, sembra che ormai sia così su qualsiasi cosa. Dal voto di un gioco ad un'operazione marketing ad un personaggio, ci sonosempre delle mega polemiche, anche perché oramai i social ci hanno abituato a questo tipo di dinamiche. Ma scusate, giocate e basta!
Raffaele: Proprio nell'ottica di questa comunicazione che è diventata sempre più inviperita da un lato e sempre più difficile dall'altro secondo te, a questo punto, può il videogioco diventare un oggetto, uno strumento culturale se c'è una frangia che invece non riesce a far nient'altro a perdere tempo su "problemi" come la forma fisica di Aloy?
Alessandra: Diventa uno strumento culturale in mano a persone che sono aperte. Come un libro, come un film. Un libro ti può cambiare la vita? Cavoli se te la può cambiare. Ci son dei libri che hanno cambiato la vita della persone, in bene e in male. Non è vero che certe opere sono innocue e non producono nulla. Certe opere non sono affatto innocue e producono cambiamenti, ed anzi possono essere usate per la propaganda. L'intrattenimento non è esattamente un medium neutro, non lo è affatto. I cambiamenti avvengono se vengono recepiti. Ti faccio un esempio: io sono andata a vedere Guerre Stellari Episodio IX, quello con la protagonista donna (Rey ndr), e ci sono andata per accompagnare le mie due nipoti, e una serie di ragazzini e ragazzine attorno ai 12 anni. Le mie due nipoti erano talmente coinvolte, ed anche gli altri ragazzini saltavano sulla sedia. Le ho viste totalmente coinvolte, e questo dimostra che aver scelto una protagonista donna non è una questione neutra. Disney ha trasmesso l'idea che anche una donna può essere una Jedi e scegliere di fare quel che vuole, e questo genera immedesimazione. È un cambiamento culturale? Cacchio se lo, è ed è anche molto forte! Non è da sottovalutare. Ecco, queste sono cose che ti fanno rendere conto che l'intrattenimento non è neutro, manda messaggi e i messaggi possono essere recepiti e possono cambiare sia la percezione delle persone, che il mondo circostante. Questo vale anche per i videogiochi.
Raffaele: Visto che hai citato il cinema a me interessa sempre il paragone cinema/videogame. Non per questione di Kojiniama memoria, a me interessa più la questione comunicativa. Prima il cinema era considerato il mero intrattenimento, ci è voluto un lungo lavoro che è passato prima dalle piazze, poi addirittura dalle università per trasformare il cinema nel cinema inteso artisticamente e culturalmente. Secondo te a che punto siamo nel mondo del videogame su questo passaggio?
Alessandra: no no, siamo molto indietro, ma Siamo sulla buona strada. Lo siamo perché sono stati fatti dei passi avanti con le produzioni mainstream. L'ultimo The Last of Us, Horizon, quindi stiamo facendo delle produzioni “hollywoodiane” per i videogiochi, con grandissimi budget, e con un budget pubblicitario enorme. Insomma: Aloy finisce sulla cover di Vanity Fair, e questo è un fatto grosso. In realtà, però, il ruolo grosso lo giocherà il settore indie. Di recente ho intervistato Christian Cantamessa, sceneggiatore, tra la varie, del primo Red Dead Redemption, e lui, come me, è convinto che un grandissimo aiuto su questo discorso lo giocherà l'indie. Perché l'indie si potrà permettere di avere dei prodotti come quelli di Playdead, che sono politici, che funzionano. Si avrà questa evoluzione nel momento in cui si abbasseranno molto i prezzi di produzione e chiunque abbia una visione autoriale potrà realizzarla. Più ci saranno produzioni autoriali, più il pubblico si differenzierà, più il gioco potrà maturare, perché fino a poco tempo fa l'indie era veramente ristretto ad un certo tipo di titoli. Quando c'era il titolo indie molto particolare, sto pensando ad esempio a Papo & Yo, di un game designer brasiliano (Vander Caballero ndr), che parlava del suo rapporto con il padre alcolizzato ma, anche parecchi anni fa, le perle erano poche, perché purtroppo la produzione di un certo tipo di giochi costa veramente cara.
Raffaele: Hai ragione, io penso sempre a robe come Paper Please...
Alessandra: ...o anche solo Lake. Cioè, non parlo solo di titoli politici, ma anche titolipoetici che abbiano tutta una serie di sfumature differenti come avviene nel cinema, ma noi siamo ancora molto indietro su questo discorso.
Raffaele: Certo, ci sono poi giochi come This War of Mine che però un passo avanti lo hanno fatto, anche solo perché il team di sviluppo è stato bravo a riproporlo su tante piattaforme. Ma, a questo punto, qual è, secondo te, la percezione dei giocatori quando si trovano davanti un This War of Mine, o un Paper Please. Perché io sono d'accordo con te, l'indie può essere una strada per lo sviluppo culturale e, in questo contesto penso anche a Life is Strange, che nasce per essere una roba super indie e diventa un titolo apprezzatissimo.
Alessandra: Direi che ce n'è voluta di strada, e certa gente ha anche cambiato le recensioni...
Raffaele: LOL, e ok. Ma parliamo del pubblico vero e proprio. Perché, ecco, Life is Strange è stato molto spinto a livello di comunicazione ma, sul versante opposto, Paper Please ha alle spalle un team così piccolo che forse il gioco non è arrivato a tutti quelli che potrebbero apprezzarlo. E dunque: secondo te come si fa a fare comunicazione e cultura senza budget?
Alessandra: Come ho detto: quando si abbasseranno i costi di produzione, questi team avranno più budget per fare un po' di pubblicità ma la questione, ribadisco ancora, è esattamente come per il cinema. Perché ha funzionato Life is Strange? Perché aveva un impatto visivo molto forte? No sembrava un giochino. E quel gioco è caro, molto caro. Però quando si potranno fare giochi di quel genere o comunque con quel tipo di grafica e quel tipo di appeal ad un costo più basso, il mercato si svilupperà molto di più in quel tipo di direzione.
Raffaele: ti faccio un'ultima domanda, tornando anche al discorso originale, ovvero al “videogame come strumento di emancipazione culturale”. Tu cosa ti auspichi visto che il percorso è ancora lungo? Intendo: cosa ti auspichi come professionista, con tutto quello che sta succedendo nel mondo, nei prossimi cinque anni? Ho scelto cinque anni perché, oggi come oggi, lo ritengo il tempo minimo di una media generazione console, e il tempo di sviluppo utile affinché esca almeno un titolo di grosso calibro che, se non cambia le carte in tavola, genera un eco abbastanza lungo.
Alessandra: Anzitutto: vorrei che il prossimo GTA avesse un personaggio femminile di quelli veramente cattivi. Ma veramente bastardi. Una cosa proprio, che da donna ti dia fastidio giocarla. Ma proprio un personaggio così sgradevole che ti faccia dire; "ma no io non ci voglio giocare con lei" e lo dici da uomo o da donna. Ovviamente, vorrei che fosse anche contestualizzata come cosa, e credo che se c'è qualcuno che possa farlo sia proprio Rockstar. Vorrei che qualcuno creasse un personaggio che mi estendesse a tutto il gioco quella sensazione di “disagio” che, ad esempio, ho provato nello scontro tra Abby e Ellie in The Last of Us 2, in cui mi dicevo che certe cose proprio non volevo farle, ma ho dovuto farle lo stesso.
Raffaele: Ok, ma perché?Alessandra: Perché cambierebbe completamente la percezione rispetto al tema uomo/donna e quello che possono o non possono fare. Sarebbe una cosa così forte che ti farebbe riflettere, che ti farebbe male, e sarebbe bello se succedesse. Inoltre, mi auspico che i grandi cambiamenti non siano solo frutto dei titoli indie, perché non può esserci solo un team come Playdead che faccia determinate cose, e penso che sia ora che altri si sforzino di creare titoli più politici, come è successo in Detroit: Become Human, anche se lì certe scene sono poi smorzate, come se Cage non avesse voluto spingersi oltre. La fantascienza, in questo senso, è uno strumento ottimo, perché ha sempre illustrato a dovere ciò che sarebbe potuto diventare il nostro presente. Ma soprattutto, vorrei che tutti questi grossi game designer, abbiano non solo il coraggio di proporci delle scelte forti, ma anche che mostrinoquelle che sono le conseguenze estreme di certe scelte, senza il timore di “doversi fermare prima” per paura di quella che potrebbe essere la reazione del pubblico. Perché anche i videogame devono avere il coraggio di parlare degli orrori del nostro presente, ma il timore è sempre che certe scelte non paghino in termini di vendite. Vorrei che se ne fregassero e dicessero: “Sì, ho fatto questo gioco così, per rappresentare la realtà fino in fondo. Non vuoi giocarlo? Va bene, non mi importa”. Perché tanto alla fine li giocheremmo comunque tutti, e forse ci lasceremmo dentro anche un pezzo di noi stessi.
Conclusioni
Insomma: il videogame ha le carte in regola per essere considerato uno strumento culturale? Può creare emancipazione? Può portare ad un messaggio che vada oltre quello che effettivamente si vede, ovvero un mare di poligoni e pixel?
La risposta è indubbiamente sì, così come ci è stato anche confermato dalle 3 professioniste coinvolte in questo articolo. Anzi, col passare del tempo è sempre più probabile che il videogame raffini il suo modo di comunicare ed arrivi con il proprio potente messaggio anche a chi, per motivi anagrafici, geografici o culturali non ha alcun interesse nel conoscerlo.
Strano a dirsi, esiste lì fuori una cerchia ancora immensa di persone che non solo non ritengono il videogame un oggetto degno di nota (parliamo quindi di una concezione a monte, che viene ancor prima di un'eventuale considerazione artistica o culturale) ma, soprattutto, ritengono che esso sia addirittura nocivo, se non deleterio, per le nuove generazioni.
Ovviamente questa è una concezione non solo sbagliata, ma anche triste, perché dettata solo ed esclusivamente dal pregiudizio, che impedisce, al pari di un film o di un buon libro, di godere di opere che, anche solo per il loro impatto emotivo, meriterebbero senza dubbio di essere giocate e vissute da tutti.
Per fortuna, a forza di provarci, sia per motivi autoriali, che per mere questioni di quello che è lo sviluppo della comunicazione umana, che raramente tende a fossilizzarsi, specie se immersa in un contesto culturalmente ricco e vivace (come è quello del mercato del videogioco), ci sono buone speranze che nel giro di una generazione certi bias vengano definitivamente aboliti, e tutti impareranno non solo a convivere, ma anche a godere, di opere piccole e grandi, spesso magnifiche.