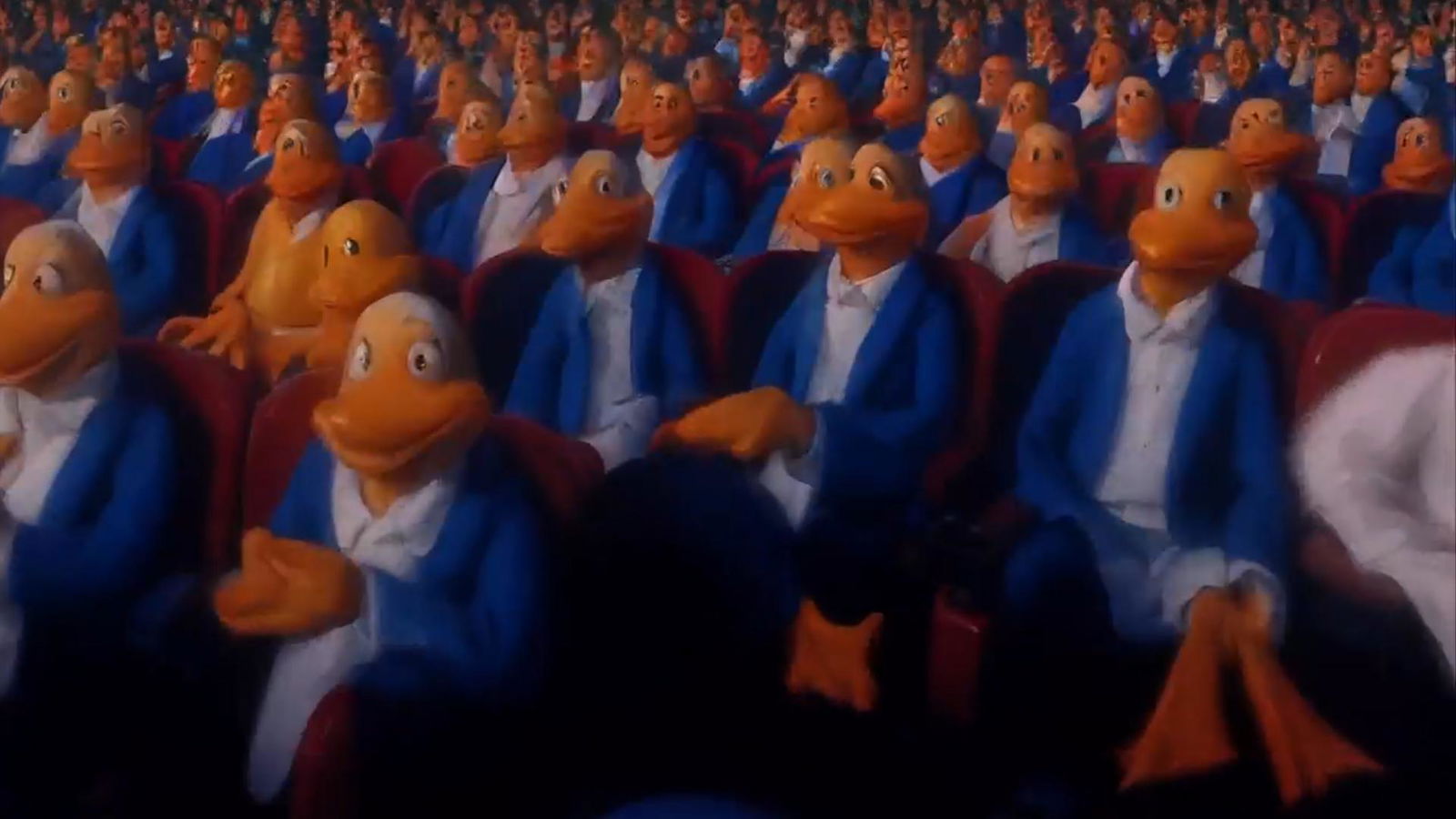I ricercatori dell'Università di Oxford hanno finalmente svelato un enigma archeologico che durava da settant'anni, riuscendo a identificare con certezza il contenuto misterioso di otto antiche giare greche rinvenute in un santuario funerario presso Paestum. Grazie alle moderne tecniche di analisi chimica, quello che per decenni era stato classificato come grasso animale o vegetale contaminato si è rivelato essere miele antico, conservato per oltre 2.500 anni all'interno di contenitori di bronzo. La scoperta non solo rappresenta un trionfo della scienza moderna applicata all'archeologia, ma offre anche preziose informazioni sui rituali religiosi e le credenze sulla vita dopo la morte nell'antica Grecia.
Il mistero delle giare di Paestum
Nel 1954, gli archeologi portarono alla luce un santuario funerario greco risalente al 520 a.C. circa, situato a Paestum, una città della Magna Grecia a circa 70 chilometri a sud di Pompei. All'interno del sito sacro furono rinvenute otto giare contenenti un residuo appiccicoso di natura sconosciuta. Per oltre mezzo secolo, questo materiale ha rappresentato un vero rompicapo per gli studiosi, che tentarono ripetutamente di identificarne la composizione utilizzando le tecnologie disponibili all'epoca.
Tra gli anni '50 e '80, tre diverse équipe di ricerca si cimentarono nell'analisi del contenuto, arrivando tutte alla medesima conclusione errata. I test di solubilità, unici strumenti a disposizione dei ricercatori di quel periodo, suggerivano che si trattasse di grassi di origine animale o vegetale, probabilmente contaminati da polline e frammenti di insetti.
La svolta tecnologica che ha cambiato tutto
Luciana Carvalho e il suo team dell'Università di Oxford hanno affrontato il mistero con un approccio completamente diverso, sfruttando le potenzialità delle moderne tecniche analitiche. Il primo passo è stato l'utilizzo della spettroscopia a infrarossi, che analizza come i materiali riflettono la luce infrarossa per determinarne la composizione generale. Inizialmente, i risultati sembravano confermare l'ipotesi della cera d'api degradata, dato l'aspetto esteriore simile alla cera moderna e l'elevata acidità del campione.
La vera rivelazione è arrivata con l'impiego della gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa, una tecnica sofisticata che ha permesso di identificare la presenza di glucosio e fruttosio, i principali zuccheri contenuti nel miele. "Abbiamo scoperto una miscela sorprendentemente complessa di acidi e zuccheri degradati", spiega Carvalho. "La pistola fumante per il miele è stata trovare gli zuccheri proprio nel cuore del residuo".
Le prove definitive dell'origine apistica
L'analisi condotta da Elisabete Pires, anch'essa dell'Università di Oxford, ha fornito le prove definitive dell'origine del materiale. Nel residuo sono state identificate proteine specifiche chiamate proteine della pappa reale, secrete esclusivamente dalle api mellifere durante la produzione del miele. Ma la scoperta più intrigante è stata quella di alcuni peptidi la cui corrispondenza più vicina è risultata essere il Tropilaelaps mercedesae, un acaro parassita che si nutre delle larve delle api.
Secondo Pires, questo parassita si ritiene abbia avuto origine negli alveari asiatici, il che suggerisce che "i frammenti proteici trovati nel residuo sono probabilmente correlati a un altro tipo di parassita che già colpiva gli alveari nell'antica Grecia". Questa scoperta offre uno spaccato inaspettato sulla paleobiologia degli insetti e sui problemi che affliggevano l'apicoltura nel mondo antico.
Il processo di conservazione attraverso i millenni
La trasformazione del miele originale nel residuo ceroso e acido trovato dagli archeologi è il risultato di un lento processo di degradazione durato oltre due millenni. Carvalho spiega che i sigilli di sughero delle giare di bronzo si sono inevitabilmente deteriorati nel tempo, permettendo l'ingresso di aria e microorganismi. "Riteniamo che quei batteri abbiano consumato la maggior parte degli zuccheri rimasti, producendo acidi aggiuntivi e prodotti di decomposizione", precisa la ricercatrice.
Nel corso dei secoli, ciò che è rimasto del residuo originale si è trasformato in una sostanza acida e cerosa depositata sul fondo e lungo le pareti delle giare. Questo processo di fossilizzazione chimica ha paradossalmente permesso la conservazione di tracce molecolari sufficienti per l'identificazione moderna, rendendo possibile questa straordinaria scoperta archeologica.
Uno sguardo sui rituali funerari dell'antica Grecia
La conferma che le giare contenevano miele ha implicazioni che vanno ben oltre l'aspetto puramente scientifico. Come sottolinea Carvalho, "confermare le offerte di miele in un santuario a Paestum ci dice esattamente come le persone sceglievano di onorare le loro divinità e quali idee avevano sulla vita dopo la morte". Il miele era considerato un alimento sacro nel mondo antico, simbolo di purezza e immortalità, spesso utilizzato nei rituali religiosi e nelle cerimonie funebri.
Questa scoperta arricchisce la nostra comprensione delle pratiche religiose nella Magna Grecia e dimostra come la scienza moderna possa continuare a svelare i segreti del passato, anche quando sembrano definitivamente perduti nel tempo.