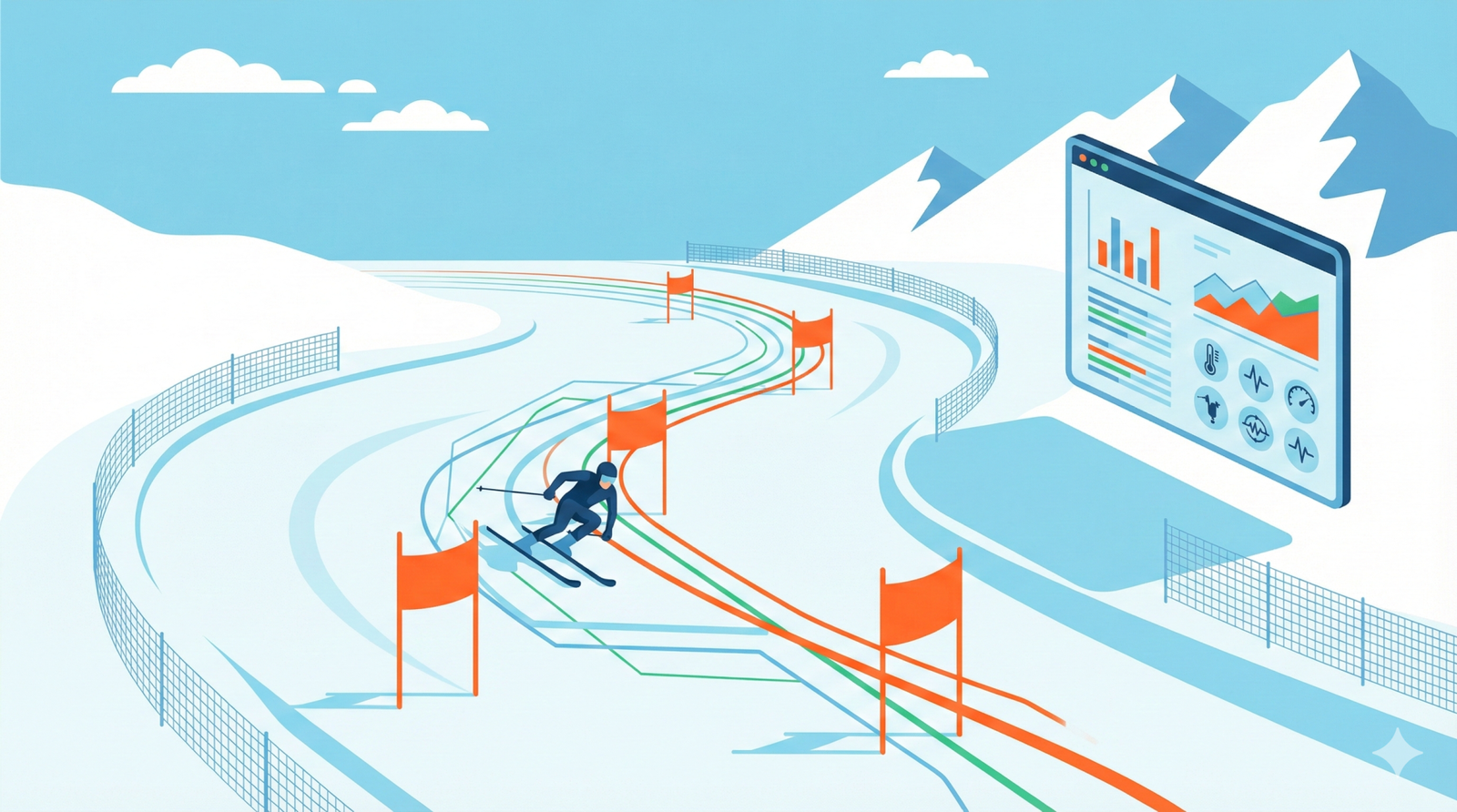All'interno dei laboratori dell'Institute of Science and Technology Austria (ISTA), un team di fisici sta utilizzando la luce laser come strumento di indagine per decifrare uno dei fenomeni atmosferici più spettacolari e meno compresi del nostro pianeta: la formazione dei fulmini. La ricerca, pubblicata di recente sulla prestigiosa rivista Physical Review Letters, rappresenta un passo avanti significativo nello studio dell'elettrificazione delle nubi, un processo che da decenni sfida la comprensione completa della comunità scientifica. Nonostante l'enorme potenza visibile delle scariche elettriche atmosferiche, i meccanismi fisici che innescano il primo bagliore rimangono avvolti nel mistero, con teorie concorrenti che spaziano dal ruolo dei raggi cosmici alle proprietà elettriche dei cristalli di ghiaccio.
L'approccio sperimentale sviluppato dal gruppo guidato dall'Assistant Professor Scott Waitukaitis, in collaborazione con l'ex ricercatore postdoc Isaac Lenton, si basa su una tecnologia raffinata nota come pinzette ottiche. Utilizzando due fasci laser verdi che si intersecano in un punto preciso all'interno di una camera sigillata, i ricercatori riescono a intrappolare singole particelle di aerosol e mantenerle sospese per periodi prolungati, che oggi raggiungono anche diverse settimane. Questa capacità di confinamento rappresenta un traguardo tecnico notevole: le prime catture, avvenute circa due anni fa, permettevano di trattenere le particelle per appena tre minuti prima che sfuggissero dalla trappola luminosa.
Gli aerosol atmosferici costituiscono un universo microscopico eterogeneo che comprende goccioline liquide e particelle solide con dimensioni che variano su diversi ordini di grandezza. Dal polline primaverile visibile a occhio nudo fino ai virus influenzali, passando per i cristalli di sale trasportati dalle brezze marine, queste entità sospese giocano ruoli cruciali nella fisica dell'atmosfera. Nel contesto della formazione dei fulmini, particolare attenzione è rivolta ai cristalli di ghiaccio che popolano le nubi temporalesche, dove le collisioni ripetute tra particelle di dimensioni diverse generano un accumulo progressivo di carica elettrica.
Andrea Stöllner, dottoranda che lavora congiuntamente nei gruppi Waitukaitis e Muller dell'ISTA, ha sviluppato un protocollo sperimentale che utilizza sfere di silice trasparente come modelli dei cristalli di ghiaccio naturali. Queste particelle, di dimensioni micrometriche, permettono di studiare in condizioni controllate i processi di elettrificazione che avvengono spontaneamente nell'atmosfera. L'apparato sperimentale richiede una stabilità estrema: il tavolo su cui è montato produce un sibilo continuo, segno del sistema di sospensione pneumatica che isola i componenti ottici da qualsiasi vibrazione esterna, anche minima, che potrebbe compromettere la precisione delle misurazioni.
La scoperta più sorprendente della ricerca riguarda il meccanismo di carica indotto dal laser stesso. Inizialmente concepito per analizzare come l'umidità modifichi le proprietà elettriche degli aerosol, l'esperimento ha rivelato un fenomeno inatteso: i fotoni del laser interagiscono con le particelle attraverso un processo bifotonico. In condizioni normali, gli elettroni orbitano attorno ai nuclei atomici mantenendo le particelle elettricamente neutre. Tuttavia, quando due fotoni raggiungono simultaneamente la particella e vengono assorbiti in un unico evento quantistico, possono fornire energia sufficiente a espellere un elettrone. Questo processo, ripetuto nel tempo, accumula progressivamente carica positiva sulla particella.
La capacità di modulare la potenza del laser offre ora ai ricercatori un controllo senza precedenti sul tasso di elettrificazione. Stöllner e colleghi possono osservare in tempo reale l'evoluzione dello stato di carica di una singola particella, dalla neutralità iniziale fino a valori elevati di carica positiva. Parallelamente all'accumulo, il team ha documentato eventi improvvisi di scarica spontanea, durante i quali la particella rilascia rapidamente parte della carica accumulata. Questi episodi transitori potrebbero rappresentare analoghi in scala ridotta dei processi che avvengono naturalmente nelle nubi temporalesche, dove cristalli di ghiaccio carichi potrebbero contribuire all'innesco delle scariche elettriche.
Le teorie attuali sulla genesi dei fulmini si dividono principalmente in due filoni. Il primo propone che le collisioni tra cristalli di ghiaccio e aggregati più grandi (grandine) trasferiscano carica elettrica progressivamente, fino a creare un campo elettrico così intenso da ionizzare l'aria circostante. Il secondo attribuisce ai raggi cosmici il ruolo di iniziatori, poiché le particelle cariche generate dal loro passaggio attraverso l'atmosfera potrebbero accelerare nel campo elettrico già presente, innescando valanghe elettroniche. Il paradosso centrale, sottolineato da Stöllner, è che secondo le misurazioni disponibili il campo elettrico interno alle nubi appare troppo debole per avviare autonomamente il processo di ionizzazione necessario alla formazione del fulmine.
La nuova configurazione sperimentale permette di testare la prima ipotesi esaminando in dettaglio la dinamica di carica delle particelle modello. Sebbene i cristalli di ghiaccio naturali presenti nelle nubi abbiano dimensioni molto superiori rispetto alle sfere di silice utilizzate in laboratorio, comprendere i meccanismi fondamentali su scala micrometrica potrebbe illuminare i processi macroscopici. L'osservazione di scariche spontanee nelle particelle confinate suggerisce che fenomeni analoghi, amplificati dalle dimensioni e dal numero di cristalli coinvolti nell'atmosfera reale, potrebbero generare microscopiche scintille che fungono da nuclei di ionizzazione per le grandi scariche elettriche.
Lo sviluppo della tecnica ha richiesto quasi quattro anni di ottimizzazione, trasformando un sistema instabile che tratteneva particelle per pochi minuti in uno strumento capace di mantenere il controllo per settimane intere. Questa evoluzione tecnologica apre prospettive di ricerca che vanno oltre lo studio dei fulmini, estendendosi alla comprensione generale dei processi di elettrificazione atmosferica e al ruolo degli aerosol nella fisica delle nubi. I prossimi passi includeranno esperimenti con particelle di ghiaccio vero e proprio, più vicine alle condizioni reali delle nubi temporalesche, e l'analisi quantitativa delle energie coinvolte nei processi di scarica osservati.




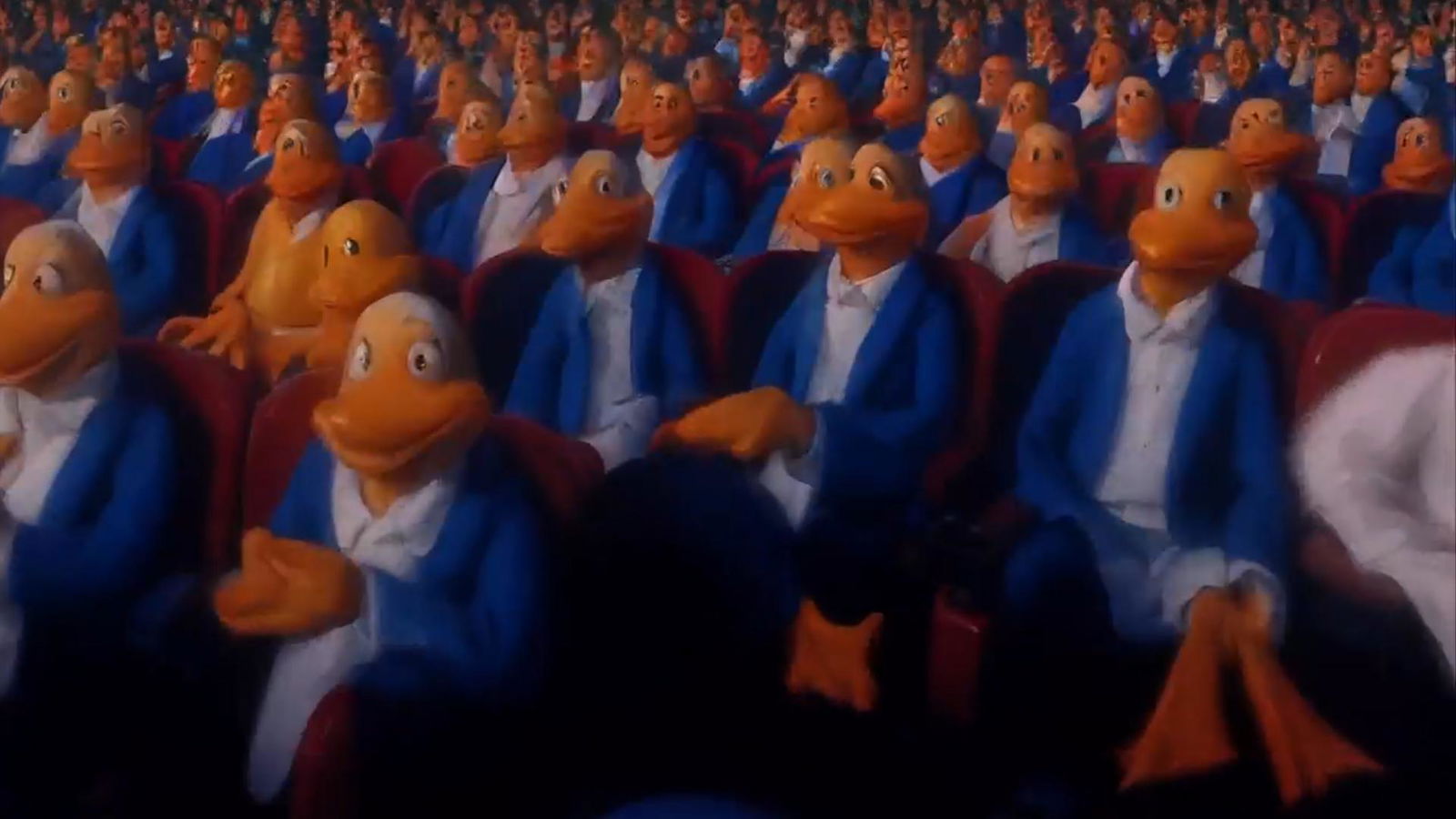
.jpg)