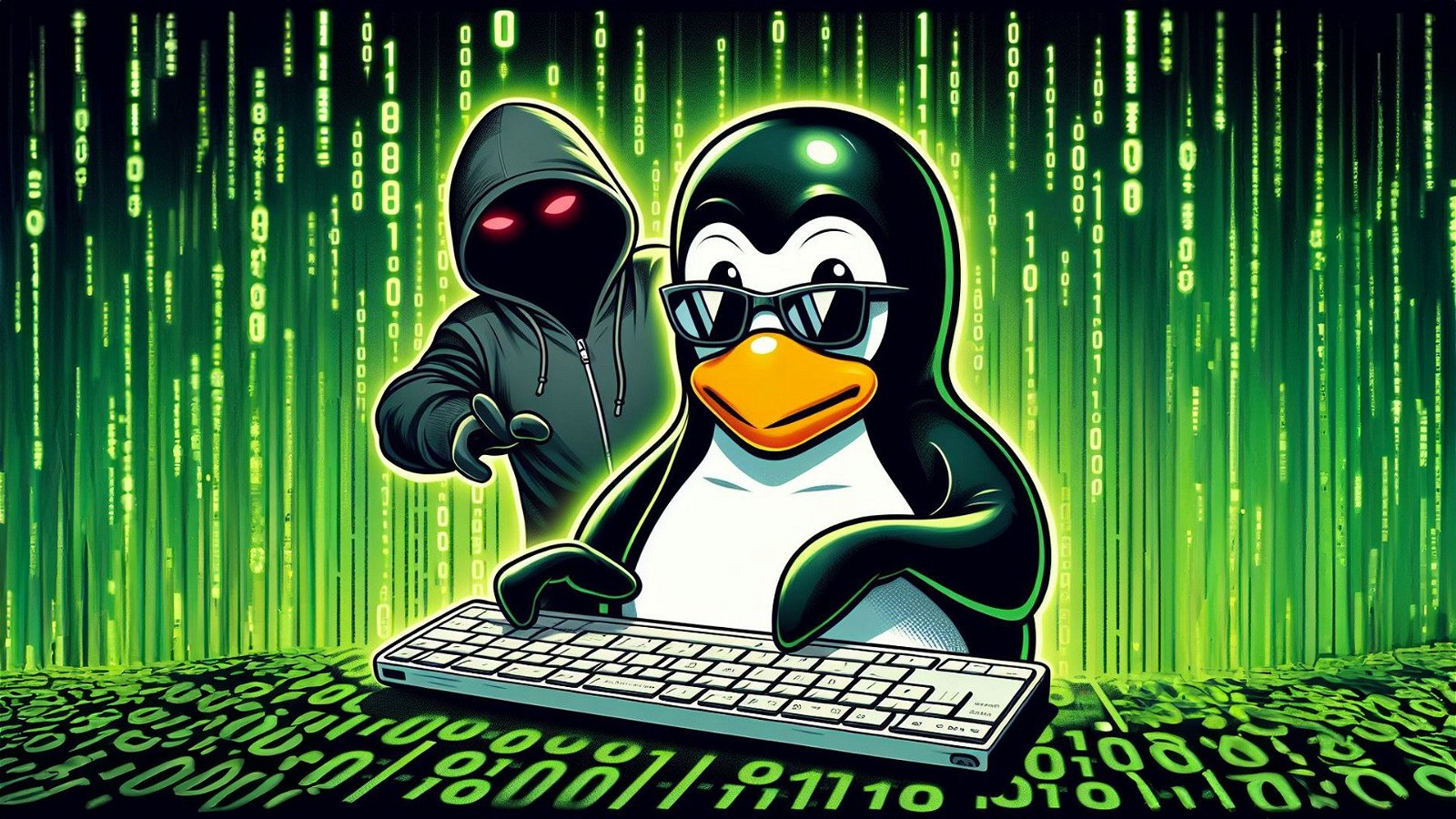Nel sottosuolo terrestre, quando un fluido meno viscoso spinge un fluido più denso attraverso mezzi porosi come le rocce, si genera un fenomeno tanto affascinante quanto problematico: il viscous fingering, o "digitazione viscosa". Questo processo crea strutture ramificate imprevedibili, simili a dita che si allungano in modo caotico, rappresentando da decenni una sfida cruciale per applicazioni che spaziano dal recupero avanzato di petrolio alla cattura geologica dell'anidride carbonica, fino alla bonifica delle falde acquifere contaminate. La difficoltà nel prevedere e controllare questi pattern complessi ha limitato l'efficacia di tecnologie fondamentali per la transizione energetica e la tutela ambientale, ma una nuova ricerca dell'Università della California del Sud promette di ribaltare completamente questo scenario grazie all'intelligenza artificiale.
Birendra Jha, professore associato presso la USC Viterbi School of Engineering, ha guidato un team che ha sviluppato un framework di deep learning rivoluzionario, presentato sulla rivista Physical Review Fluids. Il metodo supera i limiti delle tradizionali simulazioni numeriche dirette (DNS), che per quasi un secolo hanno faticato a modellare accuratamente la dinamica caotica e non lineare di questi flussi. Le DNS richiedono risorse computazionali enormi: lo stesso Jha ricorda che una simulazione per uno studio del 2011 impiegò ben due mesi per essere completata, un tempo del tutto incompatibile con le esigenze industriali.
Il cuore innovativo dell'approccio risiede nell'integrazione di due tecnologie complementari. La prima è lo "spatial embedding", una tecnica in cui una rete neurale chiamata autoencoder viene addestrata a riconoscere e semplificare i pattern complessi multi-scala delle strutture digitiformi, comprimendoli in una sorta di firma digitale sintetica. È come insegnare a un computer a riconoscere la "calligrafia" unica di ciascuna ramificazione mentre si forma e cresce nel mezzo poroso.
Il vero salto qualitativo arriva con l'implementazione delle dinamiche temporali basate sull'operatore di Koopman, un concetto matematico avanzato che permette all'intelligenza artificiale di comprendere le regole fondamentali che governano l'evoluzione temporale di questi pattern. Invece di confrontarsi direttamente con il comportamento caotico e non lineare dei fluidi, l'operatore di Koopman trasforma il problema in un sistema lineare più semplice, operando in uno spazio matematico differente. Questa trasformazione consente previsioni future straordinariamente accurate, anche per flussi altamente imprevedibili.
Mohammed Alasker e Ramdhan Wibawa, studenti di dottorato coautori dello studio, hanno collaborato alla raccolta e preparazione di dati di alta qualità per l'addestramento dell'AI. Il risultato ha superato le aspettative: il modello non solo riproduce accuratamente fenomeni fisici complessi come la divisione di una singola "dita" in due ramificazioni, la successiva fusione e coalescenza delle strutture nel tempo, e tutti i processi di miscelazione nel dominio fluido, ma corregge anche errori numerici intrinseci ai metodi tradizionali.
Una scoperta particolarmente significativa riguarda proprio questo aspetto qualitativo. Nelle regioni occupate dal fluido meno viscoso, dove la presenza del fluido più denso dovrebbe essere fisicamente assente, le DNS mostrano spesso "macchie" spurie dovute a errori numerici. Il nuovo approccio elimina completamente questi artefatti, dimostrando un'accuratezza superiore rispetto ai metodi computazionali convenzionali, non solo una maggiore velocità di calcolo.
Le implicazioni pratiche si estendono ben oltre il settore energetico e ambientale. Jha sottolinea che il framework potrebbe rivoluzionare applicazioni farmaceutiche e biomediche, in particolare nei dispositivi microfluidici utilizzati per testare nuovi farmaci contro biofluidi come sangue o sudore. Questi dispositivi miniaturizzati, pur non operando in mezzi rocciosi, sono soggetti agli stessi fenomeni di digitazione viscosa quando fluidi con viscosità differenti interagiscono negli spazi microscopici, dato che la fisica sottostante rimane identica.
Il team di ricerca sta ora lavorando per raffinare ed espandere i modelli, incorporando dataset di addestramento più ampi che includano una maggiore varietà di condizioni geologiche e tipologie di roccia sotterranea. L'obiettivo è creare uno strumento predittivo universale, applicabile a scenari sempre più complessi e realistici. Questa linea di sviluppo potrebbe rendere finalmente praticabile il controllo preciso dei flussi sotterranei, un requisito essenziale per lo stoccaggio geologico di CO₂ su larga scala, necessario per contenere il cambiamento climatico, e per ottimizzare l'estrazione sostenibile di risorse energetiche.