Ok, parliamo di avvenute grafiche. Quelle cosiddette 2.0. Quanto sono belle?
Per una parte del mercato, moltissimo. Per una ben più vasta parte del mercato, quella più concentrata su titoli che fanno dell’interazione e della mole di contenuti un metro di valutazione essenziale, sono il male assoluto.
Se fai parte della prima fetta, come me, e comprendi quel fascino generato dalla sensazione di essere parte di una storia cinematografica che dipende dalle tue scelte, allora in questo articolo sei nel posto giusto.
Il genere che ha fatto la fortuna di sviluppatori come Telltale, e basato sulle intuizioni di studi di sviluppo storici come Quantic Dream, negli anni ha saputo percorrere il suo percorso, fatto di una ascesa repentina, con esiti similari a quelli di una bolla economica, ora esplosa, dato il sempre minor numero di studi disposto ad avventurarsi nell’esplorazione di questo genere. Disfacimento che ha generato anche vittime illustri: noi giocatori, in primis, costretti a vedere ben poche IP provare a farsi largo nel mercato di massa, con notevoli stenti. Quest’estate sembra essere un’anomalia, con ben due titoli in grado di provare a farsi notare dai giocatori che preferiscono il pad alle spiagge (“Under The Waves” e “The Expanse”). Ma la storia recente ci ha abituato a vedere un piatto dalla portata decisamente più ridotta.
Eppure questi titoli sono portatori di una misto di caratteristiche uniche che traggono forza e elevano le più distintive caratteristiche di due medium all’apice del loro splendore, quello cinematografico e quello videoludico; opere in grado di sfruttare l’interazione quanto basta per massimizzare il coinvolgimento del giocatore in una narrazione abilmente diretta. Narrazione che il giocatore contribuisce a tessere, magari scegliendo solamente il dialogo A al posto del dialogo B, o optando per interazioni mirate, ma che riescono a diventare un collante efficacissimo tra opera e fruitore, in cui ci si trova inevitabilmente invischiati, e a cui non si riesce a dire basta, perché la narrazione non si ferma a sufficienza, non viene mai spezzata da un gameplay che rimane un protagonista secondario e felice. Proprio grazie a questo effetto (una esponenzializzazione degli effetti droganti delle nostre serie TV preferite) alcuni momenti diventano iconici: riescono a entrarti dentro, e scandiscono inconsapevolmente le evoluzioni stesse di un genere che ti sei ritrovato a sentir maturare insieme a te. Ripassiamo insieme alcuni dei momenti che ci hanno fatto innamorare di loro.
Fahrenheit, David Cage e un mercato non ancora pronto
L’amore per quello che era ancora una sorta di prototipo per le avventure grafiche che sarebbero nate a seguire risponde probabilmente al nome e cognome di David Cage, e quel suo strano progetto chiamato “Fahrenheit”, titolo uscito nell’era Playstation 2/Xbox, spaccato di un’epoca che di roba così smaccatamente cinematografica ancora non ne aveva vista. Il titolo era sbarcato in un mercato che probabilmente ancora non poteva dirsi propriamente pronto per giudizi di questo tipo. E proprio questi, i giudizi, infatti, non tardarono a mostrarsi impreparati nel cogliere quel nuovo e strano modo di intendere il rapporto fra narrazione e interazione. Solo pochi premiarono compiutamente quello che a oggi viene considerato un piccolo cult, un’opera sfrontatamente seminale in termini di grammatiche narrative, per quelli che sarebbero stati i suoi successori (sviluppati sempre da Quantic Dream) che invece diventarono dei veri e propri best seller in grado di far decollare propriamente il rapporto fra mondo cinematografico e ambiente videoludico.
Ma quella neve: la neve che opprimeva e faceva da contorno a tutta la vicenda, e quella “Santa Monica” (brano dei “Theory of a Dead Man”) che arrivava a chiudere il sipario fra i titoli finali, rimangono qualcosa di letteralmente indimenticabile; un po’ perché il ricordo si inserisce in un periodo della mia vita molto “romantico”, in cui prendevo consapevolezza del valore delle arti nel mondo, e ritrovarle così vividamente riconoscibili e abilmente mixate in qualcosa che all’epoca era ancora “solo un videogioco” aveva un effetto clamorosamente stimolante, ed era capace di sviluppare pensieri avanguardistici, in grado di andare oltre la narrazione che all’epoca circondava il nostro medium. Un po’, invece, per il gioco in sé, che con le sue atmosfere da “supernatural thriller” riusciva a tenerti in tensione per quasi tutta la vicenda (salvo poi mandare tutto alle ortiche, ma sappiamo che le avanguardie non nascono perfette per antonomasia).
TellTale, The Walinkg Dead e le avventure grafiche 2.0
Un secondo turning point di rilievo avviene inevitabilmente con The Walking Dead di TellTale. Sei praticamente lì, in un momento storico in cui ancora i videogiochi non avevano narrato al grande pubblico storie che mettessero al centro il rapporto intimo e viscerale “padre-figlio/a” (leggasi pre The Last of Us), e arriva lui: una produzione tie-in, con tutti i pregiudizi fortemente negativi che solitamente ciò comporta. Un’uscita pure un po’ in sordina (considerando i precedenti lavori dello sviluppatore, non certo memorabili) per l’adattamento della celebre opera seriale e fumettistica che, proprio in quel momento, stava scombussolando l’alto lato del mondo mediatico. E, incredibilmente, accade l’impensabile: il prodotto si presenta vestito di tutto punto. In forma addirittura episodica, caratteristica che per quel momento storico risulta incredibilmente calzante. Corre l’anno 2012 e l’attenzione della platea videoludica non è ancora eccessivamente frammentata: fra serie TV, cinema e videogiochi vige un equilibrio sufficientemente saldo, mentre mobile e streaming preparano silenti la loro definitiva invasione. Tradotto: c’è ancora tutto il tempo di godersi l’attesa, e con l’attesa la crescita dell’hype, proporzionalmente alla crescita di una narrazione capace di rendersi indimenticabile, come il rapporto dei suoi due protagonisti, Clementine e Lee.
TellTale sbarca il lunario, consolidando una formula che intorpidisce ulteriormente il gameplay e regala una direzione cinematografica sontuosa, appena appena stimolata da enigmi ambientali minimali, ma in grado di tenere buona compagnia, come un ottimo vino da pasto. Con questo titolo diviene chiaro e lampante un assunto: se al giocatore viene servita un’ottima storia, e un’ottima ramificazione delle linee di dialogo, c’è un intero nuovo genere che si può cavalcare, senza per forza intralciarsi con il lavoro di Quantic Dream, che continua a sviluppare la sua personale visione di queste contaminazioni videoludiche e cinematografiche, molto più orientate al fotorealismo. The Walking Dead, nonostante uno sviluppo poi proseguito non in maniera idilliaca, non può che annoverarsi fra i migliori ricordi videoludici per chi apprezza le narrazioni intimistiche. Perché sentirsi così piccoli, e lasciare la mano che ci ha guidato attraverso l’inferno, è una scelta che è costata un pezzo di cuore a tutti.
Life is Strange, Dontnod e la sperimentazione con i teen drama
Mentre il testimone di questo genere in ascesa rimane saldo nelle mani di TellTale (in un percorso di ingigantimento progressivo che però porterà a una assurda congestione) ecco che abbastanza dal nulla emerge quella meraviglia di “Life is Strange” di Dontnod, sviluppatore che aveva già fatto capire le sue qualità con quella piccola perla di “Remember Me”. Se il confine intimista tracciato da “The Waliking Dead” è sembrato funzionare, nasce una considerazione spontanea: perché non spostare ulteriormente l’ago della bilancia in suo favore, creando un teen drama a tutti gli effetti? E di quelli più efficaci, per giunta. In grado di mischiare sentimenti adolescenziali turbolenti a una struggente malinconia, con, come ultimo condimento, qualche sano elemento fantastico: il viaggio nel tempo.
Elemento che si inserisce alla perfezione nelle meccaniche stantie del gameplay fondendolo con la narrazione, che diventa così addirittura intrinsecamente plasmabile, pad alla mano. Il giocatore ha così una responsabilità più tangibile rispetto agli effetti delle sue scelte, i bivi narrativi diventano evidenti e più concretamente impattanti. Di tutti i momenti capaci di rendersi particolarmente memorabili però, non è uno dei plot twist legati a una delle scelte più importanti del gioco (vi basti citare il tetto di un palazzo e un personaggio indeciso sul lanciarsi o meno nel vuoto) quello che mi preme rievocare; il cuore va, per così dire, al cuore dell’opera, e riporta a galla proprio i primi minuti dell’avventura, in cui muoviamo la nostra protagonista all’interno del corridoio della High School, in una camminata lenta in cui le piccole vicende tipiche della vita liceale americana che abbiamo imparato a conoscere tramite il cinema si mischiano nella canzone ascoltata proprio dalla nostra protagonista (la splendida “To all of you”, di Syd Matters) creando teen drama vibes a cui è letteralmente impossibile resistere, a coronamento di un lavoro che fa del suo mood generale la sua vera punta di diamante.
Detroit, ancora David Cage, e la fine della corsa
Un ultimo grande brivido, prima di chiudere con una riflessione su questo ultimo decennio che forse, nonostante tutte le ottime premesse, non è riuscito a proseguire nell’evoluzione di un genere che è sembrato a un certo punto scoppiare, come una bolla, o quantomeno mettersi momentaneamente in stallo. In pausa dopo la sua ultima, e forse più importante, testimonianza. Come a voler chiudere il cerchio a cui aveva essa stessa dato avvio, Quantic Dream dopo il mezzo passo falso di “Beyond: two soul” prova a dare nuovamente prova del genio di David Cage sfornando (dopo quasi 8 anni di sviluppo) “Detroit: Become Human”.
Un titolo sicuramente indovinato su più fronti, che incrocia l’esperienza accumulata dal team nel genere, lo impreziosisce con forse una delle migliori prove della tecnologia di motion capture dell’epoca, e riesce a confezionare una storia dai temi forti, attuali (forse ancora di più oggi), dove il giocatore riesce a entrare in empatia con quasi tutti i protagonisti, grazie a una sceneggiatura curata, decisioni morali ottimamente dosate e conseguenze delle proprie azioni difficilmente prevedibili. Fa strano dirlo, ma ciò che rimarrà più inciso nei miei ricordi di giocatore non sta tanto nel gioco (nonostante sia ricco di momenti iconici e visionari) quanto più nella demo tecnica presentata per il reveal del progetto, all’epoca chiamato “Project Kara”: la demo riuscì a creare un vociare mediatico incredibile, capace di scavalcare il giornalismo di genere, accedendo i riflettori del mondo su un’industria che sembrava aver trovato finalmente una maturità a lungo cercata. Un videogioco a cui il termine stesso “gioco” stava stretto, e mostrava quanto il fotorealismo delle produzioni avesse poco da invidiare all’industria hollywoodiana, e ci fossero studi di sviluppo in grado di parlare, con un linguaggio di gaming assolutamente accessibile, a una platea di spettatori sempre più grande, puntando su temi su cui lo stesso cinema si è basato per dare vita ad alcuni dei suoi più importanti capolavori (si pensi a “Blade Runner” o “2001: Odissea nello spazio”).
Eppure, proprio all’apice del suo percorso, è proprio con Detroit (punta di diamante di un ventennio di evoluzioni sul genere) che l’industria sembra poi arenarsi, come se si fosse resa consapevole di non sapere più verso dove dirigere il prossimo passo. Seppur le produzioni non manchino (basti pensare alla nuova TellTale, Dontnod, Deck9 e le produzioni horror di Supermassive Games) l’asticella di questi titoli sembra essersi assestata su formule rodate, con valori produttivi ben ponderati, forse per il timore di incappare in passi falsi, o non incontrare i gusti di un pubblico che nell’ultimo decennio ha dato segnali ambigui. Una platea ampliatasi nei numeri, con bacini di utenti sempre più vasti, ma sempre più recettiva verso contenuti dal valore discutibile, fra Battle Royale e piattaforme GAS che hanno fatto sbandare più di uno studio che pensava di aver correttamente interpretato i tempi.
Forse i tempi moderni non li conosce davvero nessuno; quello che sappiamo di certo è che le belle storie, raccontate con questa formula di gameplay così essenziale ma coinvolgente, hanno sempre la possibilità di farsi notare, dato il non certo altissimo livello di concorrenza e saturazione dello “scaffale”. E che il futuro, fatto di servizi in streaming e giochi lanciati da qualunque piattaforma, può ampliare ulteriormente il bacino dei curiosi, quelli che faticano pad alla mano, ma vogliono immergersi in contenuti che gli chiedano di interagire quanto basta: magari per chi accende il suo Samsung TV e si trova piazzato in home page una avventura già bella che pronta e impacchetta per essere giocata senza che i problemi di lag incidano minimamente sulla bontà dell’esperienza. O forse sarà la VR a dare nuova linfa a questo genere, ampliandone i punti di vista, massimizzando il legame dello spettatore con l’impianto narrativo.
Tante strade, nessuna direzione certa, conseguenze imprevedibili: un destino che sembra uscito direttamente dal gameplay delle avventure che abbiamo già vissuto. E di tutte quelle che verranno, a cui non vediamo già l’ora di prendere parte, qualunque forma esse avranno.









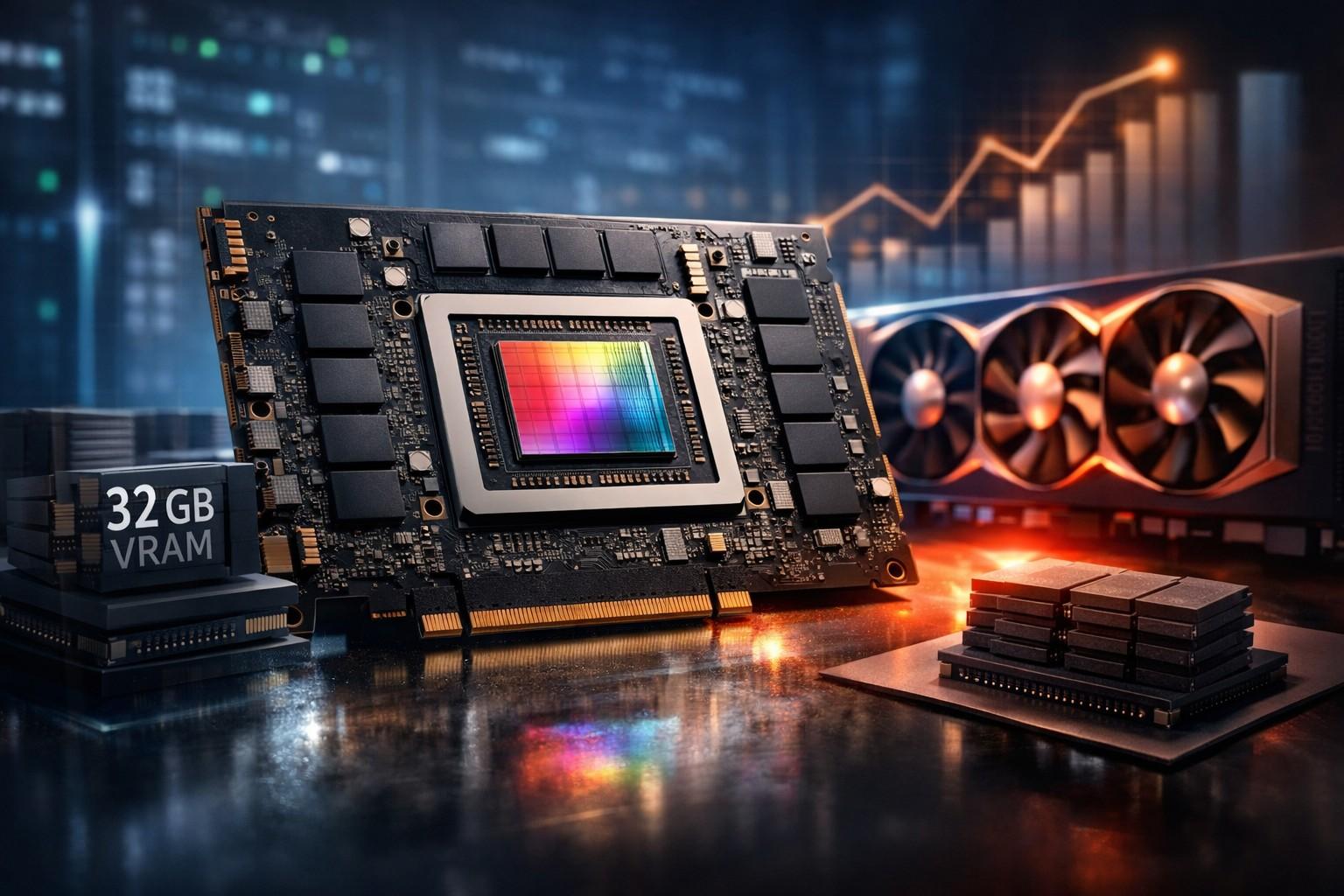

.jpg)
