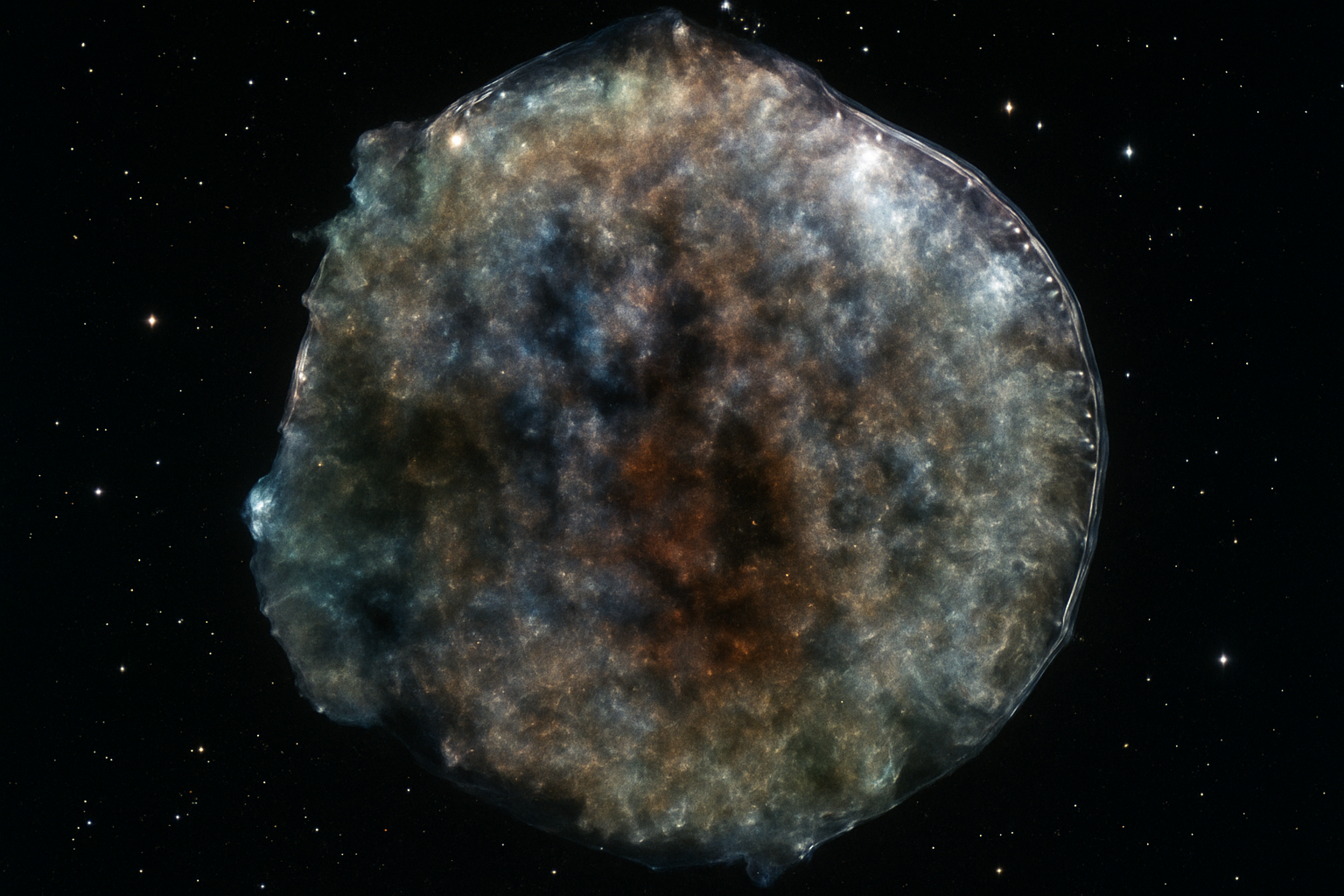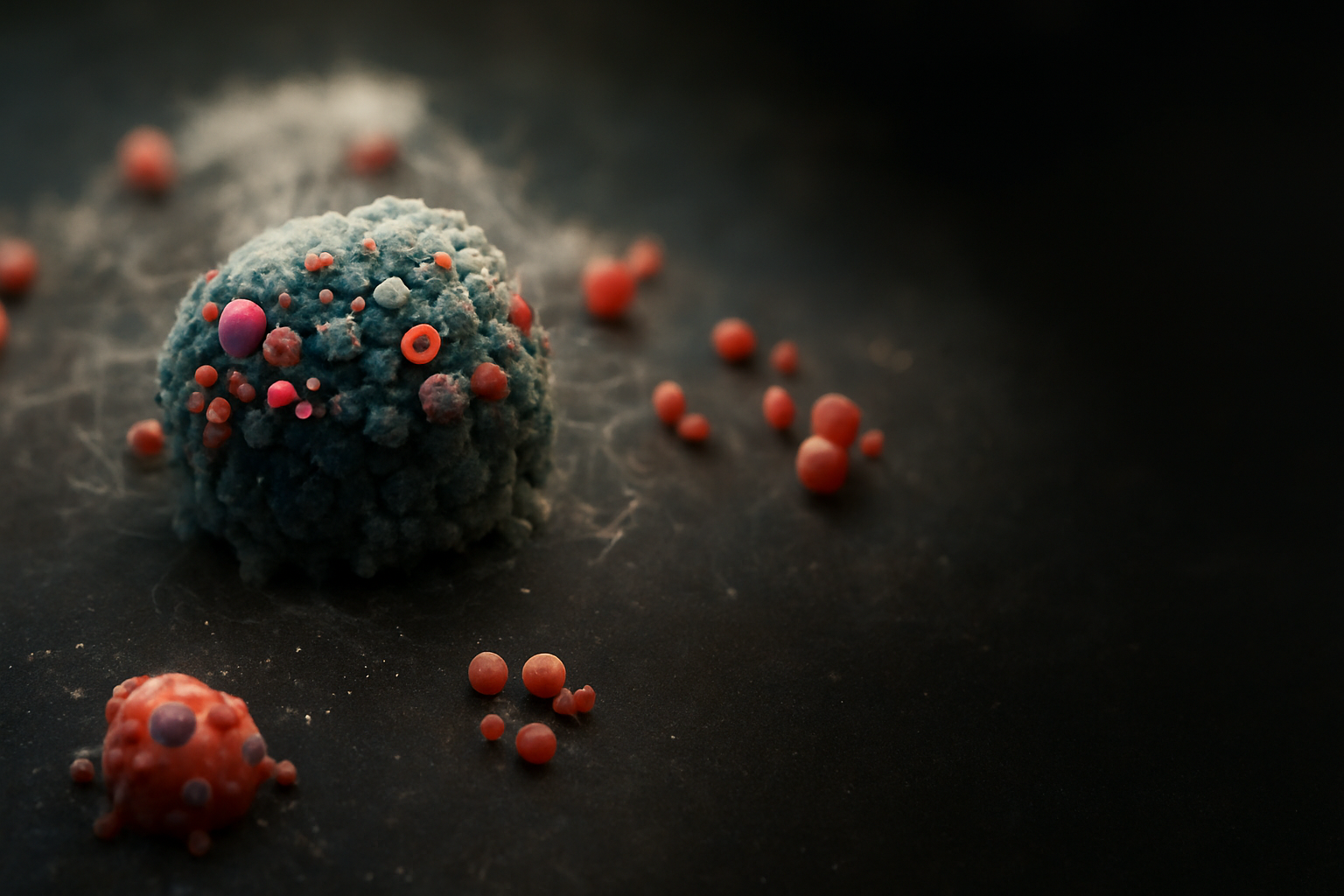Le conseguenze della pandemia di COVID-19 continuano a manifestarsi attraverso il long COVID, una condizione che colpisce milioni di persone nel mondo con sintomi persistenti che durano mesi o addirittura anni dopo l’infezione iniziale. Sebbene la ricerca medica abbia compiuto progressi significativi nella comprensione dei meccanismi biologici alla base di questa sindrome, un nuovo studio condotto dal Mass General Brigham mette in luce un fattore spesso trascurato: i determinanti socioeconomici giocano un ruolo chiave nel definire chi svilupperà questa condizione debilitante. L’analisi, pubblicata su Annals of Internal Medicine, mostra che vivere in condizioni di vulnerabilità sociale aumenta da due a tre volte il rischio di sviluppare il long COVID.
Il peso invisibile delle disuguaglianze
Lo studio ha coinvolto 3.700 partecipanti provenienti da 33 stati americani, Washington D.C. e Porto Rico, tutti colpiti dall’infezione durante l’ondata della variante Omicron tra ottobre 2021 e novembre 2023. I ricercatori hanno analizzato quattro principali categorie di rischio sociale: instabilità economica, barriere nell’accesso all’istruzione e ai servizi linguistici, difficoltà nell’ottenere cure sanitarie adeguate e mancanza di supporto sociale e comunitario.
La dottoressa Candace Feldman, autrice principale dello studio presso la Divisione di Reumatologia del Brigham and Women’s Hospital, spiega: “Durante la pandemia abbiamo osservato il peso schiacciante dei fattori sociali nel determinare chi si infettava e quanto fosse grave o letale la malattia. Volevamo capire se questi stessi fattori influenzassero anche lo sviluppo dei sintomi cronici nel lungo termine”.
Una mappatura dettagliata del rischio
L’approccio metodologico adottato ha permesso di isolare con precisione gli elementi che accrescono la vulnerabilità al long COVID. Tra i fattori individuali più rilevanti emergono l’insicurezza finanziaria e alimentare, la rinuncia alle cure per motivi economici e le esperienze di discriminazione in ambito sanitario. Anche i dati geografici hanno evidenziato correlazioni significative: vivere in abitazioni sovraffollate aumenta sensibilmente il rischio di sintomi prolungati.
I risultati rimangono solidi anche tenendo conto di variabili chiave come il ricovero per COVID-19, la storia vaccinale, la gravidanza, l’età, il sesso, la razza e l’etnia. Un dato particolarmente rilevante è che la presenza di più fattori di rischio sociale corrisponde a un incremento proporzionale della probabilità di sviluppare long COVID.
Le disparità razziali e il common ground del rischio
Uno degli aspetti più interessanti emersi riguarda le disparità razziali ed etniche. Sebbene i gruppi minoritari presentino un carico maggiore di fattori di rischio sociale, l’impatto di questi ultimi sul rischio di long COVID risulta simile tra bianchi, neri e ispanici. Questo suggerisce che le disuguaglianze socioeconomiche - e non differenze biologiche - siano il vero motore delle disparità nella salute post-COVID.
Lo studio, parte dell’iniziativa federale RECOVER (Researching COVID to Enhance Recovery), apre nuove prospettive sulla comprensione di questa sindrome complessa. I ricercatori stanno ora indagando se questi risultati si applichino anche ai bambini affetti da long COVID e se alcuni sintomi siano più fortemente associati a specifici fattori di rischio sociale.
Verso interventi mirati e sostenibili
Le implicazioni pratiche di questi risultati sono rilevanti sia per il sistema sanitario italiano sia per quello internazionale. La dottoressa Elizabeth Karlson, autrice senior dello studio, osserva: “Come per molte altre malattie croniche, diversi aspetti dell’ambiente sociale influiscono sul rischio di sviluppare il long COVID. Gli interventi futuri dovranno tenerne conto per ridurre gli esiti avversi nelle persone più vulnerabili”.
Lo studio sottolinea l’urgenza di un approccio olistico alla gestione del long COVID, che non si limiti al trattamento medico dei sintomi. Affrontare le determinanti sociali della salute - come l’accesso al cibo, la stabilità economica, la qualità dell’abitazione e la parità nell’accesso alle cure - è fondamentale per prevenire e gestire efficacemente una condizione che continua a colpire milioni di persone nel mondo, anche se i tassi di infezione acuta sono in calo.