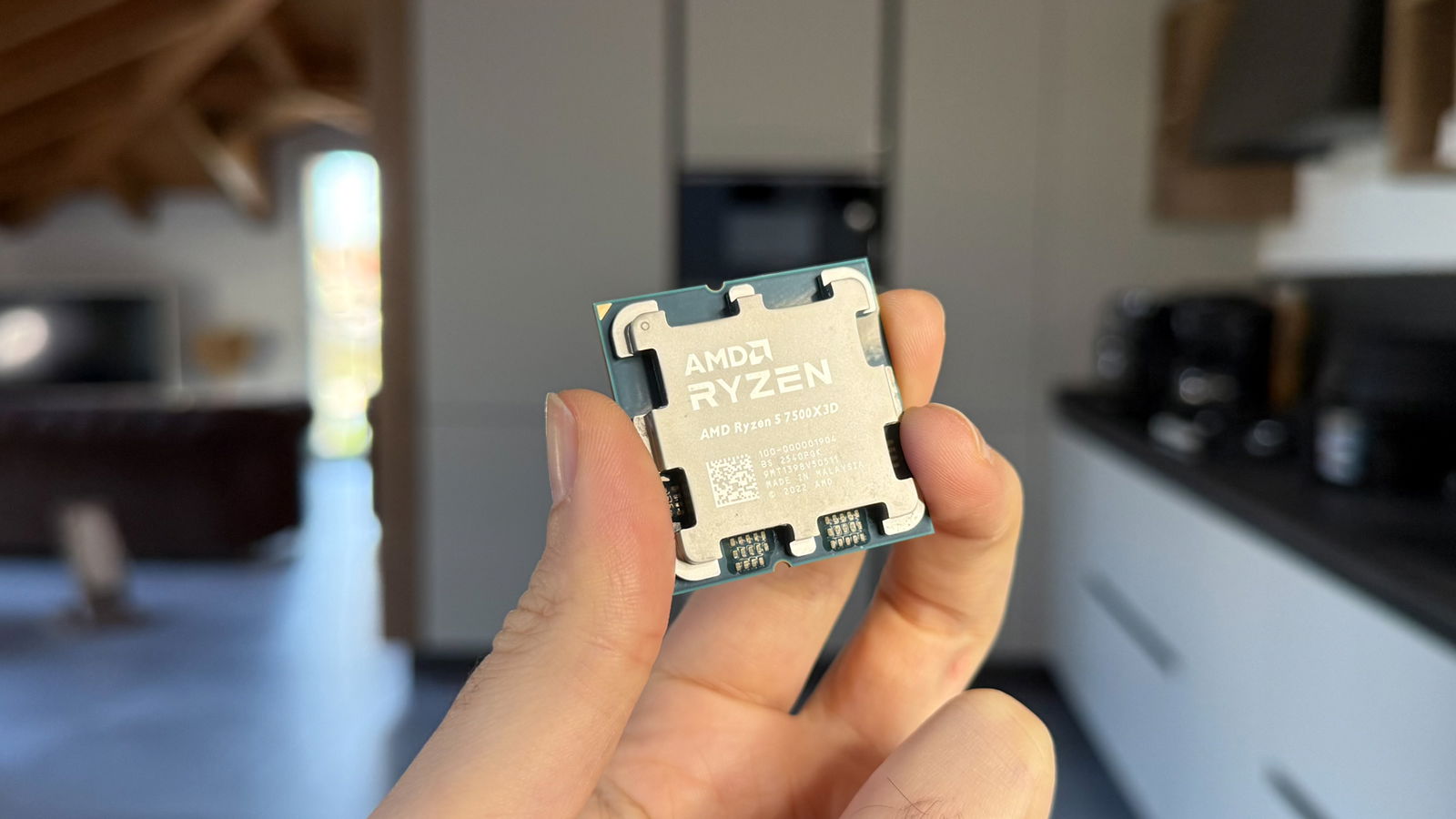Pochi enigmi hanno resistito così a lungo come l'apparente incompatibilità tra i flussi di Taylor-Couette e la teoria universale della turbolenza di Kolmogorov. Dopo decenni di misurazioni sperimentali che sembravano contraddire uno dei pilastri della fluidodinamica moderna, un gruppo di ricercatori dell'Okinawa Institute of Science and Technology ha finalmente risolto questo paradosso scientifico, dimostrando che la celebre teoria formulata nel 1941 dal matematico russo Andrey Kolmogorov si applica effettivamente anche a questi complessi flussi rotanti. La scoperta, pubblicata sulla rivista Science Advances, riabilita uno dei sistemi sperimentali più importanti per lo studio della turbolenza e apre nuove prospettive per comprendere fenomeni che spaziano dai cicloni tropicali alla formazione dei pianeti nei dischi di accrescimento attorno alle stelle nascenti.
I flussi di Taylor-Couette rappresentano da sempre un banco di prova fondamentale per la meccanica dei fluidi. Questi sistemi, apparentemente semplici nella loro configurazione, un liquido contenuto tra due cilindri rotanti indipendentemente, generano comportamenti di straordinaria complessità, dando origine ai cosiddetti Taylor rolls, vortici rotanti che a loro volta ruotano su se stessi, analogamente alle correnti verticali vorticose all'interno di un tifone che ruota orizzontalmente. La loro importanza risiede nel fatto che si tratta di sistemi chiusi, privi di pompe o ostruzioni, ideali per studiare le proprietà fondamentali dei flussi turbolenti in condizioni controllate.
La teoria di Kolmogorov sulla turbolenza descrive come l'energia si propaga attraverso una cascata di vortici di dimensioni decrescenti, dai più grandi ai più piccoli, fino a dissiparsi in calore. Come spiega il professor Pinaki Chakraborty, responsabile dello studio presso la Fluid Mechanics Unit dell'OIST, il concetto è intuitivo: "Se si mescola una pozza d'acqua con un grande cucchiaio, si aggiunge energia sotto forma di movimento che crea un grande vortice. Questo vortice si divide in vortici sempre più piccoli, fino a dissiparsi completamente come calore". La famosa legge formulata da Kolmogorov predice come questa energia si distribuisce nelle diverse scale del flusso turbolento ed è stata verificata praticamente in tutti i tipi di turbolenza studiati—con una vistosa eccezione proprio nei flussi di Taylor-Couette.
Per quasi settant'anni, esperimenti ripetuti hanno sistematicamente fallito nel confermare l'applicabilità della teoria di Kolmogorov a questi flussi rotanti, generando una contraddizione che ha tormentato generazioni di fisici. Come può una teoria considerata universale non applicarsi a uno dei regimi di flusso più importanti della meccanica dei fluidi? Questa "brutta" incongruenza, come la definisce Chakraborty, ha spinto il team giapponese a investire nove anni nello sviluppo di un apparato sperimentale di livello mondiale, capace di raggiungere numeri di Reynolds fino a 10⁶ - una misura del grado di disordine turbolento - tra i più elevati al mondo.
La sfida ingegneristica è stata notevole: ospitare sensori di precisione all'interno di un cilindro che ruota a migliaia di giri al minuto, circondato da liquido mantenuto a temperatura costante e racchiuso a sua volta in un altro cilindro rotante. Quando i ricercatori hanno analizzato gli spettri energetici misurati con l'approccio convenzionale, hanno effettivamente confermato che la legge di Kolmogorov non sembrava adattarsi ai dati. Ma qui è arrivata l'intuizione decisiva del dottor Julio Barros, primo autore dell'articolo: invece di limitarsi alle celebri ipotesi di Kolmogorov, che si applicano solo al cosiddetto range inerziale, il team ha ampliato l'analisi all'intero dominio dei flussi su piccola scala, includendo i vortici più piccoli che dissipano energia sotto forma di calore.
A queste scale, Kolmogorov aveva predetto che, tenendo conto degli effetti dissipativi, gli spettri energetici riscalati dovrebbero collassare su una singola curva universale, rappresentata dalla funzione F(kη), dove k indica il numero d'onda (inversamente proporzionale alla dimensione dei vortici) e η la scala di dissipazione. Applicando questo aspetto meno studiato ma più generale della teoria di Kolmogorov, i ricercatori hanno finalmente trovato l'universalità predetta. "Il riscalamento delle misurazioni secondo la teoria generale ha prodotto l'universalità che Kolmogorov aveva previsto. La teoria funziona", conferma Barros.
La soluzione del paradosso non risiede dunque in un'eccezione alla teoria di Kolmogorov, ma nella necessità di applicare il framework teorico completo piuttosto che limitarsi alla sua manifestazione più nota. Questo risultato riabilita completamente i flussi di Taylor-Couette come strumenti potenti per studiare la meccanica dei fluidi sia teorica che applicata, con implicazioni che si estendono ben oltre il laboratorio. Dalla previsione meteorologica, dove la comprensione dei flussi rotanti turbolenti è cruciale per modellare cicloni e anticicloni, alla progettazione di motori e turbine, fino allo studio dei dischi protoplanetari dove nascono nuovi sistemi solari attorno a stelle distanti, la turbolenza rotazionale gioca un ruolo fondamentale.
Con la riconciliazione tra i flussi di Taylor-Couette e la teoria di Kolmogorov, e con l'inaugurazione del nuovo apparato sperimentale OIST-TC, i ricercatori hanno stabilito una nuova linea di riferimento per lo studio di questi fenomeni complessi. Come sottolinea Chakraborty, la versatilità di questi sistemi chiusi permette ora di studiare il comportamento di qualsiasi liquido con diversi additivi (sedimenti, bolle, polimeri) con un solido punto di riferimento teorico. Le prospettive future includono l'applicazione di questa metodologia validata a una gamma più ampia di condizioni sperimentali e l'esplorazione di come particelle, polimeri e altre sostanze modifichino la cascata energetica turbolenta, con potenziali ricadute in settori che vanno dall'ingegneria chimica alla geofisica, dalla climatologia all'astrofisica.