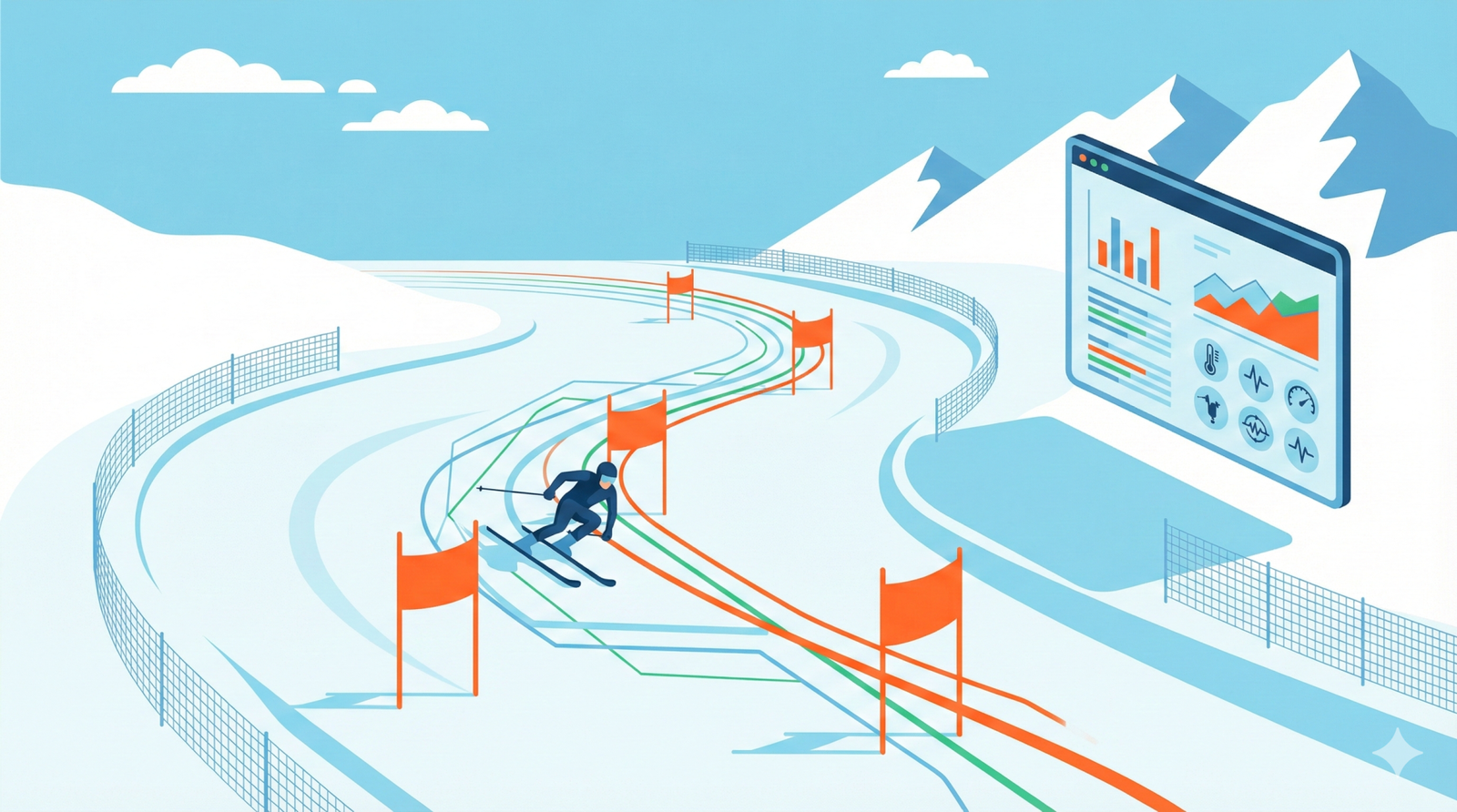La meditazione sta vivendo una stagione di straordinaria popolarità, promossa come soluzione per ridurre lo stress, migliorare la produttività e sostenere il benessere psicologico in contesti che vanno dalle aziende alle scuole, fino agli ambulatori medici. Tuttavia, proprio questa diffusione capillare solleva interrogativi scientifici cruciali che finora sono rimasti in gran parte inevasi. Quando una pratica viene utilizzata in ambito terapeutico, infatti, la comunità scientifica dovrebbe prima stabilirne con precisione efficacia, dosaggio ottimale e soprattutto profilo di sicurezza. Nicholas Van Dam, psicologo presso l'Università di Melbourne, sottolinea come per i programmi basati sulla mindfulness questo passaggio fondamentale non sia mai avvenuto: "È il tipo di ricerca che si conduce all'inizio dello sviluppo di qualsiasi nuovo intervento terapeutico, ma per ragioni complesse, nel caso della mindfulness semplicemente non è stato fatto".
Negli ultimi anni, alcuni studi hanno iniziato a documentare esperienze avverse associate alla meditazione, che possono manifestarsi con un'ampia gamma di sintomi. Tra questi figurano attacchi di panico, riemersione di memorie traumatiche intrusive simili a quelle osservate nel disturbo post-traumatico da stress, e in casi più rari sensazioni di depersonalizzazione o dissociazione. Il problema non riguarda tanto l'esistenza di questi effetti collaterali, ormai documentati, quanto la loro frequenza: le stime nella letteratura scientifica variano in modo drammatico, oscillando dall'1% riportato in alcune ricerche fino a due terzi dei praticanti secondo altri studi.
Per fare chiarezza su questa discrepanza, Van Dam e il suo team hanno progettato uno studio pubblicato su Clinical Psychological Science, coinvolgendo quasi 900 adulti provenienti da tutto il territorio statunitense. La metodologia adottata rappresenta un elemento innovativo rispetto alle ricerche precedenti: i ricercatori hanno utilizzato i dati dei Centers for Disease Control and Prevention per selezionare un campione rappresentativo della popolazione americana di meditatori, includendo praticanti di ogni livello di esperienza, dai principianti agli avanzati. Questo approccio ha permesso di ottenere una fotografia più accurata dell'intera comunità meditativa statunitense.
Un aspetto metodologico cruciale riguarda la modalità con cui vengono rilevati gli effetti collaterali. Van Dam evidenzia come molti studi precedenti si affidassero a domande aperte, un metodo definito "segnalazione spontanea", che lascia ai partecipanti la responsabilità di identificare e riportare autonomamente eventuali problemi. Questo sistema può sottostimare significativamente l'incidenza degli effetti avversi: le persone potrebbero non riconoscere determinate esperienze come effetti collaterali oppure esitare a menzionarle. Per superare questo limite, il gruppo di ricerca ha sviluppato una checklist di 30 elementi che elenca possibili effetti della meditazione, chiedendo ai partecipanti di valutare per ciascuno l'intensità, la valenza emotiva (positiva o negativa) e l'eventuale interferenza con il funzionamento quotidiano.
I risultati dello studio rivelano dati significativi: quasi il 60% dei meditatori ha riportato almeno un effetto collaterale tra quelli elencati, come sensazioni di ansia o di estraneità dal proprio corpo. Circa il 30% ha descritto esperienze sfidanti o disturbanti, mentre il 9% ha riferito compromissioni funzionali, ovvero difficoltà concrete nello svolgimento delle attività quotidiane. La ricerca ha inoltre identificato alcuni fattori di rischio: gli individui che avevano sperimentato sintomi di disturbi mentali o disagio psicologico nei 30 giorni precedenti la pratica meditativa mostravano una probabilità maggiore di incorrere in effetti avversi. Anche la partecipazione a ritiri residenziali intensivi, che prevedono lunghi periodi di meditazione silenziosa, risultava associata a un rischio più elevato di compromissione funzionale.
Van Dam precisa tuttavia che questi dati, pur robusti, non permettono ancora di stabilire relazioni causali definitive. Uno studio longitudinale prospettico, che segua i praticanti nel tempo, sarebbe necessario per chiarire come salute mentale e meditazione interagiscano reciprocamente e quali meccanismi biologici o psicologici sottendano agli effetti osservati. La questione metodologica rimane centrale: distinguere tra correlazione e causalità è fondamentale per comprendere se la meditazione provochi direttamente certi effetti o se questi emergano in persone già vulnerabili.
Nonostante i dati possano sembrare allarmanti, il ricercatore sottolinea con forza che l'obiettivo dello studio non è demonizzare la meditazione. "Le nostre conclusioni non sono che le persone debbano essere terrorizzate o evitare di provare la meditazione. Riteniamo piuttosto che dovremmo fare un lavoro migliore nel fornire un consenso informato", spiega Van Dam. Il parallelo con altri trattamenti terapeutici è illuminante: prima di un intervento chirurgico o di una terapia di esposizione per le fobie, i pazienti ricevono informazioni dettagliate sui possibili rischi ed effetti collaterali, permettendo loro di prendere decisioni consapevoli. Nel contesto della meditazione, questa preparazione preventiva è raramente fornita.
La questione diventa particolarmente delicata quando si considera che un certo grado di disagio può essere parte integrante del processo meditativo. Van Dam suggerisce che praticanti e clinici dovrebbero spiegare come sensazioni di inquietudine o di messa in discussione del proprio senso di identità non costituiscano necessariamente segnali di danno, ma possano rappresentare aspetti normali di un'esplorazione psicologica profonda. Il discrimine cruciale riguarda l'intensità e la persistenza: un disagio che interferisce significativamente con il funzionamento quotidiano richiede attenzione clinica e potrebbe indicare che quella specifica pratica non è adatta a quella persona in quel momento della sua vita.
Le implicazioni di questa ricerca si estendono ben oltre la pratica individuale. Nel momento in cui la meditazione viene integrata in protocolli terapeutici, programmi aziendali o percorsi educativi, diventa essenziale applicare gli stessi standard di sicurezza e monitoraggio utilizzati per qualsiasi intervento sulla salute mentale. La personalizzazione degli approcci meditativi, considerando la storia clinica individuale e i fattori di vulnerabilità, potrebbe rappresentare una direzione futura importante. Van Dam conclude con una riflessione equilibrata: "Queste pratiche non sono per tutti. Se non funzionano, non è necessariamente perché la persona sta sbagliando qualcosa. Potrebbe semplicemente non essere una buona corrispondenza". La ricerca scientifica futura dovrà concentrarsi sull'identificazione di quali specifiche tecniche meditative siano più appropriate per diversi profili psicologici, definendo linee guida basate sull'evidenza per un uso sicuro ed efficace di queste antiche pratiche nel contesto della medicina contemporanea.





.jpg)