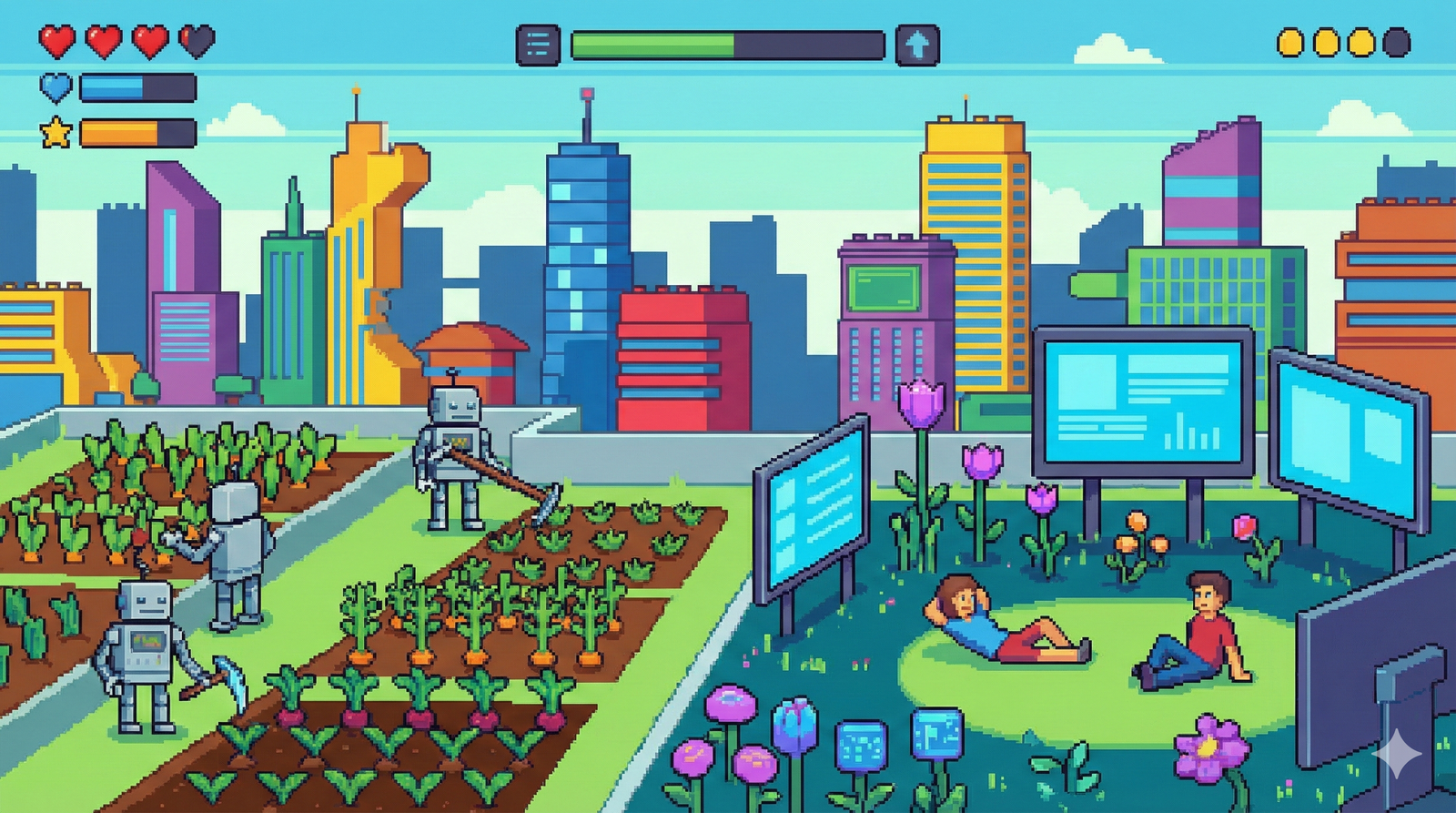Avv. Giuseppe Croari – Dott. Francesco Rabottini
Dallo scorso 25 ottobre 2025, in Cina è entrata in vigore una legge che impone agli influencer di possedere una laurea o una qualifica professionale riconosciuta per parlare online di salute, diritto, educazione e finanza. È una risposta del governo al grande potere persuasivo di queste persone e al rischio che diffondano informazioni errate - volontariamente o meno - spingendo il loro pubblico a fare scelte sbagliate, persino pericolose.
La Cina, dunque, punta sull’idea di competenza certificata e sul controllo politico, seguendo l’idea che solo chi è competente e autorizzato può parlare di certi temi “delicati”. In Italia invece la normativa è incentrata sulla trasparenza: si può parlare di tutto, ma chi ha accordi commerciali lo deve dichiarare.
Le novità per gli influencer cinesi: qualifiche obbligatorie e controllo AI
L'evoluzione normativa in Cina ha messo un punto all'era dei contenuti non filtrati, privilegiando un sistema basato sulla c.d. “competenza verificata”. Gli influencer che trattano argomenti sensibili, riconducili ai settori critici di Medicina/Sanità, Diritto, Finanza e Istruzione, aventi un impatto diretto sulla sicurezza e la stabilità finanziaria dei cittadini, devono certificare le proprie qualifiche formali al fine di prevenire la diffusione di informazioni false e fuorvianti in un settore che definire, per usare un eufemismo, può essere definito come “fiorente”.
Inoltre, il quadro normativo si è esteso per imporre agli influencer di specificare chiaramente se i contenuti da loro prodotti includano elementi generati dall’Intelligenza Artificiale (ne abbiamo parlato qui). Si tratta di un obbligo di trasparenza ricavabile dalle "Misure provvisorie per la gestione dei servizi di Intelligenza Artificiale generativa" del 2023, il quale mira a contrastare l'uso di deepfake per distorcere volti o voci.
In particolare, le piattaforme social e streaming dovranno agire da "gatekeeper", essendo tenute a verificare e archiviare le qualifiche avanzate dagli influencer e ad applicare sanzioni in caso di violazione. L'obiettivo ultimo è duplice: garantire la veridicità delle informazioni e mantenere il controllo ideologico e sociale sul cyberspazio.
Motivazioni e parallelo con lo scenario italiano
La domanda che sorge spontanea è la seguente: perché questi interventi normativi così stringenti? Ebbene, in Cina, il potere dei Key Opinion Leader (KO)L trae linfa vitale dal concetto di riprova sociale percepito dai cittadini: i consumatori cercano approvazione esterna, e l'associazione di un determinato prodotto con un KOL rispettato conferisce prestigio e affidabilità, il tutto amplificato dalla circostanza per cui i KOL cinesi si distinguono per la loro specializzazione in una nicchia di mercato, possedendo un'alta credibilità tra i loro seguaci.
In Italia, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ha riconosciuto che gli influencer sono persone fisiche o giuridiche che possono avere un "impatto significativo sul comportamento e sulle scelte" del pubblico. Pertanto, l'AGCOM ha individuato delle Linee guida e un Codice di condotta applicabili agli "influencer rilevanti". Tali soggetti sono definiti dal raggiungimento di soglie quantitative (almeno 500.000 iscritti o un milione di visualizzazioni medie mensili). Le misure italiane mirano a realizzare i principi di trasparenza e correttezza dell’informazione, garantendo che le comunicazioni commerciali e il product placement siano trasparenti al pubblico.
Limitazioni alla libera manifestazione del pensiero: un contrasto costituzionale
Venendo adesso al cuore dell’argomento che si sta trattando. La normativa cinese, sebbene miri a un "spazio internet positivo, sano, ordinato e armonioso", impone limiti politici severi, vietando specificamente contenuti che "indeboliscano, distorcano o neghino la leadership del Partito Comunista Cinese e del sistema socialista".
Questi requisiti, pur essendo formalmente tecnici, possono trasformarsi, nella pratica, in strumenti di controllo politico che impediscono a figure non istituzionalizzate o critiche di esprimere le proprie opinioni, strumentalizzando la mancanza di un "certificato" o l'etichettatura AI come pretesto per il silenziamento. Il rischio maggiore è il cosiddetto "effetto dissuasivo" (chilling effect), che spinge all'autocensura per paura di perdere la propria fonte di reddito.
Questo approccio si scontra con i principi fondamentali della Costituzione Italiana. L'Articolo 21 stabilisce che "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". La libertà di manifestazione del pensiero è definita un valore fondamentale e un pilastro di uno stato democratico basato sul pluralismo ideologico. In forza di questo assetto, la legge italiana stabilisce limiti circoscritti alla tutela di altri diritti, come la riservatezza e l'onorabilità delle persone, il buon costume e il segreto di Stato.
L'impatto sulle aziende cinesi e italiane
L'introduzione di regole stringenti ha conseguenze dirette per le aziende che operano in questi mercati.
Per le aziende che operano in Cina, un aspetto positivo è l'aumento della credibilità potenziata ottenuta grazie alle collaborazioni con KOLs qualificati. Il mercato cinese, ultra-specializzato e strutturato, offre un targeting preciso e un ordine maggiore, eliminando i "falsi anchor". L'accesso alla cultura locale tramite i KOL fornisce anche la possibilità di analizzare e adattarsi alle tendenze diffuse sul territorio di riferimento. Tuttavia, i rischi sono considerevoli: le aziende sono costrette a convivere con un controllo politico pervasivo e partner che incappano in violazioni etiche (come l'ostentazione del lusso), o politiche (critica al PCC) mettono a repentaglio l'intera campagna.
La chiarezza normativa offerta dalle Linee guida e dal Codice di condotta (abbiamo approfondito le considerazioni alla base del Codice in questo articolo), che include l'obbligo di segnaletica Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria - IAP e il divieto di pubblicità occulta, rafforza la fiducia dei consumatori e dei marketer nei confronti delle aziende italiane.
L’obiettivo di queste normative è di garantire che i contenuti siano veritieri e combattano la disinformazione, richiedendo la massima attenzione ove i contenuti siano diretti ai minori. L'aspetto negativo per le imprese è invece rappresentato principalmente dagli oneri di compliance, che sono più stringenti per gli "influencer rilevanti", e dal rischio di sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi (TUSMA).
In conclusione, se in Italia la regolamentazione si configura come uno strumento per garantire un mercato maturo, trasparente e sicuro per i consumatori, in Cina essa è vista come un potente mezzo per combattere la disinformazione e, al contempo, per esercitare un controllo politico selettivo e pervasivo sulla narrazione pubblica online.
Se sei un’azienda o un content creator e necessiti di supporto legale rivolgiti ai nostri partner dello Studio Legale FCLEX e chiedi dell’Avvocato Giuseppe Croari esperto di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie.