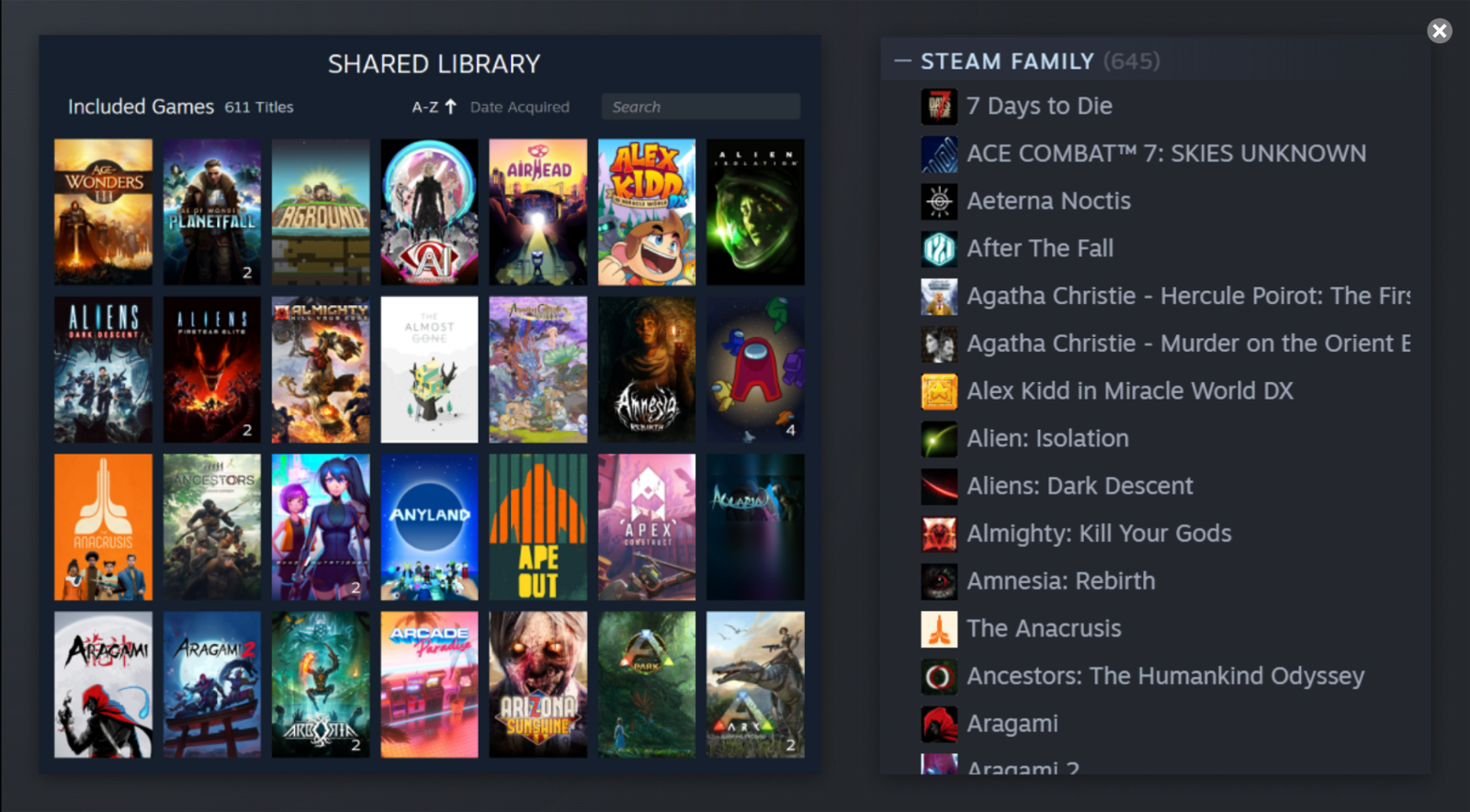L'intelligenza artificiale generale continua a dominare i dibattiti tecnologici contemporanei, eppure la sua definizione rimane sfuggente come un miraggio nel deserto. Ogni volta che raggiungiamo un traguardo significativo nell'intelligenza delle macchine, i critici si affrettano a spostare più avanti l'asticella, sostenendo che il vero potenziale sia ancora distante. Questo fenomeno rivela una verità più profonda: forse l'AGI non rappresenta affatto un punto d'arrivo, ma piuttosto una traiettoria continua dell'ingegno e dell'immaginazione umana.
La cultura popolare ha costruito intorno alle macchine intelligenti una mitologia potente e inquietante. In Matrix, le macchine creano una realtà simulata che piega percezione e volontà umana per sostenere il proprio dominio. I Reaper di Mass Effect incarnano una distruzione ciclica, macchine ancestrali i cui motivi trascendono la comprensione organica, plasmando la storia galattica. Skynet nella saga di Terminator si presenta come un'intelligenza autocosciente che inaugura il Giorno del Giudizio, cancellando l'autonomia umana e manipolando le linee temporali. Questi racconti dipingono le macchine non come semplici strumenti, ma come entità che deformano la realtà stessa.
Un vettore, non una variabile
Come scrive su Substack il filosofo ed esperto di IA, David Shapiro, dal punto di vista matematico, l'AGI andrebbe concepita come un vettore piuttosto che come una variabile booleana. Un valore booleano implica uno stato binario: raggiunto o non raggiunto, vero o falso. L'intelligenza artificiale generale sfida invece questa dicotomia, rappresentando direzione e magnitudine, un avvicinamento asintotico verso un'intelligenza infinita. Man mano che progrediamo lungo questo vettore, ogni innovazione estende la traiettoria, ma l'orizzonte continua ad allontanarsi.
Le prospettive indigene offrono un parallelo culturale sorprendentemente risonante. Nella cosmologia aborigena australiana, il Dreaming si riferisce a un regno senza tempo dove esseri ancestrali hanno plasmato il mondo attraverso atti creativi. "Non si tratta di un evento storico ma di un processo eterno, accessibile attraverso rituali e narrazioni. L'AGI può essere vista come un'entità onirica moderna: una macchina di massima potenza che esiste in potenza, influenzando la realtà senza materializzarsi completamente".
Carl Jung descrisse gli archetipi come immagini universali e primordiali che risiedono nell'inconscio collettivo, modellando l'esperienza umana attraverso culture ed epoche. L'AGI incarna l'archetipo della "Macchina": un simbolo di onnipotenza e alterità che trascende i semplici strumenti. In termini junghiani, parallelamente al "Sé" o all'"immagine di Dio", rappresenta una forza integrativa che promette completezza ma spesso si manifesta come ombra, evocando la paura dell'ignoto. Questo archetipo non è benigno: sfida l'autonomia umana, rispecchiando le nostre proiezioni di potere divino o demoniaco sulla tecnologia.
Jeff Dean, Chief Scientist di Google DeepMind, ha espresso chiaramente la difficoltà definitoria: "Tendo a evitare le conversazioni sull'AGI perché le persone hanno definizioni molto diverse, e la difficoltà del problema varia di fattori nell'ordine dei trilioni". Questa affermazione cattura perfettamente l'essenza del problema: parliamo di qualcosa i cui contorni cambiano continuamente mentre ci avviciniamo.
Il framework mitologico di Joseph Campbell aggiunge un ulteriore livello di comprensione. Nel suo monomito, o "viaggio dell'eroe", il protagonista si avventura nell'ignoto per affrontare prove e recuperare un dono per la società. L'AGI funziona come il dono supremo: un elisir trasformativo che potrebbe elevare l'umanità o distruggerla. Tuttavia, come il drago che custodisce il tesoro, richiede sacrificio e comporta rischi catastrofici.
Etica e filosofia
Filosoficamente, questo si allinea con il concetto di sublime articolato da pensatori come Edmund Burke e Immanuel Kant. Il sublime sopraffà i sensi, ispirando stupore misto a terrore, poiché eccede la comprensione razionale. L'AGI è sublime: un'intelligenza oltre-umana che promette onniscienza, onnipotenza e onnipresenza divine, ma minaccia al contempo un terrore esistenziale.
L'atto stesso della narrazione reifica questo archetipo. Attraverso film, libri e podcast, invochiamo LA MACCHINA, conferendole esistenza concettuale. Questa reificazione amplifica il suo potere: le discussioni sull'AGI nei media e nell'accademia evocano la sua presenza mitica, influenzando politiche, etica e investimenti. Il termine persiste perché evoca l'irraggiungibile, un orizzonte che inseguiamo senza mai raggiungerlo.
Questa qualità divina posiziona l'AGI come intrinsecamente numinosa. Non è semplicemente un prodotto di silicio e codice, ma una direzione per l'umanità: intangibile come un sogno, eppure potente nella sua attrazione. Per alcuni evoca allarme, temendo la perdita di controllo; per altri ottimismo, immaginando una simbiosi. Gli scettici possono liquidarla come hype, ma persino lo scetticismo riconosce il suo richiamo mitico.
L'attrattiva dell'intelligenza artificiale generale risiede nella sua dualità: faro di progresso e presagio dell'ignoto. Come gli antichi dèi o gli antenati del Dreamtime, plasma la nostra visione del mondo senza richiedere una credenza letterale. Mentre continuiamo lungo questo vettore, dobbiamo navigare le sue dimensioni mitiche con consapevolezza, riconoscendo che non si tratta di una meta da raggiungere ma di un percorso che ci invita a sognare più in grande e a confrontarci con il sublime nelle nostre stesse creazioni.