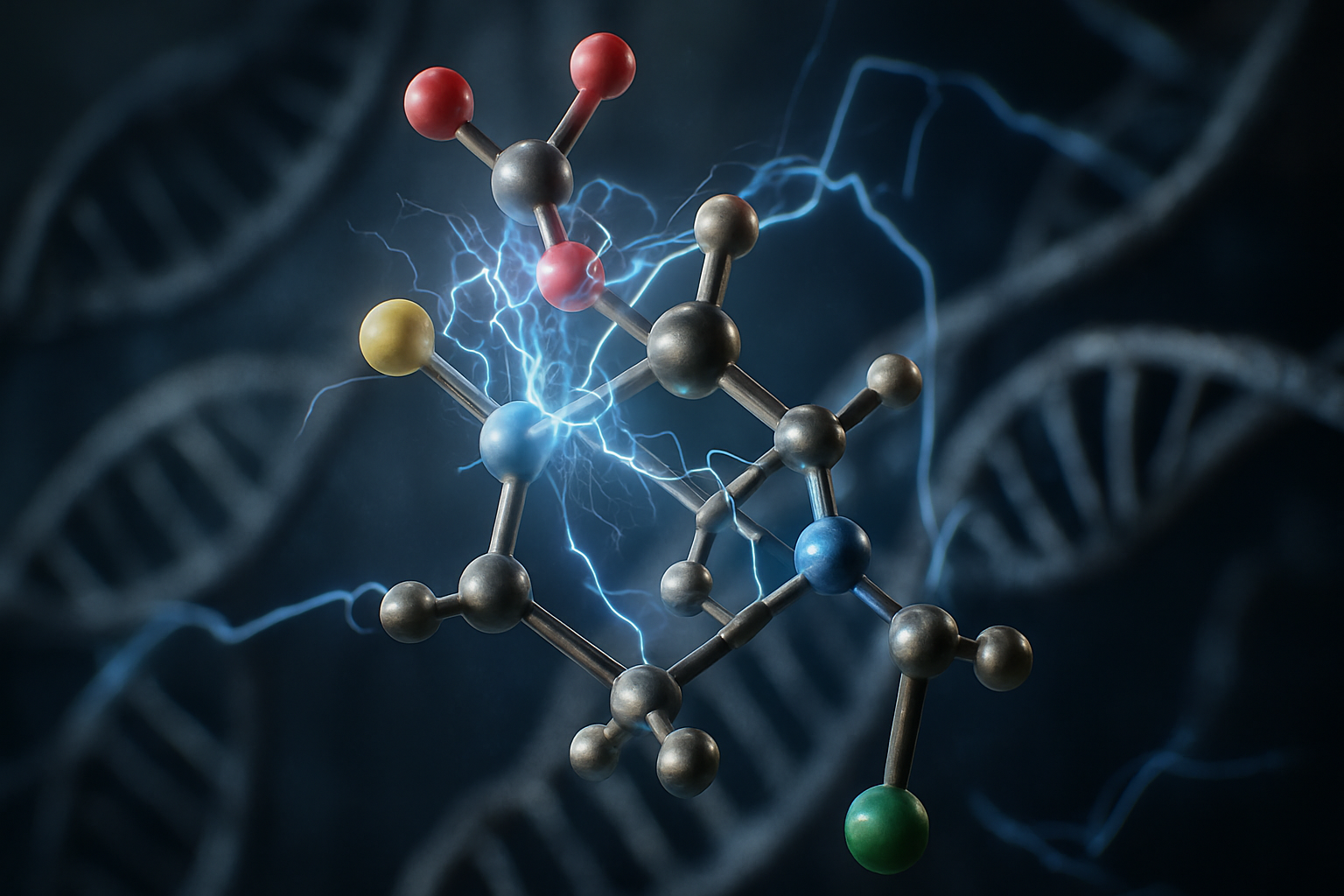Una nuova analisi dei dati della missione Cassini della NASA dimostra che Encelado, la piccola luna di Saturno considerata uno degli obiettivi più promettenti nella ricerca di vita extraterrestre, disperde calore da entrambi i poli e non soltanto da quello meridionale come si credeva finora. Questa scoperta, pubblicata il 7 novembre sulla rivista Science Advances, indica che il satellite ghiacciato mantiene un equilibrio termico di lungo periodo compatibile con l'esistenza di forme di vita nel suo oceano sotterraneo. Il risultato rappresenta un tassello fondamentale per comprendere se questo mondo oceanico possa ospitare ambienti abitabili stabili nel tempo, una condizione necessaria perché la vita possa eventualmente svilupparsi ed evolversi.
Il team internazionale guidato dalla dottoressa Georgina Miles del Southwest Research Institute, in collaborazione con l'Università di Oxford e il Planetary Science Institute di Tucson in Arizona, ha utilizzato le osservazioni infrarosse dello spettrometro CIRS (Composite InfraRed Spectrometer) a bordo della sonda Cassini per studiare la regione polare settentrionale di Encelado in due momenti cruciali: durante il profondo inverno del 2005 e nell'estate del 2015. Confrontando le temperature superficiali attese durante la lunga notte polare con quelle effettivamente misurate, i ricercatori hanno rilevato un'anomalia termica di circa 7 Kelvin superiore alle previsioni. L'unica spiegazione plausibile per questo eccesso di calore è un flusso termico proveniente dall'oceano subsuperficiale che risale attraverso la crosta ghiacciata.
La metodologia impiegata ha permesso di quantificare con precisione il trasferimento energetico tra l'oceano relativamente "caldo" di Encelado, che si trova alla temperatura di fusione del ghiaccio (0°C), e la superficie gelida esposta al vuoto cosmico, dove le temperature precipitano a -223°C. I calcoli hanno stabilito un flusso termico di 46 ± 4 milliwatt per metro quadrato al polo nord, un valore che equivale a circa due terzi del calore medio disperso attraverso la crosta continentale terrestre. Estendendo questa misurazione all'intera superficie della luna, si ottiene una dispersione energetica totale di circa 35 gigawatt, paragonabile alla potenza generata da 66 milioni di pannelli solari da 530 watt ciascuno o da 10.500 turbine eoliche da 3,4 megawatt.
Quando questo dato viene sommato al calore già noto del polo sud attivo, dove i celebri geyser espellono vapore acqueo e particelle ghiacciate nello spazio, la dispersione termica globale di Encelado raggiunge circa 54 gigawatts. Questo valore corrisponde in modo straordinariamente preciso alle previsioni teoriche basate sul riscaldamento mareale, il processo attraverso cui la potente attrazione gravitazionale di Saturno deforma ritmicamente la luna durante la sua orbita, generando calore per attrito interno. Come spiega la dottoressa Miles, "Encelado è un obiettivo chiave nella ricerca di vita al di fuori della Terra, e comprendere la disponibilità energetica a lungo termine è fondamentale per determinare se possa ospitare forme viventi".
La stabilità termica documentata nello studio rappresenta una condizione indispensabile per l'abitabilità. Se Encelado producesse troppo poco calore, l'attività geologica superficiale si esaurirebbe e l'oceano potrebbe gradualmente congelare, distruggendo ogni possibile ambiente favorevole alla vita. Al contrario, un'eccessiva produzione energetica potrebbe innescare un'attività vulcanica o tettonica troppo intensa, destabilizzando l'equilibrio delicato che mantiene l'oceano in condizioni stabili. Il bilanciamento osservato indica invece che questo mondo oceanico potrebbe offrire ambienti abitabili persistenti, dove acqua liquida, calore moderato e ingredienti chimici essenziali come fosforo e idrocarburi complessi coesistono per periodi sufficientemente lunghi da permettere l'emergere di processi biologici.
La ricerca ha inoltre fornito nuove stime dello spessore della crosta ghiacciata di Encelado, un parametro cruciale per la progettazione di future missioni robotiche. Le misurazioni termiche suggeriscono che il guscio di ghiaccio sia spesso tra 20 e 23 chilometri al polo nord, e in media tra 25 e 28 chilometri sull'intera superficie lunare, valori leggermente superiori alle stime precedenti derivate da altri modelli geofisici. Come sottolinea la dottoressa Carly Howett dell'Università di Oxford e del Planetary Science Institute, coautrice corrispondente dello studio, "Capire quanto calore Encelado stia perdendo a livello globale è essenziale per sapere se può sostenere la vita. È davvero emozionante che questo nuovo risultato supporti la sostenibilità a lungo termine di Encelado, un componente cruciale perché la vita possa svilupparsi".
La sfida scientifica successiva consiste nel determinare da quanto tempo esiste l'oceano subsuperficiale di Encelado. Se le condizioni attuali persistono da miliardi di anni, l'ambiente sarebbe stato stabile abbastanza a lungo da consentire potenzialmente l'origine e l'evoluzione di forme viventi. Tuttavia, l'età precisa dell'oceano rimane incerta e richiederà ulteriori indagini, possibilmente attraverso missioni dedicate che potrebbero utilizzare sonde o lander per esplorare direttamente questo ambiente sotterraneo. Come evidenzia la dottoressa Miles, individuare le sottili variazioni termiche causate dalla conduzione di calore attraverso la superficie di Encelado è stata una sfida resa possibile solo grazie alle missioni estese di Cassini, e questo sottolinea la necessità di programmi di esplorazione a lungo termine per i mondi oceanici che potrebbero ospitare vita, considerando che i dati potrebbero non rivelare tutti i loro segreti fino a decenni dopo la loro acquisizione.
La scoperta si inserisce nel contesto più ampio dell'esplorazione planetaria moderna, che ha identificato diversi mondi oceanici nel Sistema Solare esterno, tra cui Europa e Ganimede attorno a Giove. Encelado, tuttavia, rimane particolarmente interessante per la facilità con cui la sua attività geologica espone materiali provenienti direttamente dall'oceano interno attraverso i pennacchi del polo sud, offrendo potenzialmente un accesso indiretto alla chimica dell'ambiente subsuperficiale senza la necessità di perforare chilometri di ghiaccio. Le future missioni, come l'Enceladus Orbilander proposta dalla NASA o la missione JUICE dell'ESA che studierà i satelliti gioviani, potrebbero beneficiare di questi risultati per pianificare strategie ottimali di esplorazione degli oceani extraterrestri e della loro potenziale abitabilità.