Negli ultimi decenni, il panorama economico globale è mutato radicalmente, passando da un modello industriale a uno basato sulla conoscenza. Un cambiamento che ha spostato l'attenzione dagli asset tangibili a quelli intangibili, riconoscendone il vero valore e la capacità di creare ricchezza per l’azienda.
Così il Capitale Intellettuale (CI) è diventato ancora di più motore della vita aziendale, capace di generare innovazione e sostenere le capacità e le competenze fondamentali di qualsiasi organizzazione, tanto che nel 2018, esso costituiva l'84% del valore totale delle imprese sull'indice S&P 500. Vi è dunque una crescente discrepanza tra il valore di mercato e il valore contabile tradizionale delle aziende, e per questo motivo la ricerca ha cercato nuovi modi per misurare l’invisibile.
Il concetto di CI, pur frammentato, è in genere inteso come l'insieme delle risorse basate sulla conoscenza che contribuiscono al vantaggio competitivo sostenuto di un'impresa
Le classificazioni più note identificano tre componenti principali del CI:
- Capitale Umano (CU): le competenze, le conoscenze, l'esperienza, l'atteggiamento, la creatività e l'agilità intellettuale degli individui all'interno dell'organizzazione. Fonte principale di innovazione e rinnovamento strategico. Non può essere "posseduto" dall'azienda, ma solo "noleggiato" ed è al centro del suo valore reale.
- Capitale Strutturale (CS): tutto ciò che "rimane nell'azienda quando i dipendenti tornano a casa la sera" ( le infrastrutture, le relazioni di rete interne, tecnologie, routine, segreti commerciali, procedure, cultura organizzativa, database, manuali e sistemi di gestione. Il CS è il collegamento critico che consente la misurazione del CI a livello organizzativo. Al suo interno, si distinguono il Capitale di Innovazione (la capacità strutturale di catturare il lavoro del CU per generare innovazione, come brevetti e marchi) e il Capitale di Processo (la capacità strutturale di creare valore attraverso le modalità operative).
- Capitale Relazionale (CR) o Capitale Esterno o Capitale Cliente è la conoscenza incorporata nelle relazioni dell'azienda con l'ambiente esterno, inclusi clienti, fornitori, alleati, azionisti e altre parti interessate.
La misurazione del CI è pertanto uno strumento gestionale potente essendo utile a:
- migliorare la qualità della gestione aziendale: "ciò che può essere misurato può essere gestito". La misurazione del CI fornisce informazioni tempestive per i manager, consentendo di adattare le strategie e massimizzare l'uso della conoscenza.
- Formulare, valutare ed eseguire una strategia basata sulle risorse, fornendo feedback sugli effetti delle attività e consentendo di testare le ipotesi strategiche.
- Valutare lo sviluppo Strategico, la diversificazione e l’espansione: cruciale in operazioni come acquisizioni o fusioni, per evitare di sovrastimare gli asset intangibili e supportare nuove iniziative.
- comunicare con gli Stakeholder Esterni: divulgare il CI aiuta a ridurre l'asimmetria informativa tra l'azienda e i suoi stakeholder spiegando il valore reale dell'azienda e il suo potenziale
- identificare e misurare i componenti della conoscenza per trasformarli in un miglioramento continuo delle performance.+
Misurare il Capitale Intellettuale
Nonostante la sua innegabile importanza, la misurazione del CI presenta significative complessità rendendo i metodi contabili tradizionali inadeguati per valutarlo pienamente. Assegnare un valore monetario esatto al CI è problematico e spesso impossibile per la sua natura "tacita" e la specificità di ogni organizzazione misurata che rendono le formule di calcolo quasi irrealizzabili. E non esiste nemmeno un mercato per la maggior parte dei componenti del CI.
I metodi per misurare, peraltro, variano a seconda della dimensione, del settore, della posizione aziendale e delle finalità della misurazione. Molte misure sono soggettive e inaffidabili e i sistemi di misurazione complessi. Ogni modello di misurazione del CI ha i propri punti di forza e di debolezza.
- Lo Skandia Navigator, del pioniere Leif Edvinsson, visualizza il valore aziendale attraverso cinque aree di interesse: finanziaria, cliente, processo, rinnovamento e sviluppo, e capitale umano. Ma è stato sviluppato per una specifica azienda e tende a esprimere tutte le misure in termini monetari. Inoltre, non fornisce linee guida dettagliate sulle dimensioni della conoscenza da misurare in tutte le sue complessità (trascurando, ad esempio, la cultura aziendale o la creatività individuale).
- L’Intangible Asset Monitor (IAM) di Sveiby: Si concentra su competenza dei dipendenti, struttura interna e struttura esterna e propone indicatori di crescita/rinnovamento, efficienza e stabilità. Dunque più strumento di gestione interna e comunicazione che metodo di valutazione monetaria.
- L’IC-Index: approccio di "seconda generazione", mira a consolidare gli indicatori individuali in un unico indice, correlandone i cambiamenti con le variazioni del mercato. E’ molto specifico per il contesto aziendale, il che ne limita l'universalità per confronti tra aziende.
- Il Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) di Ante Pulic quantifica l'efficienza delle organizzazioni nella creazione di valore attraverso asset tangibili e CI. Calcola la capacità del CI di generare valore aggiunto, ma non è una misura diretta del CI in sé e non è sempre comparabile tra aziende o settori a causa delle differenze nei costi del lavoro.
- La popolare Balanced Scorecard (BSC) di Kaplan e Norton è una misurazione multidimensionale che include fattori finanziari e non finanziari, come la prospettiva del cliente, dei processi interni e dell'apprendimento e crescita. Tuttavia non fornisce linee guida esplicite sulle dimensioni specifiche del CI da misurare.
- KPMG propone il suo Value Explorer utile a identificare e valutare le competenze chiave dell'azienda in termini monetari attraverso un processo strutturato, ma la sua valutazione è soggettiva.
Il più recente approccio è il Modello Integrato di Misurazione del Capitale Intellettuale (IICM) che considera l'impatto della trasformazione digitale e offre flessibilità specifica per il settore, utilizzando misure sia quantitative che qualitative.
Sta dunque all’azienda identificare gli indicatori e i modelli più significativi che misurano gli asset di conoscenza critici che supportano le loro competenze e la loro strategia. Questi possono essere sia quantitativi (es. numero di brevetti, costo della formazione per dipendente, tasso di turnover del personale, profittabilità per cliente, investimenti in R&S, ecc.) sia qualitativi (es. indici di soddisfazione dei dipendenti e dei clienti, sondaggi sulla cultura aziendale, valutazione delle reti sociali interne ed esterne, ecc.).
Il Reporting Integrato, promosso dall'International Integrated Reporting Council (IIRC) può rappresentare una soluzione per le aziende per condividere informazioni sul CI, categorizzando il capitale in sei o sette tipologie: finanziario, manifatturiero, intellettuale, umano, sociale e relazionale, naturale, e talvolta anche di governance.
Il suo obiettivo è spiegare come l'organizzazione crea valore nel tempo, interagendo con l'ambiente esterno e i vari capitali. Inoltre il Reporting Integrato è positivamente correlato al valore dell'impresa e può ridurre il costo del capitale proprio, mitigando le asimmetrie informative.
Ma anch’esso pecca nella definizione della materialità, la relazione degli asset con il concetto di valore, l'identificazione del modello di creazione di valore e la scelta di cosa includere in un report conciso. Tuttavia è indubbio che consenta una comprensione più approfondita delle proprie capacità, rafforzi il vantaggio competitivo e comunichi in modo più efficace il proprio valore a tutti gli stakeholder.
Ai manager l’onere di identificare i propri asset di conoscenza chiave e progettare indicatori che riflettano la propria strategia e i propri processi di creazione di valore. Si dovranno utilizzare un mix di dati per ottenere una visione completa, riconoscendo che la percezione e le dinamiche relazionali sono cruciali quanto i numeri.
Sarà anzitutto uno strumento di gestione interna per il miglioramento continuo nell’intento di evidenziare l'interazione dinamica tra i componenti del CI. Perché “L’essenziale è invisibile agli occhi”: mai come in organizzazione aziendale questa frase è vera.
Davide Genta è consulente free-lance in strategia e organizzazione, oggetto anche dei suoi insegnamenti a contratto presso l’Università degli Studi di Torino, di Milano-Statale e Bicocca, e in UIBS.



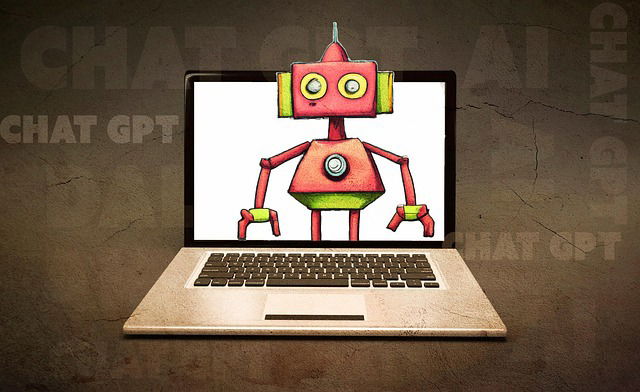



.jpg)