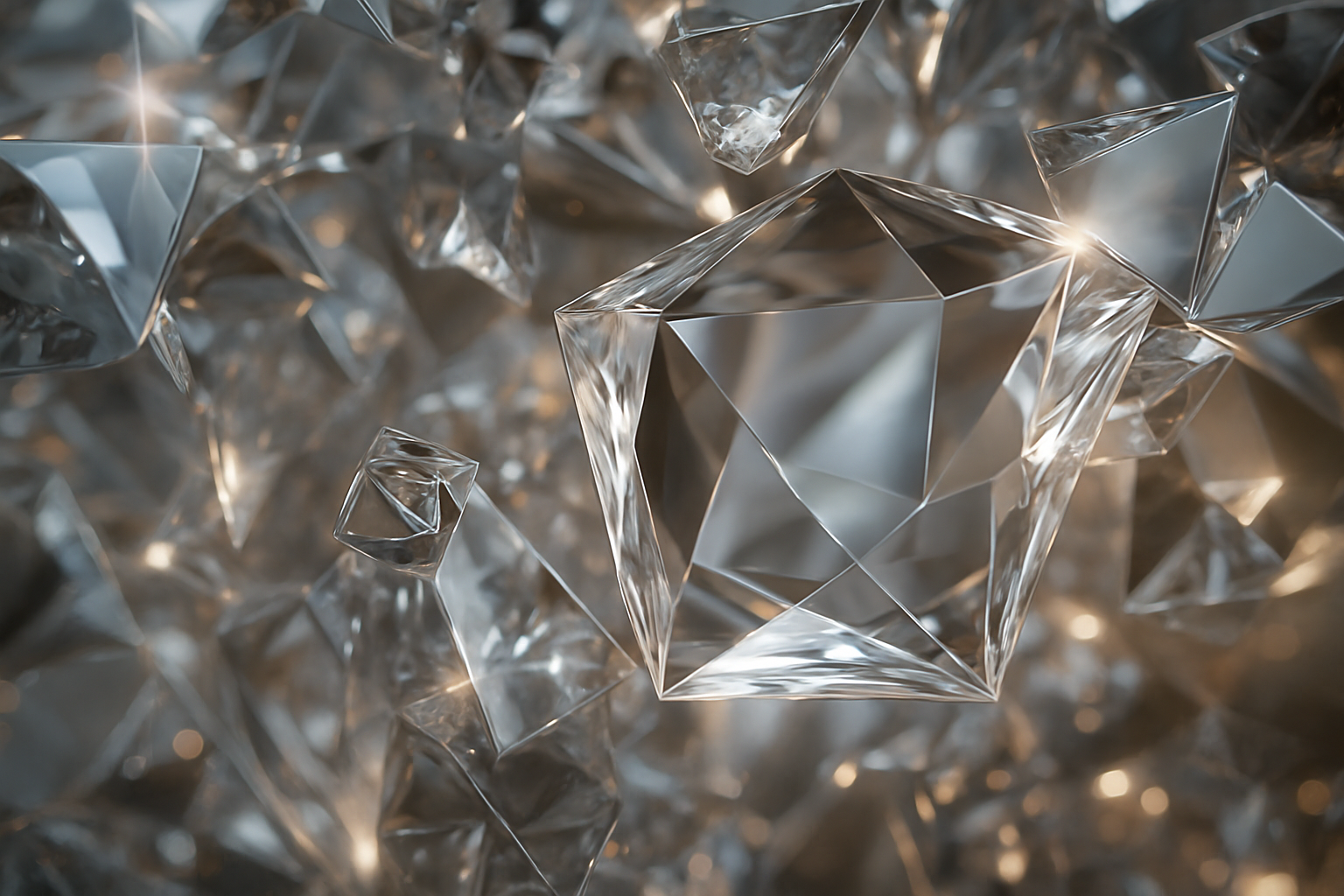La storia evolutiva del grande squalo bianco racconta un incredibile viaggio di sopravvivenza. Durante l’ultima era glaciale, con i ghiacciai che avanzavano e il livello del mare abbassato di circa 40 metri, questi predatori furono confinati in una sola popolazione nell’Indo-Pacifico meridionale. Da quella situazione critica è però nata una rinascita che ha permesso loro di colonizzare tutti gli oceani, lasciando dietro di sé un enigma genetico che da vent’anni sfida gli scienziati.
Un puzzle genetico che dura da oltre vent’anni
Il mistero emerse nel 2001, quando l’analisi di campioni genetici da Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica rivelò un contrasto sorprendente: DNA nucleare quasi identico in tutte le popolazioni, ma DNA mitocondriale diverso a seconda della zona geografica. Come se ogni gruppo avesse sviluppato una propria “firma molecolare”, pur mantenendo una base genetica comune. Per anni si è pensato che la spiegazione stesse nei movimenti migratori dei maschi, capaci di coprire migliaia di chilometri e mescolare il loro patrimonio genetico, mentre le femmine sarebbero tornate sempre negli stessi luoghi per riprodursi, un comportamento noto come filopatria.
Un recente studio, basato su uno dei più grandi dataset genetici mai raccolti su questa specie, ha smentito l’ipotesi. I ricercatori hanno confermato la presenza di tre popolazioni principali - nell’emisfero australe, nell’Atlantico settentrionale e nel Pacifico settentrionale - ma i test sulla filopatria non hanno trovato conferme. Se davvero le femmine tornassero sempre negli stessi luoghi per accoppiarsi, il segnale dovrebbe comparire anche nel DNA nucleare, cosa che non avviene.
La rinascita post-glaciale e i numeri che impressionano
La ricostruzione evolutiva mostra che circa 10.000 anni fa, alla fine della glaciazione, i grandi bianchi erano un’unica popolazione nel Sud dell’Indo-Pacifico. Con l’innalzarsi dei mari, si espansero verso nord seguendo prede ricche di energia, come le foche. La divergenza genetica iniziò circa 7.000 anni fa, quando le popolazioni si isolarono. Oggi, pur avendo diffusione globale, il numero complessivo resta basso: si stima che nel mondo vivano solo circa 20.000 individui.
Caduta la teoria migratoria, i ricercatori hanno testato l’ipotesi dello skew riproduttivo, cioè che solo poche femmine contribuissero alla discendenza, ma senza risultati. Resta quindi la possibilità che sia la selezione naturale a plasmare il DNA mitocondriale. Sarebbe però un processo durissimo: qualsiasi deviazione dalla sequenza più comune potrebbe risultare letale e non trasmettersi alle generazioni successive. Una spiegazione estrema, ma al momento l’unica ancora sul tavolo per risolvere il mistero genetico del più iconico predatore degli oceani.