“Ci sono due tipi di persone”, ha detto la voce dal palco, all’apertura di The Bologna Gathering. “Quando leggono che l’ecosistema tecnologico italiano è nove volte più piccolo di quello francese o tedesco, il primo gruppo si lamenta e dice: Oh no, non possiamo cambiarlo, saremo perdenti per sempre. Il secondo tipo di persone, invece, è in questa stanza”. In quella frase c’era tutto il senso dell'evento. Non una semplice conferenza, ma un atto di volontà. La manifestazione fisica di quell’Italia che non si arrende, che non accetta la narrazione della sconfitta e che, anziché lamentarsi, agisce. Un’Italia convinta non solo di poter cambiare sé stessa, ma di poter contribuire al futuro dell’Europa.
Ma che cos'è, nel concreto, The Bologna Gathering? Non è una fiera e non è un congresso tradizionale con un programma fitto di interventi da ascoltare passivamente. È, nella sua essenza, una piattaforma di incontri ad alta densità, un acceleratore di connessioni costruito con un obiettivo chirurgico: far dialogare quattro mondi che troppo spesso si muovono su binari paralleli. Da un lato le startup e le scaleup, motori dell'innovazione in cerca di capitali e opportunità; dall'altro i fondi di venture capital, nazionali e internazionali, a caccia di progetti promettenti, e il mondo corporate, le grandi aziende che necessitano di innovazione per rimanere competitive.
L'obiettivo è brutalmente pragmatico: trasformare le conversazioni in contratti, le strette di mano in investimenti e le idee in partnership strategiche. L'intera architettura dell'evento è disegnata per favorire questo processo, culminando in sessioni dedicate di incontri one-to-one. I numeri parlano chiaro: in meno di otto ore, sono stati facilitati oltre 1000 incontri mirati, molti dei quali - si può supporre - sono passati dal networking all’accordo, o se non altro ne hanno posto le basi. È un ecosistema temporaneo dove il potenziale inutilizzato viene messo nelle condizioni di esplodere.
Hai ragione, la sintesi è fondamentale. Una citazione deve essere un pugno, non un abbraccio.
Questa energia è il frutto della visione di persone come Nicklas Pavoncelli di StartYouUp e Stefano Onofri e Alessandro Cillario di Cubbit, gli organizzatori che in soli tre anni hanno trasformato un'idea in un punto di riferimento. Hanno creato un appuntamento esclusivo, su invito, che ha attirato 300 decision maker da tre continenti. Qui, tra i palazzi storici di Bologna e il moderno campus della Bologna Business School, ho incontrato un’Italia diversa, che non si piange addosso ma che crede, lavora e investe. Un’Italia migliore, che vale la pena raccontare.
Qui ho incontrato tante persone, e ognuna di loro portava con sé qualcosa che vale la pena di raccontare.
Più capitali che startup da finanziare

Contrariamente alla percezione comune, il problema dell'ecosistema innovativo italiano non è la mancanza di soldi. La realtà, oggi, è sorprendentemente diversa, quasi capovolta. A Bologna, una chiacchierata con Andrea Bellini di Alpha Venture ha scattato una fotografia lucida e spiazzante del nostro ecosistema. “Credo che in Italia oggi ci sia uno scompenso, un gap tra quanti soldi sono a disposizione per essere investiti [...] e opportunità di investimento”. In termini più semplici, “l'ammontare di venture capital complessivo in Italia sta crescendo a un ritmo più veloce di quello che è l'aumento delle opportunità di investimento”.
Questa abbondanza di liquidità, alimentata in gran parte da massicci investimenti di attori istituzionali, ha creato un paradosso inaspettato: ci sono più capitali a caccia di idee che startup mature e scalabili in cui investire. “Le startup migliori oggi stanno facendo dei percorsi veramente virtuosi, proprio perché c'è competizione tra gli investitori per ottenere gli oggetti migliori,” ha aggiunto Bellini. Questa dinamica ha portato alla nascita di un aforisma amaro ma efficace: “in Italia si dice come barzelletta che è bello raccogliere, è brutto investire”.
Il cuore del problema, quindi, non è economico, ma culturale. L'Italia, secondo Bellini, “ha un gap culturale rispetto ad altri paesi”. Siamo una nazione di straordinari imprenditori, ma con una mentalità specifica: “siamo bravi imprenditori artigianali. Noi non siamo bravi imprenditori a startup”.
A frenare ulteriormente il sistema sono due fattori profondamente radicati. Il primo è la gestione del fallimento. “Non uccidiamo start up, piuttosto le teniamo in vita [...] le trasciniamo”. Invece di chiudere un progetto che non funziona per liberare talento ed energie, si tende a prolungarne l'agonia. Questo si lega allo stigma sociale: “se tu fai perdere soldi a qualcuno è difficile poi raccogliere altri”. Di conseguenza, “non ci sono startupper che sono falliti che rifanno un'altra startup”.
Il secondo è la mancanza di una cultura dell'exit. Il ciclo virtuoso dell'innovazione si completa quando un fondatore vende la sua azienda, realizzando un profitto per sé e per gli investitori. Questo non solo libera capitali, ma, cosa ancora più importante, rimette in circolo un patrimonio inestimabile di esperienza e credibilità. In Italia, le exit sono ancora troppo rare e i founder tendono a rimanere alla guida delle loro creature per un tempo indefinito, rallentando l'intero ecosistema e impedendo la nascita di quel circolo virtuoso di fallimento, successo e reinvestimento che è il vero motore dell'innovazione.
Eppure si può fare, l’unicorno nato in provincia

Sono poche, pochissime, ma le storie di successo ci sono anche in Italia. Anche da noi può succedere di fondare “un’aziendina” e trovarsi tra le mani un gioiello. È successo a Enrico Giacomelli, fondatore di Namirial: la sua è la storia di un unicorno nato in provincia, un'azienda che ha raggiunto una valutazione superiore al miliardo di euro partendo da Senigallia, un luogo che, come ha scherzato lui stesso dal palco, “non è la Silicon Valley, ma di sicuro il cibo è migliore”.
La sua testimonianza è una lezione di pragmatismo e visione, un potente antidoto alla rassegnazione. Namirial è nata con un capitale iniziale quasi simbolico: “il nostro primo investimento è stato di 5 milioni di lire, circa 2.500 euro”. Un punto di partenza che rende la sua traiettoria ancora più impressionante. L'azienda ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento, un requisito fondamentale per sopravvivere e prosperare nel mondo tecnologico. “Nel primo anno vendevamo carta, dati su carta, e ora vendiamo sistemi per diventare paperless”. Una trasformazione radicale che mostra come la vera innovazione non sia in un prodotto, ma nella capacità di evolvere.
Ma il passaggio più potente del suo racconto, una vera e propria lezione per qualsiasi imprenditore, ha riguardato il momento cruciale dell'incontro con il mondo della finanza e dei fondi di private equity.
“Quando un imprenditore incontra i private equity, i banchieri, nella sua mente pensa: ‘Okay, adesso cambio campionato’. Ma è completamente sbagliato. Devi cambiare sport. Ed è difficile per un imprenditore cambiare mentalità”.
È una delle metafore più lucide e potenti che ho sentito in tema di imprenditoria innovativa. Non si tratta solo di scalare, di passare dalla Serie B alla Serie A; si tratta di imparare regole, ritmi e obiettivi completamente nuovi. È una trasformazione che richiede un'umiltà e una flessibilità mentale che pochi possiedono, e che spesso rappresenta il vero scoglio su cui si infrangono i sogni di crescita di molti founder.
Infine, Giacomelli ha toccato un punto che eleva la sua storia da semplice successo economico a modello sociale. Il suo orgoglio più grande non risiede solo nel traguardo finanziario personale. “Sono davvero fiero non solo dei miei soldi, ma anche perché ho aiutato un sacco di persone, manager, semplici programmatori... Alcuni manager sono diventati milionari, ma anche alcuni programmatori, con questa exit, possono comprarsi casa. E questo mi rende davvero orgoglioso”.
Dunque, è possibile creare ricchezza diffusa. L'obiettivo di un'impresa può e deve andare oltre il profitto del singolo; solo così si può dimostrare davvero che un'altra Italia, un altro modo di fare impresa, non solo è possibile, ma esiste già.
La potenza del networking

Con la pandemia abbiamo tutti iniziato a fare incontri digitali, e per un po’ è sembrato che da quell’emergenza sarebbe nata una nuova normalità. Ma non è andata così, e gli eventi fisici, gli incontri di persona, sono tornati alla ribalta con più forza di prima.
Occasioni come The Bologna Gathering dimostrano con una forza quasi brutale il valore insostituibile delle relazioni dal vivo. L'aria che si respirava non era solo di ottimismo, ma di urgenza: l'urgenza di incontrarsi, di parlarsi, di creare quella fiducia che nessuno schermo è in grado di replicare. Questa non è stata una conseguenza casuale, ma il risultato di una visione precisa, quella degli organizzatori Nicklas Pavoncelli, Stefano Onofri e Alessandro Cillario, che hanno concepito l'evento proprio come un acceleratore di connessioni di alta qualità.
I numeri, da soli, raccontano una storia potente. Nella sola giornata di giovedì 18 settembre, sono stati generati oltre 1000 incontri one-to-one in meno di otto ore. A dialogare non erano persone qualunque, ma 300 decision maker selezionati: founder, investitori e top manager con un portafoglio di capitali gestiti che supera i 39 miliardi di euro. In questo contesto, ogni stretta di mano e ogni conversazione informale diventava una potenziale opportunità. Non solo accordi, ma anche comprensione: a volte, basta una chiacchierata informale con una persona competente come Andrea Cosentino per illuminare i complessi meccanismi della finanza dei VC e trasformare un dubbio in una strategia. È questa la vera scintilla che accende i nuovi progetti.
Ma il successo del networking al Gathering non è solo una questione di quantità, bensì di qualità. Come ha sottolineato Nicola Mei, attento osservatore dell'ecosistema, “rispetto ad altri eventi che sono aperti, che sono più mainstream, [...] mancava una cosa di questo tipo, dove in realtà le persone sono più selezionate e quindi ti trovi un certo livello”. È proprio questa selezione all'ingresso che trasforma un semplice incontro in un'occasione ad alto potenziale, eliminando il rumore di fondo e permettendo ai partecipanti di concentrarsi su dialoghi significativi.
Questo fermento non avviene nel vuoto, ma si appoggia su un territorio che sta consolidando il suo ruolo di "Data Valley" europea. Ne è un esempio BI-REX, uno dei partner chiave dell'evento. Visitando questo Competence Center nazionale, specializzato in Big Data e tecnologie per l'Industria 4.0, si tocca con mano l'infrastruttura dell'innovazione: un ponte tra ricerca e impresa, dotato di stampanti 3D avanzatissime, robotica e linee pilota a disposizione delle aziende.
The Bologna Gathering ha riaffermato una verità fondamentale: il capitale e la tecnologia sono indispensabili, ma il vero motore del cambiamento è la fiducia che si crea tra le persone. L'evento è stato la piattaforma che ha permesso a centinaia di professionisti di guardarsi negli occhi e riconoscersi come parte di quella stessa Italia che non si arrende, ma che costruisce il futuro, una conversazione alla volta.
Fotografie dell'Italia che innova (e che a volte fugge)

Passando da un’ottica grandangolare a uno zoom si possono scattare ritratti eccellenti, altrettanto utili per raccontare questa storia. Emergono così vicende individuali a restituire la fotografia più fedele di un Paese. E quella dell'Italia che innova è un'immagine fatta di luci abbaglianti e ombre profonde, di determinazione e di frustrazione. Ascoltando le voci dei protagonisti, emergono due grandi criticità che frenano il potenziale del nostro ecosistema.
La prima è una diffusa mancanza di educazione al rischio, un problema che affligge sia chi investe, sia chi fa impresa. Come ha sottolineato lucidamente Nicola Mei, “mancano ancora le basi diffuse”. Da un lato, ci sono investitori che, pur operando nel venture capital, ragionano con la mentalità della finanza tradizionale. “Vengono da un altro mondo di investimenti, molto più sicuri. Non puoi fare un pre-seed e chiedere le metriche; se ci sono le metriche, non è un pre-seed”. È la ricerca ossessiva di garanzie in un campo che per sua natura è incerto, un approccio che sterilizza l'innovazione sul nascere. Dall'altro lato, molti startupper, pur partendo con buone intenzioni, finiscono per ricadere nel modello della PMI, cercando “la cosa consolidata, piccola, che alla fine va ma non fa niente di che”, invece di puntare a una crescita esplosiva.
La seconda fotografia è la storia di una fuga, un racconto che fa rabbia perché mostra il talento che siamo costretti a perdere a causa di una burocrazia della fiducia che non sa riconoscere il valore. È la storia di Antonella Rubicco e della sua azienda, A3Cube: l’azienda prova a sviluppare un “supercomputer con componenti da supermercato”, qualcosa che renda più accessibile il calcolo ad alta potenza. Dopo anni di ricerca e sviluppo in Italia, provano a cercare investitori. La due diligence tecnica viene affidata a un ingegnere di un prestigioso istituto torinese.
Il responso è surreale. “Mi chiama e mi dice: ‘Signora, mi spiace, ma la vostra tecnologia non potrà mai funzionare’”, racconta Antonella. “Io gli chiedo: ‘Ingegnere, è sicuro di quello che sta dicendo?’. E lui: ‘Certo, non ci sbagliamo’. ‘Perfetto, gli ho risposto. Lo spieghi al mio cliente ad Austin, che sono quattro mesi che la usa per un progetto militare e mi dice che è una manna dal cielo”.
A gennaio 2012, erano a San Francisco a costituire l'azienda. Una valutazione sbagliata e superficiale li ha spinti a cercare altrove quella fiducia che in patria gli era stata negata. La differenza culturale che hanno trovato è abissale. In Italia, la prima domanda è: “ma quant'è che fatturi? Ma chi è che te l'ha validato?”. Negli Stati Uniti, nessuno gli ha mai chiesto il fatturato. La domanda era una sola: “avete la soluzione? Sì? Va bene, basta”.
Questa storia non parla solo di una "fuga di cervelli". Parla di una "fuga di fiducia". Mostra come la mancanza di una cultura del rischio porti a non riconoscere l'innovazione quando ce l'abbiamo di fronte. Le voci dal fronte, in fondo, ci dicono questo: il potenziale è immenso, ma per liberarlo dobbiamo imparare a dare fiducia prima del fatturato.
L'Italia che che si piange addosso e quella che guarda avanti

Sono tornato da Bologna con una consapevolezza diversa, quasi un'epifania. L’Italia migliore che ho incontrato non è un'utopia, non è un'eccezione isolata, è qualcosa che esiste e che va avanti fregandosene di chi dice non si può fare. Molti di loro falliranno - inutile negarlo, va sempre così - ma quelli che ce la faranno potranno segnare la strada. È l'Italia che non si arrende, che rifiuta la comoda narrazione del declino e che, messa di fronte alle proprie mancanze, non si lamenta ma si rimbocca le maniche.
Questa Italia ha il volto e la voce delle persone che ho incontrato. Ha la tenacia di Enrico Giacomelli, che dimostra che si può costruire un'azienda globale partendo da una piccola città delle Marche. Ha la lucidità di analisti come Andrea Bellini e Nicola Mei, e la competenza tecnica di esperti come Alex Roggero e Marco Ramilli, che sezionano i limiti e le opportunità del sistema non con rassegnazione, ma con lo spirito critico di chi vuole trovare una cura, non solo lamentare la malattia.
E, soprattutto, ha la forza di chi trasforma una storia di fuga in una storia di un ritorno. La testimonianza di Antonella Rubicco e del suo co-fondatore, Emilio Billi, è il simbolo più potente di questo cambiamento. Dopo essere stati costretti a cercare fiducia e capitali negli Stati Uniti a causa di una burocrazia della valutazione cieca e sorda, ora stanno tornando. Billi ha costituito la sua nuova startup innovativa in Italia, convinto che questo sia il momento giusto. Come mi ha detto Antonella, “lui è convinto che comunque in Europa si possa creare l'alternativa”. Non c'è segnale di speranza più forte di un talento che, dopo aver vinto altrove, sceglie di tornare a casa per costruire qui.
L'evento di Bologna, con la sua energia e la sua capacità di attrarre nomi “pesanti” come BlackRock, non è la soluzione a tutti i problemi. Ma è qualcosa di più importante: non è la soluzione, è la scintilla. Ha dimostrato che le competenze, i capitali e la determinazione esistono e sono pronti a collaborare. Ha reso visibile a sé stessa una comunità che fino a ieri agiva in ordine sparso.
L'Italia che ho visto non aspetta che il sistema cambi dall'alto. Ha iniziato a cambiarlo da sé, dal basso, una conversazione alla volta, una stretta di mano alla volta. Ed è questa la sensazione, potente e contagiosa, che mi porto via da Bologna.






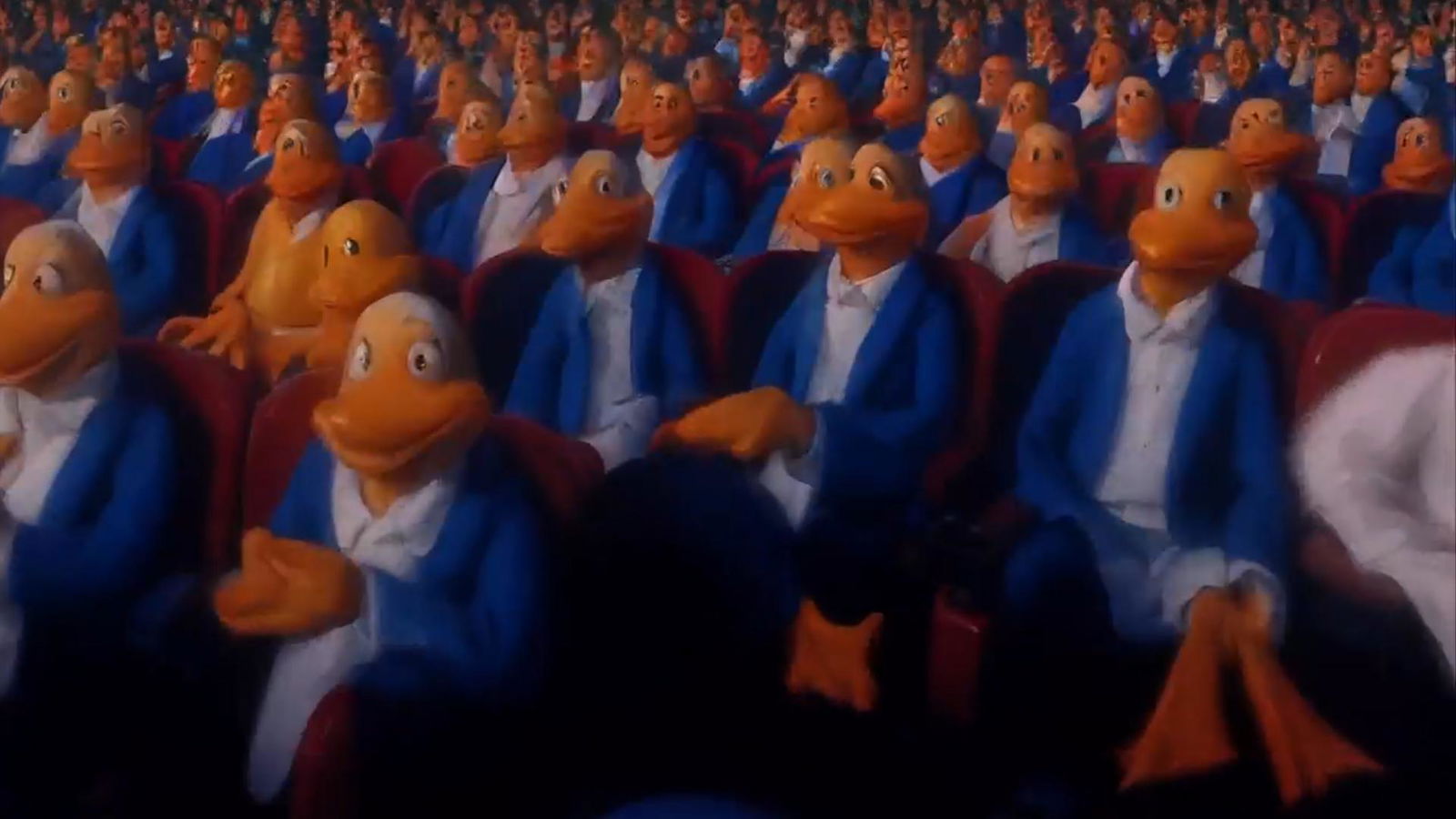
.jpg)


