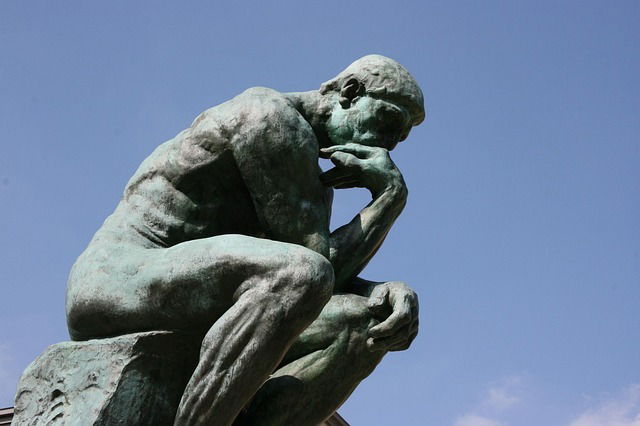Sono sempre di più le persone preoccupate dal fatto che l'uso dell'AI inneschi un declino cognitivo, di fatto portando a un graduale ma inevitabile instupidimento del genere umano. Una minaccia molto diversa rispetto al rischio esistenziale di cui si parlava qualche anno fa, ma da prendere altrettanto seriamente.
Gli insegnanti sono tra i primi a lanciare l'allarme, osservando nei loro studenti i segni di quello che in gergo viene chiamato "de-skilling", un termine poco elegante ma tristemente appropriato.
In verità non è affatto chiarto che l'uso dell'AI stia impattando sulle competenze, e bisogna anche sottolineare che perdere competenze non equivale a perdere capacità cognitivie. In teora una persona può essere intelligentissima senza saper fare nulla, nemmeno leggere e scrivere a livello elementare; questo è un concetto molto importante da comprendere, perché l'intelligenza è la conoscenza sono due cose separate negli esseri umani. Mentre negli LLM le cose funzionano diversamente.
Il discorso poi non è affatto nuovo, ma ha anzi radici antiche. Nel Fedro di Platone, Socrate racconta il mito del diizio Thot che offre al re Thamus il dono della scrittura, spacciandola come "ricetta per la memoria e la saggezza". Ma il sovrano rifiuta con una profezia inquietante: la scrittura genererà oblio, permettendo agli uomini di sostituire la fatica della memoria con segni su papiro, scambiando l'apparenza della comprensione per la comprensione stessa. L'ironia della storia è che conosciamo questo episodio proprio perché Platone lo mise per iscritto, eppure i critici della scrittura non avevano del tutto torto.
Nelle culture orali, i cantori epici custodivano interi poemi nella mente, i griot africani potevano recitare genealogie di secoli senza esitazioni. La scrittura rese superflua questa capacità, ma spalancò territori mentali inediti: il commento testuale, la giurisprudenza, la storia affidabile, la scienza moderna. Come osservò lo studioso Walter J. Ong, la scrittura è una tecnologia che ristruttura il pensiero. Questo schema si è ripetuto innumerevoli volte: i marinai che adottarono il sestante abbandonarono l'antica capacità di leggere le stelle, poi la navigazione satellitare rese obsoleto anche il sestante stesso.
Insomma, tutte le volte che abbiamo inventato qualcosa per aiutarci nel ragionare e nell'agire, ci siamo preooccupati e spaventati. Abbiamo sempre pensato che la nuova invenzione ci avrebbe rimbabito, ma poi è successo l'esatto contrario. Affermare che con l'AI la storia sarà diversa oppure che si ripeterà, tuttavia, è difficile.
Negli anni Ottanta, la psicologa sociale Shoshana Zuboff trascorse mesi nelle cartiere del sud degli Stati Uniti mentre passavano dal controllo manuale a quello computerizzato. Gli operai che un tempo giudicavano la polpa di cellulosa al tatto si ritrovarono in stanze climatizzate a fissare numeri su schermi, le loro competenze improvvisamente prive di valore. "Svolgere il mio lavoro attraverso il computer è diverso", confidò uno di loro a Zuboff. "È come cavalcare un grande cavallo potente, ma qualcuno seduto dietro di te tiene le redini." Il nuovo sistema era più veloce, pulito e sicuro, ma aveva prosciugato il lavoro del suo significato più profondo.
Una trasformazione simile colpì un panificio di Boston, documentata dal sociologo Richard Sennett. Negli anni Settanta lavoravano lì artigiani greci che usavano naso e occhi per capire quando il pane era pronto, orgogliosi della loro maestria. Vent'anni dopo, i loro successori interagivano con uno schermo tattile su un controller simile a un tablet. Il pane era diventato un'icona digitale, il suo colore dedotto dai dati, la varietà scelta da un menu elettronico. L'assottigliarsi delle competenze aveva portato con sé un assottigliarsi dell'identità stessa. Una lavoratrice disse a Sennett, mezzo scherzando: "Panificazione, calzoleria, stampa, qualsiasi cosa: ho tutte le competenze necessarie." Intendeva dire che in realtà non ne possedeva davvero nessuna, ma che avrebbe potuto fare tutto con un computer.
Anche l'ambito culturale ha vissuto un lungo distacco dalla fisicità. Nelle case borghesi dell'Europa ottocentesca, amare la musica significava suonarla. Le sinfonie raggiungevano il salotto non attraverso uno stereo ma mediante riduzioni per pianoforte: quattro mani, una tastiera, la Prima Sinfonia di Brahms evocata come meglio la famiglia riusciva. Richiedeva abilità tecnica, lettura dello spartito, capacità di evocare un'orchestra con le dita. Poi arrivò il grammofono e i pianoforti da salotto cominciarono ad accumulare polvere. I vantaggi erano evidenti: si poteva convocare l'orchestra vera nel proprio soggiorno, espandere l'ascolto dalle frivolezze da salotto a Debussy, Strauss, Sibelius. L'appassionato moderno era forse meno esecutore ma, in un certo senso, più ascoltatore. Eppure l'ampiezza era arrivata a scapito della profondità.
Il filosofo Hilary Putnam osservò che poteva usare la parola "olmo" anche se non sapeva distinguere un olmo da un faggio. Il riferimento è sociale: si può parlare di olmi perché altri nella comunità linguistica possono identificarli. Come disse lo scrittore Leonard Read in un celebre saggio, nessuno sa davvero come si fabbrica una matita: servirebbero le competenze di forestali, segherie, minatori, chimici, laccatori. Persino la maestria scientifica oggi significa sapere sempre più su sempre meno. Quando Andrew Wiles dimostrò l'ultimo teorema di Fermat non riderivò personalmente ogni lemma; assemblò risultati che si fidava fossero corretti ma non aveva riprodotto personalmente.
Arrivando ai giorni nostri, i modelli linguistici di grandi dimensioni sfumano la distinzione tra informazione e competenza, tra "sapere che" e "sapere come". In un certo senso sono statici: una matrice congelata di parametri scaricabile su un laptop. In un altro sono dinamici, generando risposte al volo. Fanno ciò di cui Socrate lamentava l'incapacità della scrittura: rispondono a domande, si adattano all'interlocutore, sostengono una conversazione. Non era difficile immaginare Google come estensione della memoria; un modello linguistico avanzato sembra a molti più simile a un sostituto della mente stessa.
Sicuramente esiste poi il problema della pratica: certe abilità e certe competenze, se non le usi costantemente rischi di perderle
Uno studio recente su medici che eseguivano colonoscopie ha rivelato che dopo tre mesi di utilizzo di un sistema IA per segnalare i polipi, diventavano meno abili nel rilevarli senza aiuto. Tuttavia, quando un altro studio ha aggregato dati da 24.000 pazienti, è emerso un quadro più incoraggiante: l'assistenza dell'IA aumentava i tassi complessivi di rilevamento del 20 percento circa. Se la collaborazione salva vite, i gastroenterologi sarebbero irresponsabili a insistere nel volare in solitaria per orgoglio.
In altri ambiti, quanto più esperta è la persona, tanto più efficace risulta la collaborazione. Uno studio ha mostrato che gli esseri umani superavano i bot nell'identificare immagini di due tipi di scriccioli e picchi. Ma nel rilevare recensioni false di hotel, vincevano i bot. Quando però i ricercatori accoppiavano persone e bot, l'esito dipendeva dal compito. Dove l'intuizione umana era debole, come con le recensioni, le persone mettevano troppo in discussione il bot e trascinavano verso il basso i risultati. Dove le loro intuizioni erano solide, sembravano lavorare in concerto con la macchina. Con gli uccelli, il duo umano-bot batteva entrambi singolarmente.
Un esperimento controllato in un grande corso di fisica ad Harvard ha prodotto risultati sorprendenti. Metà degli studenti apprendeva due lezioni nel modo tradizionale "migliore prassi": una classe attiva e pratica guidata da un istruttore esperto. L'altra metà usava un tutor IA personalizzato. Poi si invertivano i ruoli. In entrambi i casi, gli studenti seguiti dall'IA ottenevano risultati superiori, e non di poco.
Non solo imparavano di più, lavoravano anche più velocemente e riferivano di sentirsi più motivati e coinvolti. Il sistema era stato progettato per comportarsi come un buon allenatore: mostrando come suddividere problemi grandi in più piccoli, offrendo suggerimenti invece di sputare risposte, dosando feedback e adattandosi al ritmo di ciascuno studente.
Questo ricorda il vecchio sistema tutorial, potente proprio per l'attenzione individuale che garantiva. I modelli linguistici promettono di produrre in massa quel tipo di attenzione: non il cardigan del professore oxfordiano, non la pipa brunita, ma la pressione costante e reattiva che trasforma la confusione in competenza. Le macchine non sostituiranno i mentori, ma possono gestire le parti di routine del tutoraggio, liberando l'insegnante per concentrarsi su ciò che conta davvero: spiegare le grandi idee, spingere verso l'eleganza, parlare di carriere, accorgersi quando uno studente è sull'orlo del burnout.
Il de-skilling erosivo rimane una problema che non può essere ignorata: la costante atrofia delle capacità cognitive o percettive di base attraverso l'eccessivo affidamento agli strumenti, senza guadagno compensativo. Tali deficit possono esaurire le riserve di un sistema, quelle abilità di cui raramente si ha bisogno ma che bisogna possedere quando qualcosa va storto. Pensate al pilota di linea che trascorre migliaia di ore supervisionando il pilota automatico ma si blocca quando il sistema si guasta. Alcuni teorici dell'automazione distinguono tra "umani nel ciclo", che rimangono attivamente coinvolti, e "umani sul ciclo", che semplicemente approvano dopo che una macchina ha fatto il lavoro.
La prospettiva più inquietante è quello che potremmo chiamare de-skilling costitutivo: l'erosione delle capacità che ci rendono umani in primo luogo. Giudizio, immaginazione, empatia, il senso del significato e della proporzione non sono riserve di emergenza ma pratiche quotidiane.
Se dovessimo diventare, nella temibile formulazione di Jean-Paul Sartre, "la macchina della macchina", la perdita si manifesterebbe nella trama della vita ordinaria. Ciò che potrebbe svanire è la conoscenza tacita e incarnata che sostiene il nostro discernimento quotidiano: conversazioni più superficiali, un appetito ridotto per l'ambiguità, una deriva verso formulazioni automatiche dove un tempo avremmo cercato la parola giusta.
La maggior parte delle forme di de-skilling, se si guarda nel lungo periodo, sono benigne. Alcune competenze sono diventate obsolete perché è scomparsa anche l'infrastruttura che le sosteneva. La telegrafia richiedeva padronanza dei punti e delle linee; il montaggio su pellicola, la precisione della matita grassa e del nastro di giunzione. Quando scomparvero le linee telegrafiche e le bobine di celluloide, scomparvero anche i mestieri che supportavano. Un altro tipo rappresenta l'eliminazione della fatica inutile: pochi di noi piangono la perdita del bucato a mano o delle divisioni lunghe su carta.
Più radicalmente, le nuove tecnologie possono evocare nuove competenze dal nulla. Prima del microscopio esistevano naturalisti ma non microscopisti: Robert Hooke e Antonie van Leeuwenhoek dovettero inventare la pratica di vedere e interpretare l'invisibile. La cinematografia non prese semplicemente in prestito dal teatro ma fece nascere direttori della fotografia e montatori i cui mestieri non avevano precedenti reali. Lavorare con i modelli linguistici, insistono i miei colleghi più giovani, sta già insegnando un nuovo tipo di artigianato: sollecitare, sondare, cogliere pregiudizi e allucinazioni, imparare a pensare in tandem con la macchina.
La parte difficile è decidere, senza nostalgia né inerzia, quali competenze conservare e quali scartare. Nessuno ama vedere abilità conquistate con fatica gettate via come obsolete, ed è per questo che dobbiamo resistere al richiamo sentimentale. L'alfabetizzazione ha affievolito le imprese di memoria ma ha creato nuovi poteri di analisi. Le calcolatrici hanno dato un colpo all'aritmetica mentale ma hanno permesso a più persone di "fare i conti". Il suono registrato ha indebolito la competenza musicale quotidiana ma ha cambiato il nostro modo di ascoltare. E oggi? Di certo abbiamo voce in capitolo sul fatto che i modelli linguistici espandano o restringano le nostre menti. La domanda più pressante è come mantenere intatta la nostra agency, come rimanere gli autori dei sistemi che ora sono pronti ad assumere così tanto del nostro pensiero.