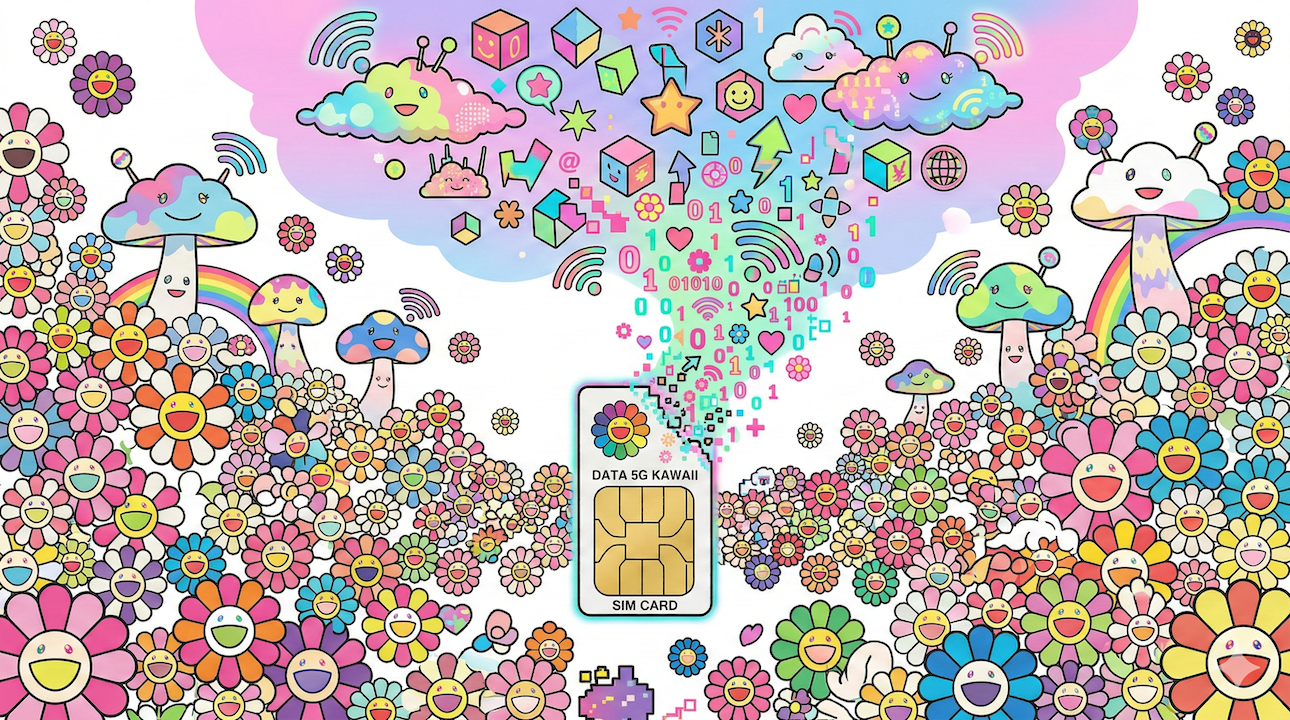L'accelerazione dell'intelligenza artificiale riapre con urgenza il dibattito sul reddito di base universale (UBI). Miles Brundage, ex ricercatore di OpenAI, lancia una provocazione: 10.000 dollari al mese per tutti. Sembra una boutade, ma ci dà la misura della dirompente ricchezza che l'automazione promette di generare. Dobbiamo quindi sforzarci di esaminare la questione in modo pragmatico, superando la dicotomia tra "lavorare" e "non fare nulla". È fondamentale valutare l'UBI come strumento per contrastare una disoccupazione tecnologica che si preannuncia strutturale, tenendo conto dei risultati degli esperimenti globali che ne smentiscono i pregiudizi più comuni, come il presunto disincentivo all'iniziativa personale.
Le due sfide colossali che ne ostacolano l'implementazione sono il finanziamento — ipotizzabile attraverso una tassazione mirata sui profitti da automazione, un meccanismo complesso da definire su scala globale — e la trasformazione culturale necessaria per ridefinire il ruolo dell'individuo in una società non più fondata sul lavoro.
Senza un intervento politico e sociale coraggioso, il rischio non è la pigrizia di massa, bensì l'avvento di una società stagnante e stratificata, dove un'élite ristretta detiene il monopolio sulla tecnologia e sulla ricchezza, mentre la maggioranza vive in una condizione di dipendenza dorata. Il bivio tra un futuro di nuove opportunità ("Star Trek") e uno di disuguaglianze abissali ("Elysium") è già presente: la direzione che prenderemo dipenderà dalle scelte che sapremo compiere oggi.
-------------
Diecimila dollari al mese, senza condizioni, per tutti. Non è la trama di un romanzo di fantascienza, ma una proposta concreta emersa da chi l'intelligenza artificiale la costruisce ogni giorno. Miles Brundage, ex ricercatore di OpenAI, ha recentemente sostenuto che una cifra simile non solo sarà economicamente sostenibile in pochi anni grazie alla crescita esponenziale abilitata dall'IA, ma è anche la scala su cui dovremmo iniziare a ragionare. Questa affermazione, per quanto provocatoria, funge da termometro di un cambiamento epocale. L'idea di un reddito di base universale (UBI) non è più un'utopia per accademici, ma una potenziale necessità strutturale di fronte a una tecnologia che promette di automatizzare non solo le braccia, ma anche le menti. Sempre più persone parlano di UBI, e sempre meno lo etichettano come una cosa impossibile.
La questione, infatti, ha smesso di essere puramente teorica. Se l'IA può generare un valore economico senza precedenti con un apporto di lavoro umano sempre minore, a chi andrà quella ricchezza? Come si sosterrà una società in cui ampie fasce della popolazione potrebbero non avere più un lavoro da svolgere, non per scelta o per crisi ciclica, ma per obsolescenza strutturale delle loro competenze? Il dibattito sull'UBI diventa così il campo di battaglia su cui si deciderà il modello sociale del futuro, una discussione che riguarda imprenditori, economisti, lavoratori e cittadini, perché le sue implicazioni ridisegnano le fondamenta stesse del nostro patto sociale.
La produttività dell'IA: un'onda anomala sul mercato del lavoro
Ogni grande rivoluzione tecnologica ha portato con sé timori di disoccupazione di massa, puntualmente smentiti dalla creazione di nuove professioni. L'ondata dell'intelligenza artificiale, tuttavia, presenta caratteristiche che la rendono profondamente diversa. La sua velocità di adozione, la sua scalabilità globale istantanea e, soprattutto, la sua “natura cognitiva” le permettono di impattare non solo i lavori ripetitivi, ma anche quelli creativi e intellettuali che consideravamo un'esclusiva umana. Stiamo assistendo a un'automazione del pensiero, non solo del gesto.
È doveroso soffermarsi un attimo per affermare che in buona parte queste capacità “magiche” sono state esagerate, e che oggi come oggi i sistemi AI non sono davvero in grado di fare miracoli. Tuttavia la loro evoluzione non accenna a fermarsi, e il futuro dove le macchine fanno tutto sembra ancora più che possibile. Prepararsi sembra un gesto di pura razionalità.
Di fronte a questo scenario, la tradizionale risposta del "reskilling" rischia di rivelarsi una soluzione insufficiente. Riqualificare un lavoratore per una nuova mansione ha senso se il ciclo di obsolescenza delle competenze è misurabile in decenni. Oggi, invece, la velocità con cui l'IA apprende e si evolve potrebbe rendere obsoleto un nuovo set di abilità nel giro di pochi anni. Si innescherebbe un inseguimento senza fine, in cui la formazione umana fatica a tenere il passo con l'apprendimento delle macchine, creando una forbice sempre più ampia tra chi riesce a cavalcare l'onda e chi ne viene travolto.
Il problema non è più confinato a specifici settori. L'IA generativa sta già mostrando le sue capacità nella scrittura di codice, nella creazione di contenuti di marketing, nell'analisi legale e persino nella diagnostica medica. Oggi le macchine fanno ancora molti errori e sono necessari umani competenti che le guidino e le correggano; ma il bisogno di manodopera umana si sta già riducendo, e questa tendenza non potrà che accelerare in futuro. La transizione da un'economia di servizi a una basata sull'automazione cognitiva potrebbe lasciare senza alternative non solo gli operai, ma anche i colletti bianchi. Nessun settore è immune a questa trasformazione, che erode le fondamenta stesse del mercato del lavoro come lo abbiamo conosciuto.
L'acquisizione della ricchezza non è più la forza motrice nelle nostre vite. Noi lavoriamo per migliorare noi stessi e il resto dell'umanità. - Jean Luc Picard
Si profila quindi una crisi occupazionale di natura diversa, non ciclica ma strutturale e potenzialmente permanente. Se un numero crescente di compiti può essere svolto in modo più efficiente ed economico da un algoritmo, il valore del lavoro umano tradizionale è destinato a diminuire. E lo stesso varrà per lavori manuali, mano a mano che si diffondono robot sempre più evoluti e e sempre meno costosi.
Il meccanismo "lavoro in cambio di reddito" potrebbe non essere più in grado di garantire sostentamento e dignità a tutti - anzi già oggi non mancano esempi di “lavoratori poveri”, anche in Italia. È un problema sistemico che richiede soluzioni altrettanto sistemiche.
Reddito di base universale: da esperimento a polizza assicurativa per il futuro
Il reddito di base universale emerge come una delle proposte più discusse e radicali - forse l’unica di cui in effetti vale la pena discutere. È fondamentale definirlo con precisione per evitare equivoci: si tratta di un'erogazione monetaria periodica, fornita a tutti i cittadini individualmente, senza alcuna condizione o richiesta di contropartita. Non è un sussidio di disoccupazione, non è legato alla ricerca di un impiego, non dipende dal reddito. È un diritto universale, pensato per fornire una rete di sicurezza fondamentale in un mondo economicamente incerto.
L'obiezione più comune e istintiva è di natura culturale: dare soldi "gratis" alle persone le renderà pigre, disincentivando il lavoro, lo studio e l'imprenditorialità. Si teme una società di individui passivi e demotivati. Tuttavia, i dati raccolti da decine di esperimenti pilota condotti in tutto il mondo, dalla Finlandia al Kenya, dalla California al Canada, raccontano una storia molto diversa. I risultati, pur con le dovute differenze contestuali, mostrano un quadro sorprendentemente coerente.
Le persone che ricevono un reddito di base non smettono di cercare opportunità. Al contrario, lo usano per migliorare la propria condizione: investono in formazione, avviano piccole attività imprenditoriali, si prendono cura della propria salute e di quella dei familiari. In molti casi, la sicurezza economica di base permette loro di negoziare condizioni di lavoro migliori o di lasciare impieghi precari e sfruttati per cercare percorsi più qualificanti. I dati smentiscono i pregiudizi, mostrando un aumento del benessere psicofisico, della coesione sociale e dell'iniziativa personale.
L'UBI, quindi, non va inteso come un "tetto" che limita le ambizioni, ma come un "pavimento sociale" solido su cui ogni individuo può costruire il proprio percorso di vita. In un'era di automazione, diventa una sorta di polizza assicurativa collettiva contro il rischio di irrilevanza economica. Fornisce la stabilità minima necessaria per adattarsi, sperimentare e trovare nuovi modi di contribuire alla società, anche al di fuori dei canoni del lavoro tradizionale. È una base di partenza, non un punto di arrivo.
L'elefante nella stanza: come si finanzia un'utopia?
Ammesso che l'UBI sia socialmente desiderabile, resta la domanda più complessa: come si finanzia? Erogare una somma significativa a milioni di persone richiede risorse colossali. La risposta, secondo i suoi sostenitori, risiede nella stessa forza che rende necessario il reddito di base: l'enorme surplus di ricchezza generato dall'intelligenza artificiale. L'idea non è quella di aumentare le tasse sul lavoro o sui consumi, ma di intercettare una parte del valore creato dall'automazione.
Non si tratta, come a volte si semplifica, di una "tassa sui robot", ma di un prelievo fiscale sui guadagni di produttività e sui profitti delle aziende che beneficiano maggiormente della transizione tecnologica. Se un'impresa, grazie all'IA, riesce a produrre il doppio con la metà del personale, genera un extra-profitto che oggi viene distribuito quasi interamente tra azionisti e management. L'ipotesi è di destinare una quota di quel surplus al finanziamento di un nuovo patto sociale, di cui l'UBI è il pilastro.
Le sfide per implementare un simile meccanismo sono enormi. Prima di tutto, come si misura con precisione il guadagno di produttività attribuibile specificamente all'IA? In secondo luogo, in un'economia globalizzata, come si evita che le aziende spostino le loro sedi legali in paradisi fiscali per eludere il prelievo? Qualsiasi tentativo di tassare i profitti dell'automazione richiederebbe un accordo internazionale senza precedenti, una sorta di Bretton Woods per l'era digitale.
La difficoltà è innegabile, ma l'alternativa potrebbe essere peggiore. Se la ricchezza generata dall'IA si concentra nelle mani di poche mega-corporation e dei loro azionisti, assisteremo a un'esplosione delle disuguaglianze economiche mai vista nella storia. Il finanziamento dell'UBI diventa quindi non solo una questione tecnica, ma una scelta politica fondamentale sul tipo di società che vogliamo costruire. È una sfida di governance globale.
Il bivio della civiltà: tra la distopia di Elysium e l'ideale di Star Trek
Immaginiamo per un momento che le sfide economiche e politiche vengano superate. Che tipo di società emergerebbe da un mondo con un reddito di base universale? Qui il dibattito si sposta sul piano culturale e filosofico, aprendo a due scenari opposti. Il primo, quello del "pessimismo ragionato", è una distopia che ricorda film come "Elysium": una società spaccata in due. Da una parte, un'élite globale che progetta, controlla e possiede le tecnologie, vivendo in un'enclave di ricchezza e potere. Dall'altra, una massa di persone che riceve un UBI sufficiente a garantire solo la sopravvivenza minima. È quello che succederebbe in un mondo in cui si rifiuta l’idea dei “soldi gratis” ma allo stesso tempo non c’è lavoro per tutti.
In questo scenario, l'UBI non è uno strumento di liberazione, ma di controllo sociale. Garantisce la stabilità, previene le rivolte, ma spegne l'innovazione dal basso e cristallizza le disuguaglianze.
Lo scenario più estremo vede miliardi di poveri da una parte e alcune migliaia di super ricchi dall’altra, con un sistema di macchine che fanno funzionare il sistema. La società finirebbe per bloccarsi e nessuno avrebbe più stimoli per fare di più, per creare qualcosa di innovativo. L’UBI potrebbe essere anche più alto e forse potremmo arrivare a una situazione senza povertà materiale, ma la società sarebbe probabilmente condannata alla stagnazione culturale ed economica, un deserto del potenziale umano.
L'alternativa è la visione utopica, l'ideale incarnato da società come quella di "Star Trek", dove la tecnologia ha eliminato la scarsità e il lavoro non è più una necessità per la sopravvivenza. In questo futuro, l'UBI è il catalizzatore di un nuovo Rinascimento, non il fine ma un mezzo per realizzare un obiettivo più alto. Liberati dall'ansia economica, gli individui possono dedicare il loro tempo all'arte, alla scienza, all'esplorazione, alla cura delle relazioni e della comunità. Il potenziale umano si sprigiona, non più vincolato alla produzione di valore economico.
Scarsità: la "scarsità" non si riferisce solo alla mancanza di beni materiali, ma al principio economico fondamentale per cui le risorse (cibo, energia, alloggi, opportunità) sono limitate rispetto ai bisogni umani. È questa condizione che rende necessario il lavoro per la sopravvivenza. Eliminare la scarsità, come nello scenario "Star Trek", significa che la tecnologia e l'automazione permettono di produrre un'abbondanza tale da soddisfare i bisogni essenziali di tutti a un costo marginale quasi nullo. Di conseguenza, il lavoro non è più una necessità, ma una scelta.
Questa visione richiede però un cambiamento culturale radicale. Dobbiamo superare l'equazione profondamente radicata nella nostra civiltà tra identità personale e professione lavorativa. Per secoli, alla domanda "chi sei?" abbiamo risposto con "faccio il medico, l'operaio, l'insegnante". La sfida più grande non è quindi economica, ma è imparare a definire noi stessi e il nostro valore al di fuori del lavoro. È una rivoluzione antropologica, un passo evolutivo che ci chiede di trovare un nuovo scopo collettivo.
Il dibattito sull'UBI, innescato dalla provocazione dei 10.000 dollari al mese, ci pone di fronte a questo bivio. La tecnologia sta creando le condizioni per un salto evolutivo, ma non ne garantisce l'esito positivo. L'intelligenza artificiale non è né buona né cattiva; è uno strumento di una potenza inedita che amplificherà le scelte che faremo. Ignorare la discussione o liquidarla come fantascienza significa lasciare che il futuro venga definito per inerzia, rischiando che la concentrazione di ricchezza e potere ci spinga inevitabilmente verso la distopia.
La posta in gioco non è semplicemente gestire la disoccupazione, ma decidere cosa significhi "progresso" in una civiltà che potrebbe non aver più bisogno del lavoro di tutti per prosperare. Avviare un dibattito pubblico ampio, informato e coraggioso è il primo, indispensabile passo per assicurarci che la straordinaria ricchezza promessa dall'IA diventi un'opportunità di fioritura per l'umanità intera, e non l'inizio di una nuova, profonda divisione.